Il modo con cui Pasolini, specie corsaro, si è rapportato alle scienze sociali, e in particolare all’antropologia, assumendone gli strumenti con originale curvatura non specialistica per l’acuminata lettura del suo tempo storico, costituisce l’interrogativo centrale del saggio di Luca Peloso, giovane studioso dell’opera e del pensiero di Pasolini. L’intervento è stato presentato a Perugia il 16 luglio 2015, all’interno delle giornate di studio “Rileggendo Pasolini. Il diritto dopo la scomparsa delle lucciole”(15-18 luglio) organizzate dall’Università umbra per il progetto annuale “Visioni del giuridico”. Quell’occasione, aperta ad indagini di tipo multidisciplinare, ha offerto a Peloso lo spunto anche per una rapida disamina sulla presenza della disciplina giuridica nella riflessione pasoliniana, con specifica attenzione all’espropriazione della personalità giuridica e dell’autonomia individuale che, secondo Pasolini, trasforma la moderna società neo-capitalistica in un universo concentrazionario, in diretta continuità con il sistema del Lager.
Per la concessione del suo testo, un grazie all’autore, già vincitore nel 2011 della XXVII edizione del Premio Pasolini Tesi di Laurea con il lavoro La filosofia e il suo statuto. Un dialogo tra Gramsci e Pasolini (Un. Di Padova).
«L’antropologia comincia a casa propria».
Pasolini, le scienze sociali e il problema dell’autonomia individuale nel nuovo ordine omologante
di Luca Peloso
(Università dell’Insubria, Como-Varese)
I.
“«L’antropologia comincia a casa propria» è diventata la parola d’ordine delle moderne scienze sociali”, scriveva Malinowski nel 1938, nell’introduzione a un libro diventato – almeno nella patria del suo autore – un piccolo classico (1). Il maestro polacco si riferiva al fatto che si era passati da un’epoca in cui l’etnologo, con l’intento di studiare ‘l’altro’, si dirigeva verso luoghi remoti, a una in cui gli studiosi cominciavano a utilizzare gli strumenti dell’indagine antropologica per conoscere se stessi, il proprio paese, i propri simili (2). Malinowski non poteva certo immaginare che qualche decennio dopo qualcuno avrebbe imboccato lo stesso percorso su tutt’altri presupposti e con tutt’altri fini. Pasolini infatti non si servì di alcun metodo precostituito, di alcun corpus intangibile di nozioni per diagnosticare la malattia dell’Italia incancrenita dalla ‘mutazione’: portò avanti il suo progetto – se così possiamo chiamarlo – come sempre a modo suo, all’insegna della contaminazione concettuale, del saccheggio, del calco, nonché del particolare istinto che rivendicava come parte integrante del suo mestiere (3). Molto poco scientifico, si obietterà; cosa che del resto lui stesso era pronto a riconoscere (4).
Partiamo da qui, tenendo presente le tre parole-chiave del campo d’indagine prescelto (Parole, Identità, Omologazione), per tentare di avvicinarci ad alcune cifre del lavoro pasoliniano senza dimenticare il macroargomento – il diritto – di cui il convegno vuol essere costruttivamente in funzione. Il compito è in parte facilitato, perché cercare di ragionare sul “diritto dopo la scomparsa delle lucciole” ci induce a circoscrivere l’oggetto dell’indagine agli ultimi due anni della riflessione del poeta: in sostanza, a concentrarci esclusivamente sugli Scritti corsari e le Lettere luterane, definiti giustamente “la forma più organica e compiuta del pensiero politico pasoliniano” (5), e incentrati entrambi su quella rivoluzione antropologica di cui l’articolo delle lucciole è l’icastica espressione.
Le domande da cui muoviamo sono: in che modo si configura il rapporto tra individuo e collettività, tra autenticità e massificazione, in tempi di omologazione arrembante? Che ruolo svolgono, nell’economia di tale configurazione, la lingua e quindi le parole? Come il pensiero critico pasoliniano può aprire a una riflessione che coinvolga il diritto? La pista che proponiamo per una possibile risposta tenta di tenere insieme due momenti distinti ma logicamente connessi. Il primo, in qualche modo più canonico, cerca di fornire il quadro del singolare rapporto tra Pasolini e scienze quali la linguistica, l’antropologia e la sociologia – non sul piano sistematico delle nozioni e dei dispositivi in campo volta per volta, ma sul piano delle finalità, degli obiettivi e degli effetti: cioè, in ultima analisi, dell’incisività. Dei tratti che fanno l’originalità di Pasolini, infatti, spicca la capacità di trattenere, di alcune scienze sociali, ciò che di ‘vivo’ (nel senso di vitale) possono intercettare dell’esistenza dei singoli; da cui il problema empirico, attualissimo, della conservazione dell’integrità a dispetto della disintegrazione operata dal consumismo (cultura ‘morta’ in quanto mortificante). Questione che diventa il motivo di continuità con la seconda parte, dove ci si muoverà in un territorio delicato: quello dei rapporti tra il neo-capitalismo e l’universo concentrazionario (pasolinianamente inteso). Perché è un dato che non può sfuggire, quello del passaggio continuo, in sede argomentativa, dal ‘nuovo fascismo’ al nazismo storicamente ‘realizzato’; un dato che ha poco a che vedere con Salò, il quale concerne la sua rappresentazione del potere in chiave metaforica; il parallelismo cui ci riferiamo coinvolge invece ineludibilmente la questione del diritto e della legge, nella misura in cui rinvia alle pratiche dei cittadini sin nelle azioni e nei pensieri della quotidianità comune. Siamo insomma a un livello che una volta tanto vale la pena di mettere alla prova teoricamente: che impone di setacciare eventuali corrispondenze, analogie, omologie tra una società dei consumi che è ancora più che mai la nostra e regimi oppressivi di apparentemente indubbia distanza da essa.
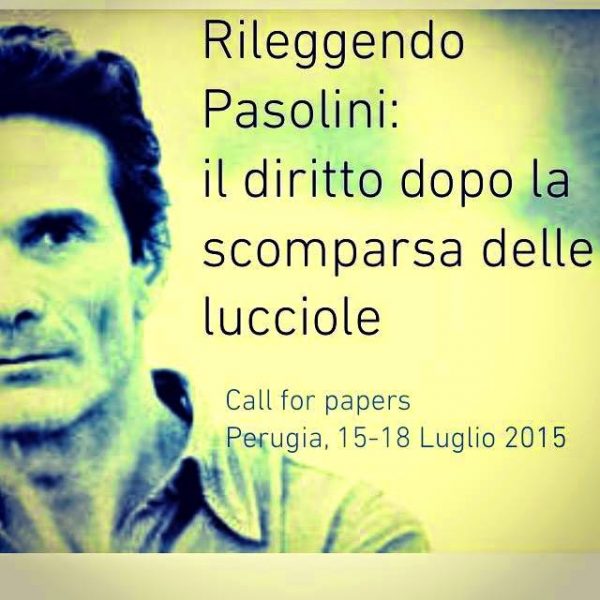
II.
In un saggio di dieci anni fa Antonio Tricomi ha offerto due chiavi interpretative per accedere all’opera di Pasolini: la performatività e il manierismo. Quelli di Pasolini, scrive Tricomi, sono gesti prima che testi, frutto di quell’inesausto sperimentalismo che è “la caratteristica saliente dell’arte di Pasolini” (6) derivante da un continuo corpo a corpo con il reale; a cui si appaia la “riproduzione e il riuso alterato e straniante di una pluralità di modelli e stili (non solo letterari)” (7), in corrispondenza diretta con un’appropriazione strumentale delle sue letture finalizzata in primis alla riscrittura (8). Di queste chiavi, preziose e anzi imprescindibili, riteniamo in questa sede la prima, a nostro avviso la più utile a mettere in rilievo sia l’anima del Pasolini corsaro e luterano, sia l’entità del suo rapporto con le scienze sociali, che certo è, almeno in parte, strumentale ma anche e soprattutto ‘gestuale’.
Nel cercare di far luce appieno su tale rapporto ci viene in aiuto un testo pubblicato quest’anno da Alberto Sobrero, che costituisce l’esame più aggiornato e sistematico sino ad ora realizzato sull’antropologia di e in Pasolini (9). Ebbene, dalla ricerca di Sobrero emergono una serie di punti fermi, che per dovere di brevità riportiamo in maniera cursoria sotto forma di elenco e mosaico di citazioni: 1) “sul terreno delle scienze sociali, le sue [di Pasolini, n.d.r.] teorie sono, a dir poco, confuse e spesso scontate” (10); 2) Pasolini non fu in senso stretto un antropologo, “ma di certo fu un potente etnografo” (11), in grado di far rientrare in un unico quadro, rendendoli in tal modo compresenti, il vicino e il lontano (12), abilità questa che emerge dai suoi squarci di “antropologia urbana” (13), pur attraverso il filtro di un’ “antropologia dell’Io” (14) che lo spinge a esplorare le scienze sociali per cercare nuove forme di vita (15); 3) il suo esperire direttamente cose e persone non sfocia affatto in una mitologia dell’esperienza sul campo e del documento in quanto tale (16); 4) all’antropologia Pasolini affida l’arduo compito di contrastare il razzismo borghese e difendere le popolazioni non ancora contaminate dal neo-capitalismo (come dall’omologazione ad esso connaturata) (17), e al contempo di testimoniare la possibilità reale della diversità in un insieme sociale (18); 5) la sua avversione per la sociologia (19).
In che modo tutto ciò si coniuga col tema della rivoluzione epocale che l’articolo delle lucciole simboleggia e sintetizza? Innanzitutto assumendo tale tema, che in quanto ‘epocale’ è anche storico, nella sua assolutezza (la tragedia, secondo Pasolini, è data dall’ irreversibilità del fenomeno: in questo senso è ‘assoluto’), rilevando come esso stesso consenta – paradossalmente, dolorosamente – di colmare lo scarto tra sfera della storia e orizzonte della vita, aspetto che secondo Roberto Esposito mette in contatto Pasolini con i caratteri profondi del pensiero italiano (20). C’è infatti, in Pasolini, un inesausto impulso a ricomporre la frattura tra poesia e politica, invitando ad esempio il lettore a concedergli di fornire “una definizione di carattere poetico-letterario” (appunto, la scomparsa delle lucciole) a un fenomeno politico (il nuovo tipo di civiltà da essa ratificato) (21). È anche per questo che Pasolini definisce la sociologia “scienza borghese” (22): in essa poesia e politica, vita e storia non stanno insieme, a tutto vantaggio delle seconde sulle prime – “non gioco su due tavoli (quello della vita e quello della sociologia)” (23). L’antropologia come la intende Pasolini cerca invece di non separarle mai (24). La linguistica, in tutto questo, è una sorta di braccio armato: viene sussunta e rilanciata come disciplina ancillare (mentre la lingua funge da indicatore, se non potenzialmente da catalizzatore). Basti pensare al ruolo strumentale (nel senso proprio di arma, strumento di difesa dall’aggressione di una realtà degradata) che svolge tanto nel Discorso dei capelli (25) quanto in Analisi linguistica di uno slogan (26), e in che misura sia la chiave per accedere ai codici della comunicazione e dell’espressione (27), dove il linguaggio non verbale è tanto acutamente analizzato proprio in quanto scaturisce da una grande consapevolezza dei fatti linguistici (sia in quanto ogni poeta/scrittore è un artigiano della parola, sia nella misura in cui Pasolini in particolare è un ‘fuoriclasse’ – autodidatta, dilettante, ergo entusiasta – della linguistica). Col termine indicatore ci riferiamo viceversa al fatto che la lingua per Pasolini incarna – tra le altre cose – un modello di comportamento che risente della (e risulta dalla) mutazione antropologica (28), ma allo stesso tempo non potrebbe essere riconosciuto se la linguistica non esistesse. Da questo punto di vista, al di là della disinvoltura con cui Pasolini manipola e rielabora le opposizioni saussuriane (29), egli resta, in senso ampio, saussuriano (per l’appunto): il suo sguardo antropologico, infatti, cos’altro non è se non una (personale, certo, e indisciplinata) declinazione della semiologia intesa come “scienza che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale” (30) , scienza di cui la linguistica è parte? Ma è anche gramsciano prima che ‘marxiano’ – nel senso che il suo marxismo paga il suo debito, su questo versante, più a Gramsci che a Marx (31). Ribadendo la sua filiazione gramsciana (32), oltre che ritenere l’influsso dell’intellettuale sardo più decisivo di altri (come ad esempio De Martino (33)), s’intende rimarcare il suo carattere non ortodosso: a testimonianza di questo sta un inciso, proprio nell’articolo delle lucciole, a proposito del vuoto di potere seguito alla mutazione: “come sempre (cfr. Gramsci) solo nella lingua si sono avuti dei sintomi” (34), rimando ineludibile alla concezione presente nei Quaderni del carcere secondo cui “ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la quistione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi” (35). Ha perfettamente ragione, dunque, Kate Crehan laddove osserva che “l’insistenza di Gramsci sulla cultura come impegno critico individuale […] è molto diversa dall’attenzione focalizzata dall’antropologia sulle culture di fatto esistenti” (36); vale lo stesso per Pasolini, in quanto l’orizzonte per entrambi è dato dal cambiamento, dalla lotta per una nuova cultura e una società migliore (benché il mondo, e con esso il rapporto tra intellettuali e popolo, verso la metà degli anni Settanta sia inevitabilmente cambiato e ciò comporti l’esigenza di andar oltre Gramsci (37)).
Insomma, se l”antropologia è disciplina princeps tra le scienze sociali (38), la sociologia è automaticamente squalificata come borghese, ‘neutra’ e dunque complice della società dei consumi, poiché di essa il Potere può servirsi come scudo per giustificare la sua stessa esistenza; da qui l’esclusione dal campo della cultura vera e propria, che ha in sé un certo grado di civiltà e che per essere tale – in Pasolini – comporta incondizionatamente un atteggiamento critico. La linguistica figura invece perlopiù – lo abbiamo appena visto – come strumento, funzione (in termini aristotelici) di quel progetto di riforma che è la causa finale, di cui l’occhio antropologico è causa formale e la linguistica stessa, potremmo dire, ora materiale ora efficiente (a seconda dell’uso – ‘sintomale’ o strumentale – che se ne fa). Rimane da aggiungere la pedagogia, purché da intendere non come un particolare sottoinsieme delle scienze educative, quanto come specifico modo d’essere e relazionarsi, che in Pasolini assume i connotati di una vocazione, di una risposta responsabile alla chiamata dell’altro, concretizzandosi infine nel trattato Gennariello (39); oltre naturalmente a una pervasiva e rancorosa – quindi meno che mai ‘scientifica’ – sensibilità teologica, che ha indotto alcuni a parlare di “angoscia quasi mistica” (40) e altri di “divinazioni antropologiche”” (41) dovute a un’“antropologia dall’inconscio rabbioso, vendicativo” (42). È qui che entra in gioco, surrettiziamente, un’altra scienza, la psicologia, che va intesa in modo affatto particolare: Pasolini se ne serve nella misura in cui concorre a far luce su processi operanti nel profondo e tra i soggetti (Freud, Jung, Ferenczi); ma sarebbe un errore farla irrompere nel nostro discorso (il suo apporto non è decisivo né particolarmente rilevante), come pure tentare di spiegare i testi e gli strali in essi contenuti a partire da questa: “la sua realtà psicologica obliterava la realtà effettuale – dice Enzo Siciliano di Pasolini – eppure egli riusciva a cogliere il seme di molteplici responsabilità” (43); basti sapere che la psicologia in molte sue ‘accezioni’ c’è e fa capolino – talvolta consapevolmente invocata dall’autore, talaltra come spettro inconscio che presidia la scrittura – nel lavoro di questi ultimi due anni di vita, benché secondo disegni meno ponderabili rispetto alle scienze sin qui esaminate (44).
Rimangono ora da indagare le ripercussioni – per via immaginativa – nell’ambito del diritto, che non studia gli esseri umani concreti, ma ad essi (ai loro destini, alle loro abitudini, alle loro pratiche) è inestricabilmente legato in quanto regola le loro vite.

III.
Mi propongo dunque di tentare un percorso concernente la modalità con cui l’approccio non ortodosso di Pasolini verso le scienze sociali è posto al servizio dell’interpretazione della società dei consumi come ‘nuovo fascismo’, responsabile dell’avvento di una nuova umanità con inediti valori, comportamenti, corpi e coscienze.
Gli studiosi almeno su un punto concordano: Pasolini non aggiunge, sul piano delle idee, nulla di nuovo con la sua personale interpretazione della società industriale avanzata: da questo punto di vista tutto ciò che egli afferma è già presente – ben più organico e articolato – in testi come L’uomo a una dimensione o Dialettica dell’Illuminismo. Quel che colpisce in Pasolini, tuttavia (al di là del singolare connubio di poesia e politica, di cui si è detto), è la radicalità con cui, nei suoi affondi polemici, il nuovo sistema di produzione dei beni e della vita si traduce pressoché meccanicamente in sistema totalitario violento, capillare e repressivo quant’altri mai. In questo Marcuse, che pure imposta il suo discorso sulla pervasività del modello economico-politico in questione, è più cauto: per lui la società industriale avanzata ha tendenze totalitarie, non è totalitaria in sé e per sé – quantomeno l’equazione non è data per scontata. Eppure anch’egli individua una connessione con fenomeni storici – analogamente a ciò che Pasolini fa col fascismo – gettando le basi per una comparazione che non suona affatto come una semplice provocazione: “quel che comincia come l’orrore dei campi di concentramento – scrive Marcuse – si trasforma nella pratica di addestrare le persone a vivere in condizioni anormali, a condurre un’esistenza umana sottoterra ed a sorbire la dose quotidiana di alimento radioattivo” (45). Ci sarebbe un legame non esteriore, dunque, tra quel laboratorio sociale che i campi sono stati, e le nostre attuali condizioni di vita: qualcosa che là è cominciato, dunque continua. Si tratta di uno spunto che poi Marcuse lascia cadere (cui sembrano tuttavia voler dare conferma le parole di Ionesco citate nel prosieguo). Sentiamo invece che cosa diventa un simile spunto di riflessione nel Pasolini corsaro:
il fascismo […] era meno diabolico […] che il regime democratico (46);[…] è qui che si vivono i valori, non ancora espressi, della nuova cultura della società dei consumi, cioè del nuovo e più repressivo totalitarismo che si sia mai visto (47); […] si può dunque affermare che la «tolleranza» della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana […] (48).
Questo in generale. Ma il passo successivo è facilmente deducibile: Pasolini affastella i suoi corollari sulle ali di un furore crescente cui però non segue una ritrattazione; essi non possono quindi essere attenuati nella sostanza né equivocati nei contenuti:
La «caccia alle streghe» è tipica delle culture intolleranti, cioè clerico-fasciste. In un contesto repressivo, l’oggetto della «caccia alle streghe» (il «diverso») viene prima di tutto destituito di umanità, cosa che rende lecita poi la sua effettiva esclusione da ogni possibile fraternità o pietà; e, generalmente, in pratica, anticipa la sua soppressione fisica (Himmler, i Lager) (49); il trauma italiano del contatto con l’ «arcaicità» pluralistica e il livellamento industriale ha forse un solo precedente: la Germania prima di Hitler. […] In Italia sta succedendo qualcosa di simile: e con ancora maggiore violenza (50) […]; ritengo cioè che la distruzione e sostituzione di valori nella società italiana di oggi porti, anche senza carneficine e fucilazioni di massa, alla soppressione di larghe zone della società stessa (51). […] Ecco l’angoscia di un uomo della mia generazione, che ha visto la guerra, i nazisti, le SS, che ne ha subito un trauma mai totalmente vinto. Quando vedo intorno a me i giovani che stanno perdendo gli antichi valori popolari e assorbono i nuovi modelli imposti dal capitalismo, rischiando così una forma di disumanità, una forma di atroce afasia, una brutale assenza di capacità critiche, una faziosa passività, ricordo che queste erano appunto le forme tipiche delle SS; e vedo così stendersi sulle nostre città l’ombra orrenda della croce uncinata (52).
Pasolini insomma oscilla dalla convinzione – la più gridata e insistita, mai davvero abbandonata – che il ‘nuovo fascismo’ sia la peggiore forma di oppressione sociale mai esistita, che nulla ha da invidiare agli strumenti del totalitarismo nazista (la sua violenza è più subdola e profonda), al dubbio che a un vero e proprio sistema concentrazionario non si sia ancora giunti – il quale a sua volta sottende l’angoscia derivante da alcuni segnali a suo avviso inequivocabilmente diretti all’oppressione fisica, ultimo stadio possibile della violenza e, nell’accezione di sterminio, la prova della sua incommensurabilità con altri metodi. Al di là delle usuali contraddizioni pasoliniane, rimangono sia in un caso che nell’altro i riferimenti all’esperienza storica della II guerra mondiale, soprattutto in relazione al tema della diversità – che in un certo senso è la chiave e il ‘motore’ di tutte le argomentazioni di Pasolini: egli cita infatti anche i pogrom (53), mentre nelle Lettere luterane parla del ghetto come figura persistente nelle pratiche e nell’immaginario della collettività (54); in un altro caso parla esplicitamente – benché in contesto diverso – di “universo concentrazionario” (55): segno dell’assiduità con cui tali dispositivi, sia come referenti empirici (storici) sia come figure mentali (immaginifici, possibili), diventano complementi di argomentazioni altrimenti meno vigorose. Si potrebbe associare la loro presenza all’ipotesi secondo cui, in questo periodo, prevale l’urgenza, che inevitabilmente sacrifica il rigore al rumore: questa osservazione tuttavia è contraddetta dal fatto che il Lager, come immagine evocativa e termine di paragone, è una presenza costante in Pasolini sin dagli anni ’50: si veda a questo proposito uno scritto del ’58 (I campi di concentramento), in cui l’autore, in una sorta di breve reportage, ci guida da una borgata romana all’altra, da una periferia all’altra: “Ogni città italiana” – leggiamo – “anche nel Nord, ha, alla periferia, dietro gli ultimi orti, i suoi piccoli campi di concentramento per ‘miserabili’” (56), ma a Roma più di ogni altra; lo si capisce, insiste il poeta, dalla conformazione esteriore di tali insediamenti. Dopodiché passa a descriverne uno, appena costruito in seguito alla demolizione del precedente (di epoca fascista), e conclude: “nulla, in realtà, è cambiato. Anziché le misere casette a un piano, con davanti il misero cortiletto, ci sono ora palazzoni nuovi di zecca […]; ma qual è il criterio stilistico, sociologico e umano di queste nuove abitazioni? Lo stesso. Siamo sempre alla nozione di campi di concentramento” (57).
Gusto dell’iperbole? Non possiamo escluderlo: rimane il fatto che in questo frammento lo scrittore mette insieme riferimenti iconici (il campo, l’istituto penitenziario, il ghetto) che – anche senza invocare Foucault – attuano con tutta evidenza strategie oppressive di diverso tipo e natura, e che tuttavia allo stesso tempo presentano caratteristiche comuni (sono gli stessi sociologi a riconoscerlo (58)). Notiamo allora due cose: primo, a Pasolini sembra non interessare tanto l’esattezza dei concetti o delle nozioni di cui si serve, quanto la forza che essi sprigionano in qualità di immagini (59) (elemento questo che, come vedremo tra breve, si rivela decisivo nelle ripercussioni del discorso pasoliniano nell’ambito del diritto); secondo, che tali immagini o figure vanno valutate nella misura in cui raggiungono l’obbiettivo di rinviare a un certo grado di bassezza umana prossimo alla disumanizzazione (correlato ‘oggettivo’ della mutazione). Per cui, se è necessario affermare a chiare lettere che la tesi pasoliniana va nella direzione opposta a quella su cui s’imperniano libri come I sommersi e i salvati (il sistema concentrazionario nazista resta un “unicum, sia come mole sia come qualità (60)), d’altra parte c’è in Pasolini un interesse precipuo per le sopravvivenze di quel sistema nella contemporaneità – obnubilato, certo, da una sorta di continuo e reiterato monito alla prevenzione del mortifero che si confonde con l’esperienza storicamente accertata di esso. Insomma, è indubbio che Pasolini esageri, annullando le distanze laddove sussistono differenze e sfumature (61), e questo stride non poco con la dichiarazione programmatica di uno dei suoi brani corsari, dove sostiene che “non esiste razionalità senza senso comune e concretezza. Senza senso comune e concretezza la razionalità è fanatismo” (62), mentre senso comune e concretezza difficilmente dissuaderebbero la ragione dal concepire un ‘salto’ tra la società contemporanea (che pure, non c’è dubbio, manipola corpi e coscienze) e un totalitarismo come quello nazista, la cui essenza è data da quella tangibile verificazione della pretesa di dominio assoluto sull’uomo che è il sistema dei campi. Ma è pur vero che l’idea di una contemporaneità, come riproduzione su larga scala di alcuni meccanismi che hanno nel Lager il loro ricettacolo, appare non balzana persino ai più strenui sostenitori dell’incommensurabilità dello sterminio nazista (63); così come è vero che in alcuni casi il Lager viene ad essere la ‘verità’ di ciò che nel mondo viene taciuto (64).

Ora, se non ha molto senso inseguire Pasolini laddove si affanna a definire il nuovo potere come qualitativamente peggiore di ogni altro, nazismo incluso, può risultare stimolante cogliere alcuni motivi che mettono in rilievo come nella società odierna alberghino gli stessi impulsi e operino i medesimi processi attivi nei Lager, non fosse che una diversa combinazione impedisce loro di sfociare, quarant’anni fa come oggi, in quella determinata società oppressiva che nel suo grado di massima perfezione ha trovato collocazione, in Occidente, negli anni Trenta-Quaranta del Novecento (è questa la tesi di Modernità e Olocausto di Bauman (65)). Per concentrarsi – e qui l’obiettivo è davvero comune – sulla prevenzione di un loro possibile ritorno. Ecco che allora trovano giustificazione alcuni accostamenti pasoliniani apparentemente incongrui, come il seguente: “escludo che possa lecitamente parlare di strage di feti innocenti, chi non abbia altrettanto pubblicamente ed esplicitamente parlato di stragi, per esempio, di ebrei, e più ancora, di chi non parli altrettanto pubblicamente e esplicitamente delle stragi culturali e umane del nuovo potere” (66). Una frase che potrebbe apparire eccessiva anche tenendo conto del contesto in cui s’inserisce, vale a dire la polemica contro le autorità ecclesiastiche, le quali si ergono a difesa dei feti in nome della ‘Vita’ per poi disinteressarsi alle vite concrete dei singoli, portatori di culture concrete da difendere altrettanto strenuamente, o di storie di oppressione da raccogliere: potrebbe sembrare una licenza pasoliniana (magari corroborata dalla sua propensione al sincretismo), per cui si getta in un unico calderone la questione dell’aborto, l’Olocausto e la distruzione delle culture subalterne. Ma in questo caso non lo è, proprio in quanto – e qui veniamo al diritto – il denominatore comune è la vita concreta dei singoli (vita etica come facoltà di promuovere i valori distinguendo il bene dal male) e il loro costituire un gruppo (etica da ethos, costume di un popolo, in cui tensione verso il bene della comunità e pratiche antropologicamente intese – etno-logìa – s’incontrano e s’interfecondano): dove, nella fattispecie occupandoci dell’uomo moderno, la vita del singolo e il gruppo che lo contiene diventano soggetti a regolamentazioni giuridiche come individui e cittadini all’interno di uno Stato di diritto.
A quest’altezza i temi da noi fino ad ora toccati nella seconda parte si riuniscono in una sola trama, e vanno a intrecciarsi con l’ordito delle singole scienze sociali (esaminate nella prima parte) producendo un’unica tessitura tematica. È infatti Hannah Arendt a ricordarci che il primo passo compiuto dai nazisti nei Lager per depersonalizzare la vittima era spogliarlo dei suoi diritti civili (67), cui faceva seguito l’eliminazione della personalità morale (68) e l’annullamento della sua peculiare identità come differenziazione individuale (69). Possiamo dunque comprendere perché Pasolini ritenga l’aborto una questione giuridica e non morale (o meglio morale solo in seconda battuta, per ciò che riguarda la singola coscienza che vi si confronta nella pratica (70)) – e quindi sia per la sua legalizzazione nonostante lo consideri una colpa giuridica, da evitare (prima) e da rendere possibile (poi, e solo in alcuni casi) (71) –; è perché, in un contesto di disumanizzazione progressiva in cui la vita è mercificata non solo nelle persone in carne e ossa (schiavitù del consumo e sfruttamento dell’uomo sull’uomo) ma persino nella loro potenzialità d’essere (il feto), Pasolini interpreta ogni legalizzazione non cauta come una aprioristica concessione allo strapotere di quella burocrazia tecno-scientifica che storicamente è stata un tutt’uno con l’annichilimento morale dell’intero corpo sociale ad essa legato e, infine, della persona come tale nella sua irripetibile unicità. I legislatori in questo senso sono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano, pena il probabile avallo di una regressione che ha in sé il germe della negazione stessa del diritto – e quindi il primo passo verso l’annullamento totale di cui parla la Arendt. Scrive infatti Karl Jaspers che “il diritto rappresenta l’alto pensiero degli uomini che vogliono basare la loro esistenza su un’origine che, sebbene abbia bisogno della forza per essere garantita, non viene però da essa determinata” (72). Il guaio, bisogna riconoscerlo, è che Pasolini si presta effettivamente a degli equivoci: la violenza dei suoi toni lo conduce talora ad utilizzare (in ragione degli effetti che intende ottenere) un lessico afferente la sfera del diritto – ad esempio l’aggettivo ‘criminali’ abbinato indistintamente ai giovani delle nuove generazioni –, anche se sa benissimo che tali termini si riferiscono ad atti compiuti, e non possono essere riferiti ad azioni possibili, anche se è probabile che seguiranno a comportamenti che la stessa autorità giudiziaria giudicherebbe senza dubbio ‘sospetti’. Egli risponderebbe che è proprio questo il punto, che sta parlando con lo sguardo rivolto al futuro (e in più di un caso vede giusto): il risultato tuttavia è una ricezione a volte attonita a volte stralunata anche nel lettore ben disposto, il quale si domanda fino a che punto la virulenza polemica giustifichi certe espressioni che confondono l’universo della colpa giuridica con quello della colpa morale (è come se Pasolini sostituisse alla colpa metafisica di Jaspers una del tutto inedita ‘colpa antropologica’, che ci si porta addosso per il solo fatto di essere nati nell’epoca del consumismo).
Ciò non sminuisce comunque il suo contributo, che ancora oggi ci stimola e ci interroga. Pasolini infatti legge (marxianamente) la storia umana come risultato di conflitti e la società come configurazione di rapporti di forze, e a tal riguardo è sempre lucidissimo: per questo il nesso tra diritto e politica è in lui così stringente, e per noi – attraverso di lui – così visibile: essendo la società percorsa da forze e strutturata da poteri disuguali che le esercitano con fini e obiettivi identificabili, come può il diritto (e coloro che vi si richiamano) disinteressarsi alle scienze umane? Come può il diritto prescindere dall’antropologia, dalla linguistica o dalla sociologia, se è grazie a queste (prima che al diritto) che è stato messo in luce l’avvento di una nuova civiltà? Se le forze e i poteri non sono più gli stessi, come non volgersi alla giurisprudenza se non con la coscienza che – come ogni altro sapere – deve ripensare almeno in parte se stessa, rivedere le proprie categorie, ricalibrare i propri dispositivi? È in grado il diritto, e con lui le scienze tutte, di ‘stare al passo’ con una realtà su cui le categorie finora approntate non sono più in grado di ‘fare presa’?
A quest’altezza, e prescindendo dai limiti messi in evidenza, la lezione pasoliniana è esemplare: temendo che la maggioranza si stia muovendo in direzione dell’assenso a un modello in cui la forza invoca il diritto per legittimare se stessa (anziché assumerlo nella sua imprescindibile funzione di rinvio e richiamo a un’origine – umanistica e umana –, oltre che di ‘freno’ rispetto ad ogni deriva politica delle superpotenze), Pasolini ci rinvia alla radice dello Sviluppo che l’Occidente ha assunto come unica bussola: uno sviluppo come ‘fare’ che non s’interroga sul suo ‘essere’ solo perché funziona – solo perché esiste. Egli ci mette così in guardia dal portare a compimento ciò che già è iniziato, ciò che continua: l’arrendevolezza rispetto allo strapotere delle nuove élites e alla privazione dei diritti civili dei subalterni (coloro che per caratteristiche e numero non godono di rappresentanza) … Da qui l”impegno’ come conseguenza diretta dell’appartenenza alla classe intellettuale (sia pur borghese, com’è ovvio), ma anche della consapevolezza che è su un piano strutturale che l’individuo – ogni individuo, a maggior ragione se in grado, per risorse proprie e congiunturali, di farsi ascoltare – può intervenire attivamente nei processi vitali di una comunità politica. Egli cerca di allontanare l’incubo di un’omologazione compiuta e definitiva, talmente coercitiva da pretendere “di fare dell’umanità stessa l’incarnazione del diritto” (73), e con ciò tentare di rimediare alla sconfitta del marxismo umanistico (l’espressione è di Pasolini), giunto a constatare l’avvenuta sparizione di ogni cultura propria delle classi sfruttate, ormai ‘convertite’ ai valori delle classi dominanti proprio mentre queste ultime le schiacciano. Infine egli ci ricorda, con la Arendt, che dietro il diritto si cela l’etica, e dietro questa individui concreti: che nessuno di questi tre momenti dev’essere inteso astrattamente, perché ognuno rimanda necessariamente agli altri due.
Si potrebbe dire che Pasolini compie due operazioni: mette in luce, a monte, le ripercussioni delle scelte compiute nell’ambito del diritto sull’uomo concreto, sulle sue abitudini e possibilità d’azione; promuove, a valle, i gesti che questo stesso uomo concreto può compiere per resistere alla mutazione – compito che egli declina a suo modo, come pedagogo. In questo secondo caso, è la sopravvivenza in condizioni estreme a fungere da filo conduttore, e quindi il Lager ad essere il convitato di pietra, il ‘grado zero’ di ogni possibile discorso intorno alla conservazione dell’autonomia individuale in una società massificata. A questo livello gli spunti per un possibile confronto vengono soprattutto da Bruno Bettelheim, che con i suoi libri – specialmente Sopravvivere e Il cuore vigile. Autonomia individuale e società di massa – ha avanzato la sua proposta (praticissima, e insieme genuinamente teorica) che la conservazione dell’individualità sia da ricondurre, in un’ottica strategica, all’impedire la disintegrazione della personalità – al favorire cioè l’integrazione delle sue varie componenti. Tale integrazione è realizzabile a partire dalla ‘lezione del Lager’: il cui primo precetto è capire cosa sta avvenendo dentro di noi e perché, per giungere, attraverso decisioni spontanee, all’affermazione di sé come centro autonomo di decisioni costantemente negoziate con l’estremo, e conseguentemente negazione di sé come unità di un sistema (essendo la distruzione dell’individuo il proposito reale, l’essenza stessa dello Stato totale di massa (74)). Ogni misura volta a promuovere l’istinto di vita contro l’angoscia della morte e della mortificazione, diviene un momento, una tappa o una parte di un “medesimo sforzo, lo sforzo dell’integrazione” (75), la quale dopo essere stata risolta a un livello si ripropone a un altro (76). È a questa lotta squisitamente individuale che Pasolini dà forma con Gennariello: tutti i suoi insegnamenti al suo allievo immaginato (non temere la sacralità e i sentimenti, persistere nella critica e nella denuncia, accettare le proprie qualità personali, essere allegri di contro al grigiore del consumatore, coltivare la propria volontà) (77) vanno nella direzione della conservazione di un’autonomia che si scontra sia col conformismo più supino e arrendevole, sia con quelle forme codificate di anticonformismo che sono l’altra faccia del conformismo stesso.
Mi piace dunque concludere, dato che i contributi – sub specie pasoliniana – si richiamano a un progetto intitolato «Visioni del giuridico», ricordando quanto la vista e il vedere siano decisivi, preponderanti nell’ultimo Pasolini. Tutto ciò che di più acuto egli ha scritto negli ultimi due anni della sua esistenza è da ricondurre infatti a un metodo che è stato opportunamente definito “semiologico-visivo” (78), dove il vedere apre a ciò che sta oltre la vista (la psicologia, l’ideologia, le intenzioni, la cultura) ma è pur sempre desunto da essa. Tanto più questo discorso vale per l’ambito giuridico, a cui il nostro excursus, toccando la questione della legalizzazione dell’aborto, ha inteso sineddoticamente richiamare: negli Scritti corsari si legge infatti che i legislatori arrivano sempre in ritardo, il che da un lato (inconscio) è il frutto inevitabile della condizione umana (“ciò che si vive esistenzialmente è sempre enormemente più avanzato di ciò che si vive consapevolmente” (79)), ma dall’altro lato (conscio) può suonare come un’esortazione, un invito a coloro che al diritto si sono votati: ossia fare propri i requisiti che Pasolini ascrive alla professione di scrittore: immaginare “ciò che non si vede”, letteralmente prevedere … non nel senso (strutturalista) dell’anticipare la reattività di un modello in cui il minimo cambiamento, al livello dei tratti costitutivi, coinvolge l’intero sistema con trasformazioni determinabili su basi neopositivistiche; piuttosto, nel senso dell’immaginazione prefigurante, della ‘costruzione’ di scenari possibili a partire dai dati concreti di realtà su cui agire, in seguito, anche con gli strumenti che al diritto competono. È in questo contesto – crediamo – che può avere un senso l’altrimenti equivoca sentenza per cui “la prima qualità di ogni scienza è quella di essere profetica” (80). Dove a ‘scienza’ va aggiunto (Pasolini lo sottintende) ‘umana’. Parte cioè di quella cultura che l’edonismo consumista rifiuta (81) e senza la quale si cade in profezie d’altro genere, afferenti alle cosiddette ‘scienze dure’, necessarie e sicuramente efficacissime sul piano del calcolo delle probabilità, ma estranee a quella particolare imprevedibilità che sola definisce l’atto con cui ogni uomo può rivendicare, fosse anche solo una volta nel corso della vita, la propria libertà (82).
Note
1. B. Malinowski, «Introduction», in J. Kenyatta, Facing Mount Kenya, Vintage Books, New York 1965, p. vii.
2. È la prima fase – cosiddetta degli antropologi – del quarto periodo nella partizione di Kapuściński concernente i rapporti tra gli europei e l’altro: il cosiddetto periodo post-illuminista (gli altri tre sono quelli dei mercanti e ambasciatori, delle grandi scoperte geografiche e dell’Illuminismo). Seguono – sempre stando a Kapuściński – le fasi di Lévinas e la fase multiculturale. Alla luce di questa periodizzazione, Pasolini s’inserisce, senza la mediazione di Lévinas, tra la fase degli antropologi (dove in qualche maniera s’inserisce) e quella multiculturale (che entro certi limiti presagisce). Vedremo in che senso. Cfr. R. Kapuściński, L’altro, Feltrinelli, Milano, pp. 21-2.
3. “Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il mistero. Tutto ciò fa parte del mio mestiere e dell’istinto del mio mestiere” (P.P.Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano 2005, p. 89 – d’ora in poi SC).
4. “Ho aggiunto alla mia esperienza esistenziale, anche degli interessi specifici. Cioè linguistici, per esempio. Ma anche etnologici e antropologici. Non ne ho un’informazione scientifica; ma ne ho la conoscenza che deriva da un profondo interesse” (SC, p. 212).
5.G. Galli, Pasolini comunista dissidente. Attualità di un pensiero politico, Kaos edizioni, Milano 2010, p. 65.
6. A. Tricomi, Pasolini: gesto e maniera, Rubbettino, Catanzaro 2005, p.17.
7.Ibid., p. 5.
8. Ibid., p. 76.
9. A. M. Sobrero, Ho eretto questa statua per ridere. L’antropologia e Pier Paolo Pasolini; Cisu, Roma 2015. Tale studio, molto ricco, puntuale, approfondito e per giunta appassionato, ha forse un unico neo che gli impedisce d’essere esaustivo: l’aver tralasciato il rapporto – indiretto e obliquo ma non per questo di secondo piano – che l’opera di Pasolini intrattiene, coscientemente e non, con l’antropologia strutturale. (Sobrero accenna una volta sola, di sfuggita, alla distanza tra il “sentimento dei luoghi e dell’altrove” che aleggia e si fa tangibile nell’inquietudine di Pasolini, e l’equilibrio lévi-straussiano che la storia corromperebbe). A questo proposito mi permetto di rinviare al mio «Riformare lo strutturalismo? Pasolini critico di Lévi-Strauss» (di prossima pubblicazione), in cui ho cercato per sommi capi di restituire alcune affinità e differenze tra i due.
10. Ibid., p. 26.
11. Ibid., p. 37.
12. Ibid., 37-8. Si veda a tal riguardo l’articolo Che cos’è uno scritto corsaro?, in cui Rovatti parla di “qualcosa come uno zoom con cui avvicina a sé le persone, i comportamenti, i dettagli […] o meglio, con cui avvicina se stesso alla gente fino a toccare, con i suoi sensi, i comportamenti e i dettagli di essi” (P. A. Rovatti, Che cos’è uno scritto corsaro?, in Aut Aut n. 345. Inattualità di Pasolini, Il Saggiatore, Milano 2010, p.67).
13.A. M. Sobrero, op. cit., p. 140, p. 263, pp. 273-4 e passim.
14.Ibid.., p. 253.
15. Ibid., p. 46.
16. Ibid.., p. 246.
17. Ibid., p. 92 e 113.
18. Ibid., p. 96.
19. Ibid., p. 83.
20. “Si potrebbe, anzi, arrivare a dire che tra la sua esperienza intellettuale e gli istituti tradizionali della letteratura passi la stessa relazione di obliquità, o di esteriorità, che la riflessione filosofica italiana intrattiene con i profili canonici della filosofia moderna” (R. Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità della filosofia italiana, Einaudi, Torino 2010, p. 196). Esposito – e non è certo il solo (cfr. Belpoliti, Pasolini in salsa piccante, Guanda, Milano 2010, pp. 39-47; Rovatti, op. cit; Santato, Pier Paolo Pasolini. L’opera poetica, narrativa, cinematografica, teatrale e saggistica, Carocci, Roma 2012, pp. 515-30) – mette bene in evidenza il tema del corpo come centro d’irradiazione e cuore pulsante dell’ultimo pensiero pasoliniano.
21. SC, p. 128.È in questo senso che va letta l’affermazione di Roversi, pronunciata più di trent’anni fa e tuttora valida, secondo cui “rileggendo le sue pagine – quelle dell’inizio ma soprattutto quelle della fine – caviamo sempre spinte determinanti per affrontare i problemi generali” (R. Roversi, Io muoio e anche questo mi nuoce (Per una riappropriazione di Pasolini), in G. Santato (a cura di), Pier Paolo Pasolini. L’opera e il suo tempo, Cleup editore, Padova 1983, p. 233 (cors. nostro).
22. SC, p. 156.
23.Ibid., p. 73.
24. Cfr. di nuovo, a questo proposito, Rovatti, op. cit., dove tale connubio è ritenuto essere il “sinolo” alla base dello scritti corsari come genere.
25. SC, pp. 5-11.
26.Ibid., pp. 12-6.
27. Si veda la chiarezza e il valore operativo della tassonomia sui linguaggi della presenza fisica, del comportamento e dell’azione (ibid., pp. 155-6).
28. “…quello che io chiamo dell’afasia, della perdita della capacità linguistica” (ibid., p. 228).
29. Cfr. categorie come lingua orale e lingua orale-grafica in Empirismo eretico (id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, I, Mondadori, Milano 2008, pp. 1319-33).
30.F. de Saussure, Corso di linguistica generale, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 26.
31. Il discorso sul marxismo pasoliniano, anche limitandosi al periodo in questione, sarebbe lungo; ci si accontenti qui di accennare al suo carattere “sentimentale” (E. Golino, Tra lucciole e palazzo. Il mito Pasolini dentro la realtà, Sellerio, Palermo 1995, p. 77) e “dicotomico” o “mobile” (G. Galli, op. cit., p. 102), nel senso rispettivamente di schematico-oppositivo – borghesi vs. operai, sfruttatori vs. sfruttati – e in perpetua evoluzione. In ogni caso, un marxismo “problematico” nella misura in cui è istintivo anziché teorico.
32. O meglio fratellanza: cfr. P. Voza, «Puro eroico pensiero e questione sociale della lingua: il Gramsci di Pasolini», in Gramsci e la “continua crisi”, Carocci, Roma 2008, pp. 91-111.
33.Sul rapporto Pasolini-De Martino cfr. A. Tricomi, «Il ’68: un’apocalisse culturale», in id., In corso d’opera. Scritti su Pasolini, Transeuropa, Milano 2011, pp. 177-195.
34. SC, 133.
35. A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 2007, p. 2346.
36.K. Crehan, Gramsci. Cultura e antropologia, Argo, Lecce 2010, p. 94.
37.Cfr. G. Sapelli, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini, Bruno Mondadori, Milano 2005, p. 64.
38. Cfr. A. M. Sobrero, op. cit., p. 26.
39.Su questi temi cfr. E. Golino, Pasolini. Il sogno di una cosa. Pedagogia Eros Letteratura, Bompiani, Milano 2005, in particolare pp. 9-52 e 185-232.
40. S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana, Marsilio, Venezia 2001, p. 318.
41. E. Siciliano, Vita di Pasolini, Mondadori, Milano 2005, p. 428.
42.Ibid., p. 422.
43.Ivi.
44. “Il linguaggio dell’azione […] dà […] informazioni di carattere direttamente politico (psicologia e etica fanno da sfondo)” (SC, p. 156); una frase importantissima, se teniamo conto che per Pasolini non è la presenza fisica né il comportamento, ma “è l’agire che qualifica” (P. P. Pasolini, Lettere luterane. Il progresso come falso progresso, Einaudi, Torino 2003 – d’ora in poi LL –, p. 97).
45.H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino 1999, p. 92.
46. SC, p. 14.
47. Ibid., p. 53-4.
48.Ibid., p. 22.
49. Ibid., p. 123 (cors. nostro).
50.Ibid., p. 131 (cors. nostro).
51.Ibid., p. 226.
52.Ibid., p. 231 (cors. nostro).
53. Ibid., p. 209-10.
54. LL, p. 24.
55. SC., p. 135.
56. P. P. Pasolini, I campi di concentramento, in RRI, Mondadori, Milano 2008, p. 1459.
57. Ibid., p. 1461.
58.Scrive Wirth, ad esempio, che il ghetto ha “effettivamente una certa rassomiglianza con le sbarre di una prigione” (Louis Wirth, Il ghetto. Il funzionamento sociale della segregazione, Res Gestae, Milano 2014, p. 9).
59. Riguardo l’uso dei concetti in Pasolini, valga quanto scrive il suo biografo francese, René de Ceccatty: “I concetti erano termini troppo pesanti per lui: li maneggiava male, dando costantemente l’impressione di scegliere un termine inappropriato, troppo vasto, troppo poco maneggiabile e di parlare una lingua che non poteva essere compresa dai suoi interlocutori” (R. de Ceccatty, Pasolini, Gallimard, Paris 2005, p. 230; trad. nostra).
60. P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 2007, p. 12. Walter Siti ha scritto che “Pasolini lo si dovrebbe leggere nelle scuole insieme a Primo Levi, per esemplificare due facce opposte del coraggio” (W. Siti, Tracce scritte di un’opera vivente , in RRI, p. xvii); non sarebbe forse del tutto privo di interesse sviluppare, a partire dal grande tema del Lager, un confronto tra i due che abbia come oggetto la circumnavigazione di quello spazio teorico, esistenziale e percettivo che in entrambi si associa a determinati modi di vivere, a loro volta corrispondenti a modi diversi d’intendere e interpretare ognuno il proprio “universo concentrazionario” – spazio fisico e della mente in cui sentimenti emozioni e pensieri si coagulano, vengono liberati, prendono forma. Al di là di ogni considerazione sull’inattendibilità “epistemologica” di alcuni azzardi pasoliniani riguardo il Lager come fenomeno storico e antropologico (che invece siamo tenuti a riportare qui), ciò significherebbe uno studio di queste due grandi personalità letterarie sotto il profilo – incompatibile e parallelo – della testimonianza. In che senso sono entrambi scrittori-testimoni, e in che misura complementari?
61. Per Pasolini sembra non esistere la “zona grigia” di cui parla Levi, ma solo distinzioni assolute e opposizioni inconciliabili: con tutto il rischio di manicheismo che questo comporta. Il suo è un pensiero dicotomico, che sembra quasi ‘esportare’ il concetto di opposizione dalla linguistica strutturale alla politica e all’etica.
62.SC, p. 26.
63. Levi non cessa di far notare – in Se questo è un uomo, La tregua e I sommersi e i salvati – che, più che i meccanismi in se stessi, sono le conseguenze a differire: i tipi umani e psicologici in Lager sono gli stessi che fuori, solo più abbrutiti o al limite in condizione di ricoprire funzioni che fuori non avrebbero. I desideri e i bisogni nella nostra civiltà sono gli stessi, dentro e fuori dal Lager: la ricerca del prestigio ad esempio, osserva Levi, entra in gioco ad Auschwitz tanto quanto in un grande stabilimento industriale (cfr. P. Levi, op. cit., p. 27-8).
64. “Il fatto lì per lì non aveva molta importanza. Ma era il movimento stesso del disprezzo – la piaga del mondo – così come più o meno camuffato, impera ovunque nei rapporti umani di tutto il mondo da cui noi eravamo stati tolti. Lì erano solo più evidenti. Noi davamo all’umanità sprezzante la possibilità di mostrarsi a nudo” (R. Antelme, La specie umana, Einaudi, Torino 2007, p. 61).
65. Z. Bauman, Modernità e Olocausto, Il Mulino, Bologna 2010.
66. SC, p. 113.
67. “Il primo passo verso il dominio totale è l’uccisione del soggetto di diritto che è nell’uomo” (H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2004, p. 612); “l’uccisione della personalità giuridica che è nell’uomo è una condizione indispensabile per dominarlo interamente” (ibid., p. 617).
68. Ibid., p. 618.
69. Ibid., p. 620.
70.SC, p. 111.
71. SC, p. 108; cfr. anche LL, pp. 24-5.
72. K. Jaspers, La questione della colpa, Raffaello Cortina, Milano 2012, p. 29. Non risulta che Pasolini abbia letto Jaspers, né egli distingue rigorosamente i quattro tipi di colpa come fa il filosofo tedesco (colpa politica, giuridica, morale e metafisica), anche se possiamo dire che tenda a escludere la quarta: certo è che in termini argomentativi generali i due sono sulla stessa lunghezza d’onda. Jaspers equipara la colpa giuridica a quella politica come entrambe afferenti il diritto, mentre esclude le altre due in quanto concernenti esclusivamente il singolo e la sua coscienza – e al limite Dio (ibid., pp. 22-3). Come si vede, le ragioni per cui Pasolini considera l’aborto una questione giuridica anziché morale sono identiche (cfr. SC, p. 111).
73.H. Arendt, op. cit., p. 633.
74. Cfr. Bruno Bettelheim, Il cuore vigile. Autonomia individuale e società di massa, Adelphi, Milano 1998, p. 344.
75. Id., Sopravvivere, SE, Milano 2005, p. 33.
76. Ibid., p 32.
77. LL, pp. 15-67.
78. M. Belpoliti, op. cit., p. 38.
79.SC, p. 33.
80.LL, p. 132.
81. SC, p 23.
82. B. Malinowski, «Introduction», in J. Kenyatta, Facing Mount Kenya, Vintage Books, New York 1965, p. vii.



