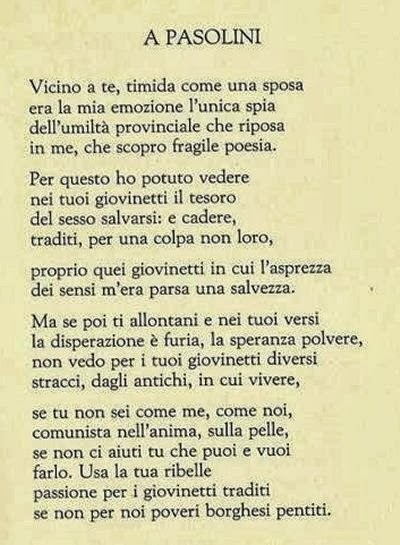A un ragazzo (1956-1957)
da La religione del mio tempo (1961)
in Pier Paolo Pasolini, Tutte le poesie, Tomo I, Meridiani Mondadori, Milano 2003
Così nuovo alla luce di questi mesi nuovi
che tornano su Roma, e che a noi altrove
ancorati a una luce d’altri tempi,
sembrano portati da inutili venti,
tu, con fresco pudore, e ingenuamente senza
pietà, scopri per te, per noi, la tua presenza.
Col sorriso confuso di chi la timidezza
e l’acerbità sopporta con allegrezza,
vieni tra gli amici adulti e fieramente
umile, ardentemente muto, siedi attento
alle nostre ironie, alle nostre passioni.
Ad imitarci, e a esserci lontano, ti disponi,
vergognandoti quasi del tuo cuore festoso…
Ti piace, questo mondo! Non forse perché è nuovo,
ma perché esiste: per te, perché tu sia
nuovo testimone, dolce-contento al quia…
Rimani tra noi, discreto per pochi minuti
e, benché timido, parli, con i modi già acuti
dell’ilare, paterna e precoce saggezza.
Esponi, orgoglioso, la tua debolezza
di adolescente, leso appena al ridicolo
che ha la troppa umiltà in un mondo nemico…
Al giusto momento, ci lasci, ritorni
alla segreta luce dei tuoi primi giorni:
alla luce che certo tu non puoi dire
né, noi, ricordare, una luce d’aprile
in cui la coscienza con le sue gemme sfiora
solo la vita, non la storia ancora.
Tu vuoi SAPERE, da noi: anche se non chiedi
o chiedi tacendo, già appartato e in piedi,
o tenti qualche domanda, gli occhi vergognosi,
ben sentendo in cuore ch’è vano ciò che osi,
se di noi vuoi sapere ciò che noi ai tuoi occhi
ormai siamo, vuoi che le perdute notti
del nostro tempo siano come la tua fantasia
pretende, che eroica, com’è eroica essa, sia
la parte di vita che noi abbiamo spesa
disperati ragazzi in una patria offesa.
Vuoi sapere le mute paure e le immature azioni
– tra macerie, strade deserte e prigioni –
delle nostre figure per te ormai remote.
Vuoi sapere, e il viso infantile ti si infuoca,
tu, così puro, il male, così limpido l’odio,
ch’è nei riaccesi ricordi su cui inchiodi
l’occhio ferito, parteggiando intero
per chi lottava in nome del sentimento vero.
Vuoi sapere che cosa abbiamo ricavato
da quell’avventura, in che cosa è mutato
lo spirito di questa povera nazione
dove provi tra noi la tua prima passione;
sperando che ogni atto che ti preesiste, Chiesa
e Stato, Ricchezza e Povertà, intesa
trovino nel tuo dolce desiderio di vita…
Vuoi sapere l’origine della tua pudica
voglia di sapere, s’essa ha già dato prova
di tanta vita in noi, e adesso cova
già nuova vita in te, nei tuoi coetanei.
Vuoi sapere cos’è l’oscura libertà,
da noi scoperta e da te trovata,
grazia anch’essa, nella terra rinata.
Vuoi SAPERE. Non hai domanda su un oggetto
su cui non c’è risposta: che trema solo in petto.
La risposta, se c’è, è nella pura
aria del crepuscolo, accesa sulle mura
del Vascello, lungo le palazzine
assiepate nel cuore del sole che declina.
Le sere disperate per il troppo tepore
che nei freddi autunni, dimenticato muore,
o, dimenticato, in nuove primavere
torna improvviso – le disperate sere
in cui, tu, felice pei tuoi abiti freschi,
o il fresco appuntamento con giovani modesti
come te, e felici, esci svelto di casa,
mentre nel rione suona la sera invasa
dall’ultimo sole – penso a quel serio, candido
ragazzo, il cui silenzio è nella tua domanda.
Certo soltanto lui ti potrebbe rispondere,
se fu in lui, com’è in te, pura speranza il mondo.
Era un mattino in cui sognava ignara
nei rósi orizzonti una luce di mare:
ogni filo d’erba come cresciuto a stento
era un filo di quello splendore opaco e immenso.
Venivamo in silenzio per il nascosto argine
lungo la ferrovia, leggeri e ancora caldi
del nostro ultimo sonno in comune nel nudo
granaio tra i campi ch’era il nostro rifugio.
In fondo Casarsa biancheggiava esanime
nel terrore dell’ultimo proclama di Graziani;
e, colpita dal sole contro l’ombra dei monti,
la stazione era vuota: oltre i radi tronchi
dei gelsi e gli sterpi, solo sopra l’erba
del binario, attendeva il treno di Spilimbergo…
L’ho visto allontanarsi con la sua valigetta,
dove dentro un libro di Montale era stretta
tra pochi panni, la sua rivoltella,
nel bianco colore dell’aria e della terra.
Le spalle un po’ strette dentro la giacchetta
ch’era stata mia, la nuca giovinetta…
Ritornai indietro per la strada ardente
sull’erba del marzo nel sole innocente;
la roggia tra il fango verde d’ortiche
taceva a una pace di primavere antiche,
e i rinati radicchi da cui vaporava
un odore spento e acuto di rugiada,
coprivano il dorso della vecchia scarpata
grande come la terra nell’aria riscaldata.
Poi svoltava il sentiero in cuore alla campagna:
liberi nell’umile ordine, folli nella cristiana
pace del lavoro, nel parlante amore muti,
tacevano gelseti, macchie d’alni e sambuchi,
vigne e casolari azzurri di solfato, –
nel vecchio mezzogiorno del vivido creato.
Chiedendo di sapere tu ci vuoi indietro,
legati a quel dolore che ancora oscura il petto.
Ci togli questa luce che a te splende intera,
ch’è della nuova gioventù ogni nuova sera…
Noi invecchiati ora nient’altro diamo
che doloroso amore alla tua lieta fame.
Anche la tua stessa pietà, che cosa dice
se non che la vita solo in te è felice?
Perché, per fortuna, quel nostro passato,
vero, ma come un sogno, è nel tuo cuore grato.
In realtà non esiste, ne sei libero e cerchi
di esso solo quanto può adesso valerti…
Nella tua nuova vita non è esistito mai
fascismo o antifascismo: nulla, di ciò che sai
perché vuoi sapere: esiste solamente
in te come un crudele dolce fiore il presente.
Che tutto sia davvero rinato – e finito –
sia tutto – è scritto nel tuo sorriso amico.
È vizio il ricordare, anche se è dovere;
a quei morti mattini, a quelle morte sere
di dodici anni or sono, non sai se più rancore
o nostalgia, leghi il nostro cuore…
L’ombra che ci invecchia fosse astratta coscienza,
voce che contraddice la vitale presenza!
Fosse, com’è in te, la spietata gioia
di sapere, non l’amarezza di sapere ch’è in noi!
Ciò che potevamo risponderti è perduto.
Può parlarti – se, tu ragazzo, sai il muto
suo nuovo linguaggio di ragazzo – soltanto
chi è rimasto laggiù, nella luce del pianto…
Era ormai quasi estate, e i più bei colori
ardevano nel mite, friulano sole.
Il grano già alto era una bandiera
stesa sulla terra, e il vento la muoveva
fra le tenere luci, riapparse a ricolmare
di festa antica l’aria tra i monti e il mare.
Tutti erano pieni di disperata gioia:
sulla tiepida polvere delle vie ballatoi
e balconi tremavano di fazzoletti rossi
e stracci tricolori; pei sentieri, pei fossi
bande di ragazzi andavano felici
da un paese all’altro, nel nuovo mondo usciti.
Mio fratello non c’era, e io non potevo
urlare di dolore, era troppo breve
la strada verso il granaio perso nei campi, dove
per un anno l’ingenua, eternamente giovane,
povera nostra mamma aveva atteso, e ora
era lì che attendeva, sotto il tiepido sole…
Ma ha ragione la vita che è in te: la morte,
ch’è nel tuo coetaneo e in noi, ha torto.
Noi dovremmo chiedere, come fai tu, dovremmo
voler sapere col tuo cuore che si ingemma.
Ma l’ombra che è ormai dentro di noi guadagna
sempre più tempo, allenta ogni legame
con la vita che, ancora, un’amara forza
a vivere e capire invano ci conforta…
Ah, ciò che tu vuoi sapere, giovinetto,
finirà non chiesto, si perderà non detto.
E Bertolucci risponde:
Scrive, ancora, Bernardo Bertolucci:
Nessuno saprà mai raccontare quelli che voglio chiamare i miei momenti privilegiati. Da quando sapevo scrivere, scrivevo poesie. Mio padre era il primo (e unico) lettore e il mio generoso e implacabile critico. Verso i sedici anni la mia produzione poetica si era andata molto impoverendo. «Ti stai arenando…» mi punzecchiava mio padre. La verità è che durante l’estate avevo girato il mio primo film, La teleferica, dieci minuti in sedici millimetri, la giusta iniziazione per un regista sedicenne. Ma anche la prima sconvolgente scoperta che esisteva un’alternativa alla poesia, trappola ormai vischiosa per il figlio di un poeta.
Nel 1959 la famiglia Pasolini (Pier Paolo, Susanna e Graziella Chiarcossi) si trasferisce in via Carini 45. Noi abitiamo al quinto piano, loro al primo. Ricominciai a scrivere poesie per poter bussare alla porta di Pier Paolo e fargliele leggere. Appena ne avevo scritta una scendevo le scale a grandi balzi con il foglio in mano. Lui era rapidissimo nella lettura e nel giudizio. Il tutto non durava più di cinque minuti. Quegli incontri cominciai a chiamarli dentro di me «momenti privilegiati». Ne uscì un mucchietto di poesie che Pier Paolo, tre anni dopo, mi incoraggiò a pubblicare. Chissà cosa pensò mio padre, degradato senza spiegazione a lettore numero due.
Nel febbraio del 1945 Guido viene ucciso, insieme al comando della divisione Osoppo. I fatti avvengono nelle malghe di Porzus: un centinaio di garibaldini si avvicinano fingendosi sbandati, catturano quelli della Osoppo e li passano per le armi. Guido, seppure ferito, riesce a fuggire e viene ospitato da una contadina. Viene trovato dai garibaldini, trascinato fuori e massacrato. La famiglia Pasolini saprà della morte e delle circostanze solo a conflitto terminato. Scrive Pasolini:
Spesso penso al tratto di strada tra Musi e Porzus, percorso da mio fratello in quel giorno tremendo, e la mia immaginazione è fatta radiosa da non so che candore ardente di nevi, da che purezza di cielo. E la persona di Guido è così viva.
Quello che segue è l’incipit della parte di poesia in cui Pier Paolo Pasolini parla del fratello ucciso:
Era un mattino in cui sognava ignara
nei rósi orizzonti una luce di mare: ogni filo d’erba come cresciuto a stento
era un filo di quello splendore opaco e immenso.