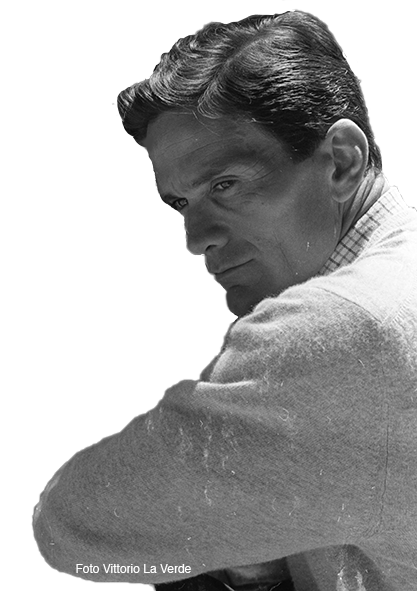Nel 2014, per i tipi di Rocco Carabba, è uscito un cospicuo saggio di Andrea Di Berardino, dal titolo Il potere sovversivo delle parole. L’ultimo Pasolini (1968-1975) che indaga e interpreta con minuziosa e acuta precisione l’impegno civile di Pasolini nel campo della pubblicistica e del giornalismo militanti e polemici. Un genere di scrittura, destinato a confluire negli scritti corsari e luterani, che trova le sue premesse negli interventi legati al ’68 e alle contestazioni studentesche del Movimento.
Qui di seguito pubblichiamo il testo che compare nella quarta di copertina e un profilo dell’autore.
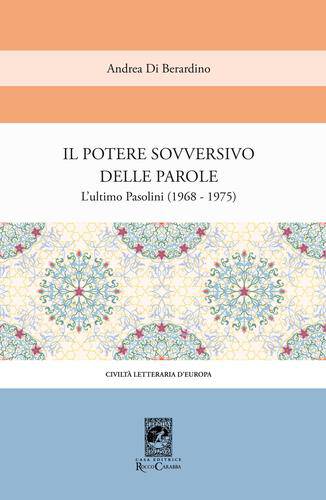
Il potere sovversivo delle parole. L’ultimo Pasolini (1968-1975)
di Andrea Di Berardino
Rocco Carabba editore, Lanciano, 2014
Nel Pianto della scavatrice, il poemetto più ampio delle Ceneri di Gramsci (1957), nelle folgoranti battute d’avvio si legge: «Solo l’amare, solo il conoscere | conta, non l’aver amato, | non l’aver conosciuto. Dà angoscia | | il vivere di un consumato | amore. L’anima non cresce più». Questa urgenza del presente è la molla che ha spinto continuamente Pasolini ad analizzare, a cercare di capire, a proporre di migliorare il mondo: in altri termini a re-interpretare il ruolo gramsciano dell’”intellettuale organico”.
Varie forme espressive di carattere artistico, in base a questa concezione, vengono sperimentate dall’autore: dalla letteratura al cinema, passando per il teatro; e, restringendo il campo alle humanae litterae, la prosa e la poesia s’avvicendano e costantemente si scambiano la leadership . A partire dal 1968 si fa strada un saggismo da pubblicista polemico, militante, civile: questo genere letterario, che culminerà nei testi confluiti negli Scritti corsari e nelle Lettere luterane, trova i suoi prodromi negli articoli usciti nell’annus mirabilis delle rivolte studentesche e della contestazione giovanile.
Siccome nel fragoroso universo dei tardi anni Sessanta, già monopolizzato dai mass media, la “vecchia” parola scritta non basta più, Pasolini non esita a chiamare in causa il gesto, cioè a «gettare il proprio corpo nella lotta», in una compromissione della persona “fisica”, assoluta, che non ammette ripensamenti. E che infine condurrà, come estrema conseguenza, ad una sorta di sacrificio di sé.
[info_box title=”Andrea Di Berardino” image=”” animate=””]laureato in lettere moderne nel 1999 presso l’Università di Chieti, poi dottore di ricerca in italianistica presso l’Università di Romatre nel 2010 con una tesi sull’ultimo Pasolini, , insegna attualmente italiano e latino al liceo scientifico “Galilei” di Pescara. Ha collaborato con riviste quali “Oggi e domani”, “Vernice”, “Itinerari”; nel 2003 ha curato una raccolta degli scritti del giornalista abruzzese Vincenzo Bucci; nel 2004 ha pubblicato una piccola monografia dedicata alle figure femminili nella poesia pascoliana (Genesi). Ha scritto saggi su Myricae, Canti di Castelvecchio, Ossi di seppia e sul Croce lettore di Shakespeare.[/info_box]