Da host.uniroma3.it/progetti/prin06rmitadia, riprendiamo una dettagliata analisi dello studioso e giornalista Franco Onorati sull’interesse di Pasolini per i dialetti, tradotto in pionieristici studi nel campo della letteratura dialettale, tra cui anche gli interventi critici nelle iniziative di Mario dell’Arco, che fu collaboratore del poeta di Casarsa per il volume del 1952 Poesia dialettale del Novecento (Guanda).
di Franco Onorati
Premessa
Sono molteplici le direzioni lungo le quali Pasolini ha svolto il suo impegno di studioso della letteratura dialettale: certo, il più noto resta il volume Poesia dialettale del Novecento (Guanda 1952), curato assieme a Mario dell’Arco, al quale egli fece seguire tre anni dopo, sempre per lo stesso editore, la compilazione del Canzoniere italiano o Antologia della poesia popolare italiana. Quanto all’importanza della prima opera, basti richiamare la circostanza – rara nella storia letteraria del nostro Paese – della ristampa integrale pubblicata nel 1995 (Einaudi), con una nota introduttiva di Giovanni Tesio. Circostanza che ha fatto scrivere a Salvatore Nigro (“Il Sole-24 Ore” del 16 luglio 1995) quanto segue: “La Poesia dialettale del Novecento è un classico. E come tale va riletta. E quindi contestualizzata. Per apprezzarne la carica di scandalosa novità, nell’anno 1952, della prima edizione. E per definirne i limiti attuali, non foss’altro nella tenuta del quadro delle scelte (delle assenze e degli esiti imprevedibili di alcuni poeti all’epoca troppo giovani) e nella consistenza filologica degli apparati.” E tanto basti.
Ma l’impegno dialettologico di Pasolini non si esaurì in quelle due vaste crestomazie, trovando espressione soprattutto nella riflessione critica confluita, tra l’altro, in Passione e ideologia (1985).Il complessivo risultato cui Pasolini pervenne va anch’esso storicizzato; lo “scandalo” di allora (il dialetto non più come lingua di realtà ma come “lingua di poesia” al quale i vari autori ricorrono per esprimere musicalità e mondi a cui l’espressione in lingua non riuscirebbe ad aprirsi) oggi è un dato acquisito, tanto da aver costituito la piattaforma storico-critica che ha mosso Franco Brevini a curare la monumentale La poesia in dialetto. Storia e testi dalle origini al Novecento (Mondadori, 1999).
Accanto a quelle operazioni editoriali di vasto impianto, Pasolini affiancò un’iniziativa di sapore più propriamente giornalistico che sta a dimostrare come, anche all’indomani dell’exploit del 1952, egli continuasse ad esplorare il vasto pelago dialettale. Mi riferisco all’inchiesta (che egli chiamò “Il nostro referendum”) comparsa su una delle tante riviste ideate da Mario dell’Arco, “il Belli”.
Dell’Arco, come noto, affiancò all’attività poetica in proprio quella di promotore di periodici, la maggior parte dei quali mirati a valorizzare la poesia dialettale; sono nell’ordine le tre serie di “Poesia romanesca” (1945-1947); i sei fascicoli de “Er Ghinardo” (aprile-dicembre 1948); le dieci annate di “Orazio” (1949-1958); le quattro annate de “il Belli” (1952-1955); “Il Nuovo Cracas- Diario di Roma” (1962-1965).
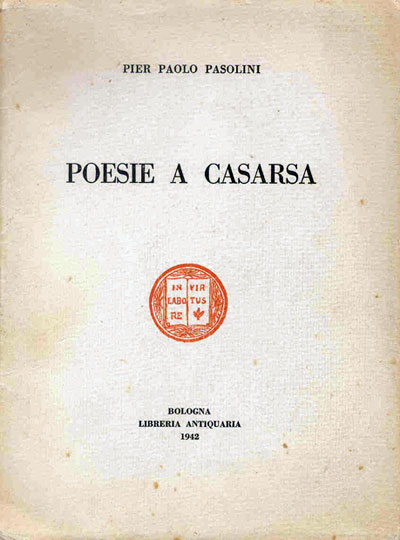
L’antefatto
E’ proprio all’interno della seconda testata sopra citata (“Er Ghinardo”) che si materializza per la prima volta la collaborazione fra Pasolini e dell’Arco.Il secondo numero, uscito nel maggio 1948, ospita infatti un brano pasoliniano dal titolo “Taccuino di un dialettale”, nel quale possiamo identificare un singolare incipit di quella lunga vicenda vissuta da protagonista che potremmo definire “Pasolini poeta e dialettologo”.
Riproduco in appendice l’articolo nel quale, nei modi di una prosa lirica intrisa di esplicite citazioni proustiane, l’artista friulano fissa un’esperienza epifanica: le apparizioni delle quattro maschere provenienti da Arzene e poi dei due Angeli (in verità, precisa più avanti, si trattava di due ragazze che erano state al funerale di una loro coetanea). Ma la paginetta ha una precisa valenza autobiografica in chiave linguistica: essa dice che le lunghe peregrinazioni del giovane poeta lungo le valli o ai bordi dei fiumi della “piccola patria” friulana avevano lo scopo non secondario di cogliere, negli incontri fortuiti che ne scaturivano, gli accenti e le sfumature di quel dialetto; così come testimoniano gli amici di quel tempo, suoi compagni in quelle gite o scorribande, e come Siciliano puntualmente registra nella sua Vita di Pasolini: “Il Friuli si dispiega ai suoi occhi come un campo da percorrere in lungo e in largo e scrutinare. Nel Friuli occidentale, specialmente basso, era possibile in dieci minuti di bicicletta passare da un’area linguistica a un’altra più arcaica…La bicicletta diventa uno strumento di lavoro intellettuale…”.
Ma per ricostruire la feconda relazione fra Pasolini e dell’Arco, occorre fare un passo indietro.I due poeti entrano in contatto qualche anno prima del trasferimento di Pasolini a Roma, avvenuto alla fine di gennaio del 1950. E’ probabile, anche se non documentato, che abbiano avuto modo di incontrarsi nel corso dei due primi soggiorni romani dell’artista friulano, avvenuti in aprile e in ottobre del 1946. Ciò che alimentò ben presto il loro rapporto, dandogli uno sbocco operativo e fecondo, fu appunto il comune impegno militante nell’area dei dialetti.A incoraggiare, se non a propiziare, il contatto fra i due non escludo possa essere stato Gianfranco Contini: c’è nell’archivio di dell’Arco una lettera che il critico gli indirizza da Domodossola (dove abitava) in data < Natale 1946>, nella quale si legge:
“Caro Signor dell’Arco, io sono un fanatico della bella poesia dialettale, e perciò Lei ha lusingato, mandandomi il Suo libretto, i miei gusti più segreti. Tanto più che oggi mi par chiara una tendenza della poesia dialettale alla lirica, diciamo così, “pura” e al (ripeto le virgolette) “canto”. Veda per esempio, se mai Le capitassero alle mani, le poesie friulane di Pier Paolo Pasolini, un ragazzo che sta a Casarsa. Capisco che Pasolini aveva tra mano un dialetto quasi-lingua (benché dovesse reagire all’imperversante zoruttismo)…omissis”.
E’ certo che l’avvio lo imprime dell’Arco, inviando a Pasolini, verso la fine del ’46, la sua prima raccolta, Taja ch’è rosso, pubblicata in quell’anno. Pronta la replica del destinatario:
“Egregio Sig. Dell’Arco,
debbo ringraziarla per il Suo dono che non so ancor bene se sia un libro, una farfalla, una manciata d’angioli. Dopo quello che Le è stato detto da Trompeo, Baldini, Bigiaretti, credo che Lei non abbia bisogno di uno di quei giudizi che confermino e comprovino; Le confesso soltanto un’impressione esterna, marginale, cioè che la seconda parte del libro mi sembra notevolmente più impegnativa della prima, e che su questo avanzamento si potrebbe imperniare tutto un discorso critico, da cui risulterebbe che è stata una intellettualità (in un certo senso anti dialettale) non scevra di umori metafisici a farle inventare le migliori poesie e non già la spensieratezza e la bravura, proposte dal Baldini, che sono dialettali.
Ad ogni modo, lasci che La invidi; Lei coi suoi versi dà di sé un’immagine beata, il bruco che si trasforma in farfalla senza doglie, semplicemente attraverso la scoperta di un meccanismo magico, prestabilito.
Cordiali saluti e auguri. Suo Pier Paolo Pasolini”.
Chiaro il riferimento alla prefazione di Antonio Baldini (“Farfalle sotto l’Arco di Tito”) e alla recensione che col titolo di “Tastiera” lo stesso critico aveva poi pubblicato sul “Corriere della Sera”.Dell’Arco gli replica e certamente gli propone, con romana schiettezza, di passare al <tu> e la successiva risposta dell’interlocutore è subito coniugata alla seconda persona:
“Caro dell’Arco,
le tue parole fini e precise mi hanno dato uno di quei piaceri intimi che tu certo conosci. Cosa vale tutta la pianura padana e tutto l’Appennino che la carta geografica minacciosamente ammassa tra le nostre due residenze? I nostri due libretti, come due candidissimi bachi (ti imito) hanno filato una rete più fitta di quella dei meridiani e dei paralleli. Quanto alle recensioni, qui la cosa è un po’ difficile, perché non ci sono riviste, e i quotidiani ben raramente escono con la terza pagina…omissis. Se come spero fra qualche tempo uscirà il Quaderno Romanzo (nuovo titolo dello Stroligut), ne darò notizia. Cordiali saluti dal tuo
Pier Paolo Pasolini”.
Nessuna traccia epistolare, allo stato delle mie ricerche, nei mesi successivi; è il periodo del “silenzio” di dell’Arco come promotore di riviste dialettali: difficoltà finanziarie (facilmente immaginabili), ma anche cambiamento di rotta. Giunge infatti a maturazione l’apertura interdialettale del poeta romano: dopo “Poesia romanesca”, la prima rivista da lui curata, chiusa nel recinto cittadino, sarà, l’anno dopo, la volta di “Er Ghinardo”, foglio aperto alla collaborazione dei dialettali di tutta Italia, oltre che naturalmente dei critici. Ma il 1947 è anche l’anno della pubblicazione della seconda raccolta dellarchiana, La stella de carta; e tra i primi destinatari cui l’autore spedisce il libretto vi è Pasolini, che così gli replica:
“Caro dell’Arco, ho appena finito di leggere il tuo libro, che da tre o quattro giorni mi attendeva al varco. Mi è piaciuto tanto che rinuncio a dartene ora un giudizio in poche righe o a riassumerlo in un complimento. Ne scriverò per qualche giornale o rivista. Qui ti dirò il più sommessamente possibile che Un prato in petto e le altre di quel settore pretendono il confronto, anche se puramente sperimentale, con la prima parte del Dolore ungarettiano. Tanti cordiali saluti dal tuo Pasolini”.
Tra le recensioni che salutano questa nuova fatica del poeta romano vi è infatti anche un bell’articolo di Pasolini, che esce su “Il mattino del popolo” in data 8 gennaio 1948; lo stesso giorno il recensore si affretta a spedirlo a dell’Arco con queste righe:
“Caro dell’Arco, rispondo con due o tre giorni di ritardo, ma attendevo che uscisse la mia recensione, per spedirtela con la cartolina. Spero di non aver colpito il bersaglio troppo ai margini. Quanto all’idea della rivista, è ottima; mi trovi consenziente e disponibile. Con affetto, tuo Pier Paolo Pasolini”.
Fin dal titolo, perentorio – “Un dialettale senza dialetto” – Pasolini mostra di centrare la scelta antivernacolare che va coltivando dell’Arco: che è poi un tratto che li accomuna.Dell’Arco deve aver ringraziato calorosamente l’altro per quel bell’articolo: e Pasolini gliene dà atto pochi giorni dopo:
“Caro dell’Arco, le tue due cartoline mi hanno fatto davvero piacere. Un critico, anche se come me estemporaneo, non poteva attendere reazione più gradita dal suo oggetto…omissis”.
Ma veniamo a “Er Ghinardo”, attorno al quale si intreccia l’ulteriore rapporto fra i due; dell’Arco rivolge anche a Pasolini l’invito a collaborare alla nuova rivista; l’altro accetta e gli invia il pezzo richiestogli, come risulta da questa lettera:
“Caro dell’Arco, ti mando per P.P.Trompeo, ben contento per l’invito, quattro poesie: qui a Casarsa sono estremamente solo, non ho nessuno a cui chiedere consiglio, quindi lascio a te o al Trompeo l’incarico della scelta. C’è anche il pezzo per “Er Ghinardo”, se ti sembra troppo lungo puoi farlo andare dalla crocetta (x) in giù … omissis…”.
La collaborazione fra i due artisti si intensifica e in quello stesso anno registra un altro episodio saliente: a settembre esce il terzo volumetto di poesie di dell’Arco, Ottave, con un’ampia introduzione a firma di Pasolini che ha piuttosto la densità di un saggio. Ne troviamo menzione in questo messaggio che Pasolini invia all’autore:
“Caro dell’Arco, incolpa la Biennale e gli scrutini per il mio lungo silenzio. Ho ricevuto ieri il tuo pacchetto di poemi, e senza averli letti (sono un lettore delicato e maniaco. Finché non avrò un giorno di calma, e sarà la prossima settimana, non potrò leggerti) accetto di farne l’introduzione, e commosso per la stima che così mi dimostri … omissis…”.
L’introduzione alle Ottave occupa le pagine da VII a XVII del volumetto, cui il poeta romano ha destinato sette dei suoi poemetti; la copertina ospita una illustrazione di Domenico Purificato sul tema dell’ultima ottava, La merca. Una volta stampato, dell’Arco si premura di inviare subito al collega friulano una copia del volumetto ed ecco come Pasolini riscontra l’invio:
“Caro dell’Arco, ho avuto il tuo delizioso volumetto e l’ho contemplato a lungo con l’avidità di un filatelico davanti a un francobollo splendido, oltreché raro. Rallegrati da parte mia con Purificato. L’uno o due tenui ritocchi al mio testo mi trovano del tutto consenziente. “Er Ghinardo” è in stato di floridezza e di grazia; nuovi rallegramenti…omissis…Saluti affettuosi dal tuo Pier Paolo Pasolini”.
Il 1948, anno di grazia nel rapporto fra i due, si chiude con un episodio tutto lirico, interno al piacere solidale di poetare in dialetto. Tra le poesie che dell’Arco aveva incluso ne La stella de carta era particolarmente piaciuta quella intitolata “Fine der monno”: qui il poeta s’era mostrato maestro nell’arte del togliere, raggiungendo una essenzialità che metteva in luce, forse per la prima volta, come la sua ispirazione sapesse volgere al drammatico, anzi al tragico. Il successo della composizione indusse dell’Arco a proporre ai poeti più rappresentativi delle varie aree dialettali di tradurla nei rispettivi idiomi. L’iniziativa “intedialettale” – come la chiamerà Baldini – trovò l’immediata adesione dei principali corrispondenti del poeta romano: l’abruzzese Vittorio Clemente, il genovese Edoardo Firpo, il còrso Petru Giovacchini, il napoletano E.A.Mario, il torinese Luigi Olivero e…. l’italiano Antonio Baldini.Non manca lo stesso Pasolini; tutte insieme, queste traduzioni vengono pubblicate a p.15 di “Er Ghinardo” n.4/1948 (ottobre).
Trascrivo il testo originale e quello friulano, quest’ultimo con le note esplicative aggiunte da Pasolini:
Fine der monno
Ommini, manco er seme.
Er prato, morto; l’arbero, scontorto;
e lucertole e passeri e farfalle
se so squaiate insieme. Er girasole
co le pennazze gialle
intorno all’occhio nero, aspetta er sole.
La fin dal mont
Si a pierdùt la siminsa dai òmis.
Muars i pras, cuntuàrs i paj.
E svampidis insièmit
sbìssis pavèis e pàssaris.
Il zirasòul
cu’i spilòcs zaj
atòr dal vuli neri
al speta il soreli.
<Svampidis>, lett. “Svanite, svaporate” / <Spilòcs>, più che “pennazze”, “pelacci”
Col trasferimento a Roma di Pasolini il rapporto fra i due artisti si fa più organico: e, tra l’altro, tramite dell’Arco Pasolini entra in contatto con Vittorio Clemente, antico collaboratore e amico del poeta romano, che gli troverà un posto nella scuola media parificata “Francesco Petrarca” in via Appia Pignatelli: una salvezza per il povero poeta esule. E da questo momento collaborazioni, recensioni e lavori a quattro mani si intrecciano, alimentando una stagione di riflessioni e studi sul problema del dialetto che fa di Roma in quegli anni il vero epicentro, il fecondo laboratorio dei dialetti d’Italia.
L’artista friulano ritorna sulle pagine di “Orazio” nel numero doppio (giugno-settembre 1952) che così il curatore annuncia: “ Il prossimo numero di Orazio sarà doppio e interamente dedicato al Belli, del quale sono annunciati i Sonetti romaneschi a cura di Giorgio Vigolo e per i tipi di Arnoldo Mondadori”.
L’annuncio dell’uscita del Vigolo suggella un evento memorabile nella bibliografia belliana: ed è proprio da questa fondamentale edizione dei sonetti belliani che dell’Arco – con opportuna tempestività – promuove il numero interamente dedicato al Poeta, lasciando allo stesso Vigolo il privilegio di aprire il fascicolo, con una prosa (“Se vuoi la pace, prepara il Belli”) in cui sono descritte la fatica e la soddisfazione di quella memorabile impresa (“lunga peripezia” la definisce).
Il fascicolo quadruplo contiene parecchie presenze di rilievo: accanto agli interventi di collaudati bellisti, di particolare interesse le testimonianze di due”alloglotti”, Sciascia e Pasolini, i cui scritti denotano la serietà delle loro frequentazioni belliane. La relazione fra i due registra un altro significativo episodio: il recupero di un brano espunto da Ragazzi di vita. Si tratta del frammento intitolato Rievocazioni del Riccetto che lo stesso dell’Arco così presenta nel numero di maggio del 1955 di “Orazio”: “Sotto il titolo Rievocazioni del Riccetto pubblichiamo in questo numero alcune pagine escluse dalla stesura definitiva di Ragazzi di vita, il romanzo di Pier Paolo Pasolini uscito in questi giorni per i tipi dell’editore Garzanti”.
Ma prima dell’approdo collaborativo a “il Belli”, resta da segnalare un altro importante capitolo che, assieme alle pagine definitive incluse nei saggi di Passione e ideologia, suggella il grande apprezzamento critico professato dal poeta friulano nei confronti di quello romano.Mi riferisco alla premessa che Pasolini scrive per l’ antologia curata da Leonardo Sciascia col titolo de Il fiore della poesia romanesca (1952), antologia nella quale, accanto a Belli, Pascarella e Trilussa, figura dell’Arco, al quale Pasolini e lo stesso curatore riservano elogi critici incondizionati.
Siamo così giunti al “referendum” pubblicato su “il Belli”.

Presenze pasoliniane su “il Belli”
Come accennato, nel nome di Belli prende il via nel dicembre 1952, cioè stesso mese ed anno della più volte citata antologia dell’Arco-Pasolini, l’ennesima iniziativa dellarchiana: una rivista intitolata appunto “il Belli”, che nel fondo di apertura (anno I, n.1, dicembre 1952) Trompeo definisce sinteticamente “una rivista figlia delle Muse, che raccoglie il meglio della poesia in dialetto e il meglio della relativa critica letteraria”.Fin troppo evidente che tale impostazione valorizza il grande lavoro di preparazione che Pasolini e dell’Arco avevano affrontato per la loro antologia: quel lavoro prosegue sulla nuova testata e spalanca al lettore panorami di inaspettata vitalità e vastità del fenomeno dialettale, affrontati con metodo critico e filologico.
La rivista durerà quattro anni (dicembre 1952-novembre 1955); successivamente volgerà in “quaderni di critica e poesia”, assumendo i tratti d’una vera e propria antologia, e col nuovo titolo di “Il nuovo Belli dei dialetti italiani” durerà fino al 1960.Promotori de “il Belli” sono, a ben vedere, gli stessi poeti, operanti nelle varie aree dialettali; a rileggere quell’elenco si ripassano nomi la maggior parte dei quali ha superato il vaglio del tempo e che oggi figurano nelle antologie. Essi sono Mario Boselli, Novella A.Cantarutti, Eugenio Cirese, Vittorio Clemente, Edoardo Firpo, Giacinto Gambirasio, Ettore Giuseppetti, Emilio Guicciardi, Cesare Mainardi, Biagio Marin, Domenico Naldini, P.P.Pasolini, Leonardo Sciascia, Aldo Spallicci, Vann’Antò, Cesare Vivaldi.
Il taglio interdialettale de “il Belli” e gli apparati biocritici (per solito sarà un dialettale che presenta un altro dialettale) con cui vengono presentate le poesie più recenti dei vari dialettali rendono la rivista particolarmente congeniale a Pasolini; la molteplicità e la mole dei suoi interventi lungo tutte e quattro le annate della rivista non consentono, in questa sede, una integrale riproduzione; mi limiterò pertanto a compilare una scheda riepilogativa degli scritti di – e talora su – Pasolini.
“ I l B e l l i “
Anno I, n.1 – dicembre 1952
Prima puntata del saggio “Pamphlet dialettale” (pp.5-7)
Avvio de “Il nostro referendum”, con le risposte di Aldo Spallicci (Forlì), Cesare Vivaldi (Imperia), Edoardo Firpo (Genova) e Emilio Guicciardi (Milano)
Schede di recensione dedicate a Puisiis di Novella A.Cantarutti; I canti dell’isola di Biagio Marin; Belfior di Emilio Guicciardi
Anno II, n.1 – febbraio 1953
Seconda puntata del saggio “Pamphlet dialettale” (pp.26-28)
Seconda puntata de “Il nostro referendum” con le risposte di E.Ferdinando Palmieri (Rovigo), Eugenio Cirese (Molise), Biagio Marin (Grado), Livio Rizzi (Rovigo), Vittorio Clemente (L’Aquila) e Novella A.Cantarutti (Spilimbergo)
Anno II, n.2 – maggio 1953
Conclusione de “Il nostro referendum” con le risposte di: Giacinto Gambirasio (Bergamo), Cesare Mainardi (Milano) e Antonio Guerra (S.Arcangelo di Romagna).
Segue una nota conclusiva di P.P.Pasolini (pp.45-46)
Scheda di recensione dedicata a I canti popolari del Molise di Eugenio Cinese
Anno II, n.3 – giugno 1953
Terza puntata del saggio “Pamphlet dialettale” (pp.55-56)
Schede di recensione dedicate a Villotte friulane di Giovanni Calabrò; ‘A lucerna di Feliciano De Cenzo; Memori d’on pivèll de settent’ann e poesie varie di Corradino Cim; I fiori di carta e Il nuovo mondo di Ernesto Calzavara; Poesie di Tolo Da Re
Anno II, n.4 – novembre 1953
Quarta puntata del saggio “Pamphlet dialettale”
Schede di recensione dedicate a Sto cuor fato cussì e La Marioneta di Gino Meneghel; E more l’ua sberlà da la tempesta di Quirino Sacchetti; Poesie dialettali di Carlo Turini; I brisul e Cun parmess di Vincenzo Strocchi; Sènere calde di Biagio Marin
Anno III, n.1 – marzo 1954
Appunto su Novella A.Cantarutti
Scheda di recensione dedicata a Miòdine di Carlo Alberto Zanazzo
Anno III, n.2 – giugno 1954
Il numero non contiene interventi di Pasolini, ma si segnala per uno scritto di Angelo Romanò, “Appunto su Pasolini”, seguito dalla poesia I Ciasaj in friulano (in calce la versione italiana).
Tra le schede di recensione ce n’è una anonima dedicata all’edizione 1954 del lunario friulano “Il Strolic furlan”
Anno III, n.3 – ottobre 1954
Articolo “Ognun che se esprime se perde” dedicato a Noventa
Postilla a una poesia di Carl Pettrich
Scheda di recensione dedicata a Lu beddu paisi di Liu Piazza Csaszar
Anno III, n.4 dicembre 1954
“Omaggio a Giotti”
Scheda di recensione dedicata a Lu pani si chiama pani di Ignazio Buttitta
Il numero contiene un articolo di Cesare Vivaldi “Nuovo linguaggio dei dialettali” dedicato a La meglio gioventù di Pasolini
Anno IV, n.1 – aprile 1955
N.N.
Anno IV, n.2 – luglio 1955
Contiene i saggi: “Poesia popolare còrsa” e “Vann’Antò traduttore di Eluard”
Anno IV, n.3 – novembre 1955
N.N.
In questo numero viene pubblicata una lettera aperta di Nino Buttitta, di critica all’articolo di Pasolini sulla poesia popolare còrsa.

Le risposte dei poeti
Premesso che le tre domande rivolte ai poeti erano
1.Perché scrivi in dialetto anziché nella lingua letteraria?
2.La tua poesia (secondo te) fa parte della letteratura italiana o di una letteratura regionale?
3.Supponi che ci siano delle speciali istanze di impegno sociale nell’uso del dialetto?
riproduco nell’ordine le risposte dei poeti.
Anno I, n.1 – dicembre 1952
ALDO SPALLICI, Forlì
1.Il dialetto è lingua del popolo fra cui son nato fra cui mi duole esser costretto a non vivere in continuità. Materna lingua con cui ho imparato a dar veste più opportuna al pensiero, cogliendone i tratti più espressivi e più aderenti alle cose ed agli stati d’animo. Musicalità, mutevolezza, suoni che è quello e solo quello e che non può trovarsi entro le pagine di un libro.. Non tutti possono avere la fortuna di vivere sulle rive dell’Arno. Studio attento occorre e orecchio vigile alla frase che coglie nel segno e che Carlo Porta andava cercando alla <scola de lengua del Verzèe> nella sua Milano.
2.La poesia, quando sia tale, non soffre aggettivi.
3.Lingua proletaria (il dialetto), lingua borghese o aristocratica (l’idioma nazionale)? All’abate Giordani che faceva tale distinzione rispose a proposito, per quanto un po’ grossolanamente, Carlo Porta.
CESARE VIVALDI, Imperia
1.2.3 Le tre domande sono a mio parere e per quanto mi riguarda così strettamente collegate che non posso non coordinarle in una unica risposta. Proprio la terza domanda infatti è quella che, almeno per il sottoscritto, fornisce la chiave della altre due. Né d’altra parte è possibile considerare il questionario che mi viene sottoposto come qualcosa volto ad un semplice soddisfacimento di curiosità, o come una indagine statistica cui si possa rispondere anche soltanto con affermazioni o negazioni, bensì come un serio invito ad una autocritica, nei limiti di spazio concessi, la più approfondita e serena possibile.
Debbo premettere che la mia opera di scrittore in versi si è prevalentemente esplicata in “lingua” e con obiettivi spiccatamente “sociali”, nel senso preciso che a questo aggettivo si dà parlando della poesia del nostro Risorgimento o, per fare un esempio più alto, di quella di un Petofi. Ma poiché i risultati raggiunti erano molto lontani – a motivo della loro “aulicità” e della loro lontananza dalla vita popolare , dal linguaggio e dalla realtà popolari – dal soddisfarmi, e poiché capivo che il problema di un nuovo realismo non poteva essere affrontato che partendo ab imis (e cioè da un punto diverso di visuale, più concreto, più umile, se vogliamo, di fronte alle contraddizioni della realtà, colte non tanto nei loro “gesti”, e quindi nella loro “retorica”, ma nella loro “quotidianità”), mi accorsi che questo non avrebbe potuto avvenire se non a prezzo di un mutamento radicale, mutamento nel quale anche la questione del linguaggio si poneva in termini nuovi.
Ciò avvenne nel 1951, ed appunto in quell’anno tentai un esperimento (lo chiamo così perché fallito nei suoi scopi principali) nel mio dialetto ligure. Furono otto poesie che pubblicai in volume nello stesso 1951 e che, prescindendo da ogni valutazione estetica, non portarono a grandi risultati. Anziché un approfondimento del linguaggio in senso popolare non ne sortì infatti che una serie di figure e paesaggi della nostalgia. In altri termini il poeta, anziché dominare il linguaggio dell’infanzia, ne era stato dominato. La cosa fu molto chiara quando, scrivendo nuovamente in “lingua”, mi avvidi di ricadere nei vecchi difetti. Ed oggi, sulle soglie del 1953 il problema è sostanzialmente rimasto nei suoi vecchi termini. Come risolverlo non posso dire perché io stesso lo ignoro. Ma se può interessare dirò che dopo la già fatta esperienza, mi propongo di tornare, con diverso impegno, all’uso del dialetto.
Ma con ciò mi avvedo di aver risposto alle due domande principali, la prima e la terza, e non alla seconda. Dal tenore del mio scritto penso però che i lettori non dureranno fatica a trovare la risposta mancante; comunque, per risparmiare loro una fatica, dirò che considero anche quanto ho scritto in dialetto come facente parte non di una letteratura regionale ma della letteratura nazionale, dato che non può essere dissociato dal complesso della mia opera quanto occorre al suo divenire.
EDOARDO FIRPO, Genova
1.Scrivo in dialetto perché è il mio mezzo espressivo più congeniale; perché sento in lingua genovese, “in za lengua zeneize”; perché le pietre, le torri, il mare, il vento tra i pini, mi parlano in genovese.
2.La mia poesia fa parte della poesia.
3.Non credo affatto.
DOMENICO NALDINI, Casarsa
1.Nella campagna friulana le prospettive di gelsi sono la visione più comune (antica misura e armonia del Friuli). I gelsi si chiamano “morars” e come “morars” sono vissuti nella coscienza dei friulani per secoli: in quella parola e in poche altre è gran parte della loro storia. Chiamandoli gelsi li renderei irriconoscibili e al di fuori di quella particolare storia (di uomini e cose insieme o di uomini attraverso cose) che cerco di riassumere in me. In genere l’uso del friulano mi ha permesso un rapporto più asciutto tra anima e cose, e di questa esperienza dialettale mi sono giovato poi nello scrivere qualche verso italiano.
2.Un grande fiume, il Tagliamento, divide il Friuli. “Di là da l’aga” c’è una tradizione letteraria che si vanta appunto regionale e alla quale non ho mai guardato. “Di cà da l’aga” c’è una lingua vergine con caratteristiche suggestivamente arcaiche, proprie, come insegnano i glottologi, delle aree marginali, dove l’alta aspirazione della poesia moderna alla verginità della parola si sarebbe potuta realizzare nell’uso cosciente di questa castissima lingua. Nel cuore dei parlanti friulano, “lingua meravigliosa, misteriosa di significati e suggestioni” come scrisse G. Raimondi, trasportato dall’esempio di un amico e maestro mi sono trovato a risentire le voci della poesia europea (da Leopardi a Penna, da Lorca a Jimenez letti questi ultimi nel vagheggiamento di una nuova e ancor segreta Andalusìa).
3.Speciali credo di sì. E mi pare derivi naturalmente da quello che ho cercato di dire nella prima risposta. Che queste istanze poi entrino in modo più o meno forte e dichiarato, oltre che dal temperamento del singolo poeta, mi pare dipenda dalla storia particolare della sua gente. Penso ai casolari inghiottiti dal fango nel Delta Padano e d’altra parte alle case odorose di latte e pavimenti immacolati dei friulani, fortunati e saggi piccoli imprenditori.
EMILIO GUICCIARDI, Milano
1.Sono ambidestro.
2.La poesia , per me, fa parte della “poetica” e non della geografia.
3.Di impegno sociale, no; di utilità sociale, forse, ma nel senso educativo e affettivo.
Anno II, n.1 – febbraio 1953
E .FERDINANDO PALMIERI,Rovigo
1.Mistero. Il mio dialetto mi è sempre garbato, e non mi è mai passato per la mente di scrivere un verso in lingua. Una volta, in lingua, ho composto una commedia; ma era, nel suo fondo, dialettale. Debbo aggiungere che ho sempre letto benissimo tutti i dialetti, e che nessuno mi ha mai impartito lezioni di napoletano o di milanese. Debbo anche aggiungere che “scrivevo”: acqua passata, insomma.
2.Fa parte della letteratura italiana. Come la brutta poesia scritta in lingua.
3. Sì. Ma la poesia “sociale” è quasi sempre la peggiore. Si tratta di versi che incitano alla fraternità e all’ottimismo e che sollecitano l’applauso del “buon cuore”. Naturalmente, non confondo le istanze sociali di Carlo Porta con quelle di certi poeti di oggi.
EUGENIO CIRESE, Molise
1.Il dialetto è una lingua. Perché possa essere mezzo di espressione poetica e trasformarsi in linguaggio e immagini è necessario possederla tutta; avere coscienza del suo contenuto di cultura e della sua umana forza espressiva. Nell’infanzia e nella prima giovinezza – o sia nel tempo più bello e più vivo d’interessi della mia vita – ho parlato, raccolto e cantato canzoni, gioito, pianto, pensato in dialetto.Non sto qui a sostenere la maggiore efficacia espressiva del dialetto sulla lingua letteraria – luogo comune non serio, perché ogni lingua ha pienezza ed efficacia di forme – dico solo che il possesso del dialetto agevola la ricerca e l’articolazione di forme in atteggiamenti efficaci e immagini proprie; accresce insomma la possibilità di dare – e questa è per me l’esigenza vitale della poesia dialettale – qualche cosa di nuovo a se stessa e, perché no?, alla lingua letteraria. Aggiungo che il dialetto è sempre stato il luogo del mio respiro: quando mi trovai a cantare l’amore, nato e patito sotto le finestre e sulla aie; ora che il ricordo giunge a farsi memoria tutto solo perché tante cose ha lasciate per la via.
2.Se è poesia, non può soffrire limiti né avere confini.
3.Ci sono, sì, anche se non intenzionali. Se no si dovrebbe negare alla poesia un pensiero, ossia un contenuto. Nel dialetto poi, mi pare ci sia un più diretto legame con il mondo dei semplici e degli “umili”: a loro più che a noi appartiene lo strumento espressivo di cui il poeta si serve, e al loro mondo, sia pure trasfigurandolo, rimane pur sempre legato.
BIAGIO MARIN, Grado
1.Scrivo in dialetto perché è il linguaggio più aderente al mio mondo d’origine e alla mia anima che di quel mondo s’è nutrita e incantata.
2.Penso che la poesia non possa essere che universalità sub specie aesthetica e quindi che, se i miei versi hanno raggiunto la poesia, e in quanto possono averla raggiunta, appartengono alla letteratura nazionale. Non si dovrebbe mai dimenticare che tutta la poesia greca era poesia “dialettale”.
3.Per me, personalmente, è stato vivo e presente il desiderio di parlare alla gente della mia isola, per rivelare loro il loro mondo e la loro anima.
LIVIO RIZZI, Rovigo
1.Ecco, quando scrivo, o meglio, quando scrivevo in lingua ero come uno che indossasse un vestito non fatto sulle sue misure. Ora, invece, col dialetto, l’abito mi va a pennello.
2.Secondo me la mia poesia fa parte di una letteratura regionale, perché oltre che avere riferimenti esclusivamente regionali, oltre che muoversi in paesaggi strettamente regionali e dare voce regionale a persone e cose, vive entro determinati limiti chiusi da ben definiti confini. Dirò di più: la mia poesia è soprattutto provinciale nel senso che il suo mondo è circoscritto quasi sempre dall’Adige e dal Po.
3.Naturalmente. Nell’uso del dialetto ci sono delle speciali istanze di impegno sociale. Perché solo col dialetto e, dirò meglio, soprattutto col dialetto si può rappresentare lo stato d’animo particolare di una gente e di un paese.
VITTORIO CLEMENTE, Bagnara (L’Aquila)
1.Scrivo in dialetto per mio naturale bisogno espressivo. Io mi sento intimamente inserito nella mia terra abruzzese e, quanto più ne vivo fisicamente lontano e quanto più la lontananza aumenta nel tempo e nello spazio, sento che il mio linguaggio si fa di più ed essenzialmente abruzzese.
2.C’è la poesia e ci sono i poeti; per me non ci sono province poetiche, né definizioni della poesia. Il poeta crea sempre un suo linguaggio – semantica, morfologia, sintassi – che, perciò, è poeticamente e sempre trasparente, ossia immediato nei significati. Qualunque sia la forma che il linguaggio possa assumere, quando esso è coerente con la ispirazione, il significato poetico è sempre comprensibile, anche se, in parte o in tutto, dovessero sfuggire le accezioni particolaristiche delle parole.
3.Il dialetto è un linguaggio e come linguaggio può assurgere ad espressione, ossia ad arte. Ora tanto il linguaggio che l’arte hanno un loro innegabile valore sociale; ma se si volesse spiegare tale implicito valore del linguaggio e dell’arte in base a particolari e pratici impegni è chiaro che non si dovrebbe più parlare di poesia (almeno come la intendo io).
NOVELLA A. CANTARUTTI, Spilimbergo
1.Mi spinge a scrivere in friulano un’esigenza di fedeltà. Se usassi la lingua italiana, tale fedeltà verrebbe meno, nel senso che uno sforzo di traduzione si inserirebbe tra l’istanza lirica e la parola, frangendone l’intimo rapporto.
2. Non so dove collocare la mia poesia: è nata senza propositi, al di fuori di ogni scuola, sorretta da un’esigenza di purezza.Appaio legata alla recente letteratura friulana non tanto per presupposti comuni, quanto per risultati affini. Sento la mia poesia friulana perché è scritta, con amore, nella mia parlata e perché, in ultima analisi, godo di dare una dimostrazione delle possibilità della parlata stessa. All’infuori di queste ragioni, credo (e tengo ben presenti i miei limiti) che potrei chiedere asilo a più d’una letteratura d’oggi.
3.Non comprendo l’esatto significato che si vuol dare all’espressione “impegno sociale”. Se si intende la celebrazione, attraverso la poesia, di una unità linguistica e perciò storica, ritengo che tale impegno non sia assente in chi usa il dialetto; non l’ho mai sentito come motivo determinante la mia poesia.
Anno II, n.2 – maggio 1953
Pasolini introduce l’ultima puntata dell’inchiesta con questo titolo: “Conclusione del nostro referendum”.
GIACINTO GAMBIRASIO, Bergamo
1.Scrivo in dialetto, perché penso in dialetto. Il dialetto è la lingua che io ho appreso, da bambino, dalle labbra della mamma. Lo scrivere in lingua italiana importa sempre per me un sia pur lieve sforzo di traduzione. Confesso inoltre modestamente che il possesso della lingua non è per me così completo come quello del dialetto.
2.Ritengo che tutti i dialetti italiani abbiano legittimi titoli per entrare nella letteratura italiana. La letteratura italiana, secondo me, non deve intendersi limitata alla forma (lingua) con la quale viene espresso il pensiero, ma piuttosto estendersi alla sostanza ed alle caratteristiche del pensiero. Così non dovrebbe essere dubbio che anche gli scritti nei diversi dialetti italiani, quando riflettano idee e sensazioni di individui appartenenti alla nazione italiana, non appartengano propriamente alla letteratura italiana.
3.Credo per certo che il dialetto, per essere più accessibile alle masse delle rispettive regioni e provincie, possa ottenere effetti più sicuri e immediati, di educazione e di elevamento sociale.
CESARE MAINARDI, Milano
1.Se scrivo versi mi viene più facile il dialetto, così come mi viene più spontanea la lingua letteraria se scrivo prosa. Aggiungi che pur considerando il dialetto un mezzo di espressione non meno degno della lingua letteraria, esso non mi infonde quella reverenza né mi incute quel timore reverenziale che la lingua mi dà per la poesia. Il vernacolo è per me un vecchio amico, alla buona, alla mano, tollerante, quasi, al quale mi pare di poter confidare anche pensieri che forse non confiderei alla “madre nobile”. Infine scrivo in dialetto, e ciò vale in riguardo al “mio” dialetto, per contribuire nell’ambito delle mie possibilità a liberare la poesia milanese dall’ingiusta accusa, che le viene fatta, di amare solo le espressioni volgari o triviali, e per alleviarla dal giusto carico, che le è addebitato, di troppo indulgere a modesti pensieri di pura occasionalità e a stucchevoli motivi di campanilismo o di retorica stracittadina.
2.Ciò malgrado, ritengo che la mia poesia possa far parte della letteratura italiana in quanto esula da essa ogni carattere di voluta regionalità o di ricerca coloristica o di compiacenze puramente lombarde. Il pensiero non è mai suggerito né l’estro è mai sollecitato dal mio esser nato milanese, dal mio abitare Milano, dal mio discender lombardo. Scriverei le stesse cose se fossi romano o abruzzese.
3.Direi di sì, poiché, al di sopra di ogni regionalismo politico o amministrativo, sono convinto che se l’uso del dialetto contribuisce difficilmente alla fusione delle classi sociali (il cui distacco e il cui attrito sono dovuti a fattori economici), giova tuttavia ad una meno disagevole reciproca comprensione. Qualche volta, anche in momenti gravi, l’uso dello stesso mezzo espressivo è, o può essere, un motivo di meno aspra frizione, forse di una tal quale sopportazione vicendevole. Penso pure che sia un discapito per il “maggiore” non saper parlare la lingua del “minore”, intesi naturalmente “maggiore” e “minore” cum grano salis. Ritengo infine che i vernacoli siano sempre una purissima fonte di integre tradizioni e di operanti riferimenti al passato collettivo di una intera regione, quando non di una discendenza etnica. La fonte va tenuta il più possibile limpida poiché essa alimenta lo spirito dei singoli e delle masse. Se essa è inevitabilmente destinata ad alterarsi, facciamo che ciò avvenga senza danni, vale a dire senza scatti, senza urti, senza violenza; ma solo attraverso un processo di lentissima evoluzione, quell’evoluzione che può modificare i dialetti (non mummifichiamoli, per carità!), ma non li deve uccidere.

ANTONIO GUERRA, Sant’Arcangelo di Romagna
1.Mi pare che il dialetto sia più aderente a quello che voglio dire. Lo sento molto di più. Contribuirà anche il fatto che fin da piccolo ho sempre pensato in dialetto, mia mamma mi ha sempre parlato in dialetto e tutta la gente mi ha raccontato le sue storie e le sue pene in dialetto.
2.Per quanto riguarda la seconda domanda vorrei rispondere indirettamente. Io penso che tutte le buone poesie in dialetto facciano parte della letteratura nazionale. Bisogna vedere quindi se le mie poesie sono belle.
3.No. Oppure ci sono come nei componimenti in lingua.
Le conclusioni di Pasolini
Giunto al termine della sua inchiesta, Pasolini compila la seguente nota conclusiva:
“1. In genere il dialettale sceglierebbe il dialetto perché mezzo espressivo immediato, ma in accezione di “materno”, “spontaneo” ecc. (Spallicci, Firpo, Cinese – con modificazione nel senso dell’infanzia e della memoria – Marin – immediato come “aderente al mondo d’origine”, con dunque più chiaro riferimento alla nostalgia – Rizzi, Clemente, la Cantarutti – immediato in accezione di fedele alle cose, e quindi assoluto – Guerra, Gambirasio).
Fanno eccezione Vivaldi, che usa il dialetto perché più atto a un avvicinamento al modulo della poesia impegnata in un ideale sociale; Naldini, che se ne serve perché unico modo di “conoscenza” di un mondo altamente “georgico” con una storia identificata coi suoi effetti poetici; Guicciardi che sfugge alla domanda dichiarandosi “ambidestro” (ma non sfugge alla deduzione che, così, lo segna in margine all’espressionismo lombardo-tessiano: espressione per l’espressione); Palmieri che sfodera il più brillante agnosticismo (brillante in quanto spregiudicata presa di coscienza di un atto irrazionale), Mainardi, che, sia pure con modesta approssimazione, tocca ll punctum dolens, ossia la fuga “reverenziale” dalla lingua , con conseguente polemica.
Statistica: almeno nella coscienza critica, che non dà limpressione d’essere fortissima, nove su quattordici sono i dialettali operanti su una linea romantica, davvero stupefacente date la spontaneità in sede stilistica e l’accezione piuttosto anacronistica di “popolo” ch’essa presuppone. (A voler essere sinceri coi nostri amici diremmo che la sincerità ha fatto loro un poco difetto, o che perlomeno non hanno interamente ripensato una loro prima, ovvia, e un po’ scolastica ragione della scrittura dialettale). Due su quattordici hanno superato la discutibile remora dell’immediatezza materno-ambientale ecc., per una ragione socialistica (Vivaldi) o di pan-poeticismo (Naldini). Uno (Palmieri) è agnostico; uno (Guicciardi) indifferente.
2. La seconda domanda. Era un’articolazione della prima: un suo duplicato su scala non più psicologico-estetica ma storica. In genere non è stata “sentita”; e anzi, per la verità, abbiamo ricevuto una severa lezione di crocianesimo,se la tangente per cui i nostri amici son sfuggiti alla domanda era la distinzione poesia-letteratura. Era evidente però ch’essi, se non altro per modestia, avrebbero dovuto collocare la loro opera nella sfera della letteratura, non della poesia…Invece, con protasi a fior di labbra, gli ipotetici delle risposte corrispondono in genere al tipo della realtà. “La poesia, quando sia tale, non soffre aggettivi” risponde Spallicci; “La poesia per me fa parte della poetica non della geografia” esclama Guicciardi; “Se è poesia – dice Cirese – non può soffrire limite né avere confini”. E, sulla stessa linea, Clemente e la Cantarutti,
Vivaldi , Palmieri, Marin (“non si dovrebbe mai dimenticare che tutta la poesia greca era poesia dialettale”), Mainardi, Guerra, Gambirasio, fanno rientrare la loro produzione dialettale nella letteratura nazionale; Naldini, abolendo ogni regionalismo convenzionale, pensa per il Friuli a una simbolica e assoluta Andalusia lorchiana, cioè lo immette in una civiltà letteraria europea. Uno solo, Rizzi, coraggiosamente parla di limite regionale, anzi, provinciale, della sua poesia.
Al lettore la dimidiante statistica e i raffronti tra le concomitanze nella prima risposta e le divergenze nella seconda: con progressione feconda di contraddizioni.
3. La terza era la domanda più scottante, e ha, nel liquido per prudenza un po’amorfo, operato delle colorite precipitazioni.Spallicci non vuol sentir parlare di distinzioni tra lingua proletaria (il dialetto) e lingua borghese (la koinè nazionale); e così Firpo, Guicciardi, Clemente, Guerra.Di coloro che rispondono “sì”: Vivaldi intende l’impegno sociale nel senso più moderno e attuale della parola (base marxistica con le speciali varianti di questo dopoguerra); Naldini ne è a conoscenza ma lo dilata verso la sua poetizzazione di un mondo contadino in cui le stesse condizioni economiche divengono”poetiche”; Palmieri ha di questo “engagement” un’idea pessimistica, ne dà un’accezione conviviale e progressistica di tipo pre-fascista (o dell’antifascismo delle barzellette), Cirese è tra Vivaldi e Naldini, il suo socialismo è di vecchio stampo, tra umanistico e romantico, ha il buon sapore di certa vita italiana rimasta aurorale nel primo Novecento; anche per Marin l’istanza sociale è di tipo romantico: conoscenza di un mondo popolare e sua fine innografia, al di fuori della politica: idem Rizzi, mentre i due lombardi Mainardi e Gambirasio, ma anche Guicciardi, di sfuggita (il moralismo portiano-manzoniano, la dignità della borghesia padana, la psicologia etnica lombarda…) propendono per un’efficacia propedeutica, di educazione del popolo attraverso un mezzo espressivo a lui familiare e in certo modo volgarizzatore di sentimenti “elevati” che son appannaggio della borghesia.
Non si può calcolare, dalle risposte non certo impegnatissime di questi quattordici poeti (e dovrebbero essere almeno una quarantina per rappresentare l’intero schieramento peninsulare) quale sia la situazione della poesia dialettale in questo momento. Si ha l’impressione che sia di transizione: da un romanticismo antiquato e provinciale a un romanticismo per così dire para e post ermetico, da un realismo bozzettistico e populista a un realismo “poetico” e politicamente impegnato”.
* * * *
La contenuta dimensione del “campione” di poeti che hanno risposto al “referendum” induce Pasolini a una cauta conclusione: ma la sua prudenza non fa aggio sulla lucidità del giudizio che formula sulle linee di tendenza del fenomeno.Non diversamente dalle impressioni che aveva manifestato il suo maestro Contini (qui citate nell'”Antefatto”) egli intravede un orientamento della poesia dialettale verso la lirica “pura”: la progressiva attenuazione del “romanticismo antiquato e provinciale” così come di un “realismo bozzettistico e populista” riscatterà la poesia dialettale, riconciliandola con il “canto”.
Se il Pasolini ideologo fa una concessione a personali istanze è nella previsione che il realismo poetico tout court di cui egli avverte l’affermazione sia politicamente impegnato. Ma, ancora una volta, dobbiamo contestualizzare questa analisi, riferendola al clima dei primi anni Cinquanta. Merito non secondario della sua inchiesta e di tutte le altre iniziative intraprese all’epoca, da solo o con Mario dell’Arco, è quello di aver contribuito a una piena legittimazione della letteratura dialettale, anche con strumenti – come questo “referendum” – utili a rinsaldare coscienza e autostima degli “amici” (come lui chiama i poeti intervistati).Possiamo altresì constatare quanto felice sia stata la scelta da lui compiuta nel selezionare i poeti interpellati: con poche eccezioni, ritroviamo quei nomi nella già citata antologia di Brevini; un bel risultato critico, se consideriamo che cinquanta anni separano il suo lavoro (1952) da quello di Brevini (1992).
Segno anche che la contiguità temporale non gli impediva di identificare le voci migliori della lirica in dialetto.Sono queste alcune delle ragioni che mi hanno suggerito di recuperare il testo del “referendum” pasoliniano, di fatto sconosciuto in quanto pubblicato su una rivista (“il Belli”) la cui circolazione non poteva non essere- all’epoca – che circoscritta agli “addetti ai lavori”. Tali “puntate”, assieme al testo dello scritto “Taccuino di un dialettale” ci consentono di constatare che il laboratorio dialettologico pasoliniano risulta essere, anche in un caso, come questo, di iniziativa giornalistica, non meno fecondo di altri suoi momenti di più approfondita riflessione critica.
[info_box title=”Franco Onorati” image=”” animate=””]giornalista pubblicista e direttore responsabile della rivista «il 996», edita dal Centro Studi “Giuseppe Gioachino Belli” del quale è socio, ha pubblicato, tra l’altro, Libiamo libiamo. Trasgressioni conviviali nell’opera lirica e dintorni (1987); Le lingue della realtà (1993); Strenna per Mario dell’Arco (1955); A teatro col Belli. Il sublime ridicolo del melodramma nei sonetti romaneschi (1996). Ricorrendo il centenario della nascita di Mario dell’Arco (1905-1996), ha promosso un convegno di studi a lui dedicato, i cui atti ha poi curato per le Edizioni Gangemi (2006). Ha presentato al Convegno Gli Scrittori stranieri raccontano Roma(Roma 13-15 maggio 2006) la relazione “Da Berlioz a Wagner. Roma nelle lettere e nelle musiche dei compositori stranieri” . Vicepresidente del “Gruppo dei Romanisti”, collabora alla redazione della Strenna dei Romanisti. Alla Strenna destina saggi sui soggiorni romani di musicisti italiani e stranieri.[/info_box]



