Tre scrittori hanno dedicato in anni recenti i loro libri a Pier Paolo Pasolini “calciatore”. Ecco le schede, talora corredate da recensioni.
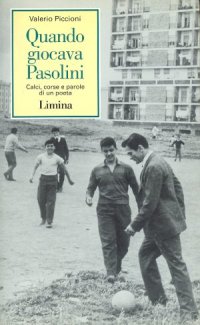
Valerio Piccioni
Quando giocava Pasolini. Calci, corse e parole di un poeta
Limina Edizioni, Arezzo 1996
È la prima biografia-antologia di un Pasolini pressoché inedito, quello che amava e viveva lo sport con la passione di un ragazzo di borgata e la complessità di un intellettuale raffinato.
I calci svogliati dei «ragazzi di vita» nella Roma più periferica, l’antipatia per Benvenuti, la polemica antinazionalista con Arpino, la commozione in diretta tv per il racconto di Vito Taccone, la corte vana a Carlos Monzon mai diventato Yunan nel Fiore delle Mille e una notte, le risposte in monosillabi dei giocatori del Bologna alle sue domande sul sesso in Comizi d’amore, la scelta del saltatore Giuseppe Gentile per il Giasone del suo film Medea.
E poi il gioco del calcio con le sue molteplici forme letterarie: gli elzeviri di Rivera e Mazzola, la poesia di Corso e Riva, la prosa di Bulgarelli. Un lungo viaggio attraverso i romanzi, gli articoli, le interviste, le poesie.
Valerio Piccioni, giornalista, nel 1983 segue i Mondiali di atletica in Scandinavia per «Paese Sera», dove ha cominciato la sua carriera. Dal 1990 lavora a «La Gazzetta dello Sport». Ha seguito più volte il Giro d’Italia e il Tour de France. Letteratura e sport sono tra le parole che ama di più: tutto questo ha reso inevitabile il suo incontro con Pier Paolo Pasolini.
Una recensione
Quando giocava Pasolini…
di Giancarlo Susanna
www.pasolini.net
“Pasolini mangiava poco,” scrive Piccioni, “non beveva alcolici, non fumava. Era un uomo sportivo nel vero senso della parola. L’abitudine al moto, alla corsa, era nata spontanea nella sua infanzia itinerante, rafforzata dalle successive, diverse gioventù: quella ludico-vacanziera del Friuli e quella liceale-universitaria di Bologna”. E Ninetto Davoli ricorda in un’altra pagina: “Lo chiamavamo Stukas per quel suo modo di scattare sulla fascia e quella corsa bruciante. Nelle partite che giocavamo, lui era quasi sempre il più in forma. Aveva un fisico perfetto, nerboruto, mai un chilo di troppo addosso. A pallone era come un ragazzino, uno di noi. Il calcio era il suo sport preferito; dopo veniva la boxe, anche se non frequentava il ring come gli stadi”.
Seguendo il filo critico-narrativo dello sport nella scrittura e nella vita di Pasolini – dal pallone sempre presente in Ragazzi di vita e in Una vita violenta all’intervista ai giocatori del Bologna in Comizi d’amore, dalle partitelle sui campi di periferia a quelle con la nazionale dello spettacolo, dalla polemica sulle “mille coree” augurate alla nazionale italiana con Arpino all’intervento sul ciclismo nel Processo alla Tappa di Zavoli -, Piccioni traccia dello scrittore un ritratto vivido e brillante.Tanto più interessante perché diretto (Pasolini ci parla attraverso i suoi scritti ) e corale (gli interventi di quelli che gli erano amici o l’hanno incontrato sono illuminanti).
Piccioni raccoglie una nutrita serie di testimonianze dell’epoca: articoli, interviste e voci si dipanano a sostegno di una tesi che si chiarisce nelle ultime battute del libro: “Certo il Pasolini calciatore sorrideva di più, si divertiva di più, scherzava di più di altri Pasolini. Però il suo calcio, partite su partite, gol che non arrivano, arrabbiature che non finiscono con un’azione di gioco, somiglia ad altri Pasolini, perennemente alla ricerca di qualcosa che sfugge, che scappa via: un linguaggio, una strada per comunicare, un genere umano. L’amico pallone lo aiuta più di tanti altri: qui non c’è nessuna abiura, nessuna resa. Poi l’ultimo viaggio verso l’ultimo campo.

Ugo Riccarelli
L’angelo di Coppi
Mondadori, Milano 2001
Storia e fantasia, magia e poesia sono gli ingredienti sapientemente dosati da Ugo Riccarelli nel suo libro. Dieci storie ispirate al mondo dello sport; momenti importanti, veri o sognati, ci narrano storie sconosciute o riportano all’attualità personaggi quasi dimenticati: un magnifico modo per raccontare la grandezza e la debolezza degli uomini, i loro sogni e le loro ossessioni. Il decimo racconto ( in cui Ricciarelli descrive le partite di calcio di Pier Paolo Pasolini, scrittore, poeta, regista e ideatore oltre che allenatore del “Caos” di Monteverde, una squadra di borgata che parla in romanesco e che più che in una partita sembra impegnata in una rissa, tra maledizioni e bestemmie, ma che, conquistata dal fascino di Pasolini, riesce a diventare una vera squadra) rappresenta la parte più dolce e commovente del libro ed è la descrizione di un momento di incontro tra sport e cultura in cui molti ancora si rifiutano di credere.
Ugo Riccarelli è nato a Ciriè (Torino) nel 1954 da famiglia toscana. Vive e lavora a Pisa. Ha pubblicato Le scarpe appese al cuore (Feltrinelli, 1995: premio Chianti; ora nella collezione Oscar Mondadori), Un uomo che forse si chiamava Shulz (Piemme, 1998; selezione premio Campiello, Prix Wizo Européen), Stramonio (Piemme 2000; premio Pisa) e Il dolore perfetto (Mondadori, 2004; premio Strega).
A Pa’
di Ugo Riccarelli
(da L’angelo di Coppi di Ugo Riccarelli, Oscar Mondadori, Milano 2004)
Io penso che ci si debba spendere fino all’ultimo, e che quindi si debba anche sbagliare.
Pier Paolo Pasolini
Il pomeriggio del 4 luglio 1954 Pier Paolo Pasolini uscì di casa alle tre esatte. Il sole picchiava su Roma e scioglieva le figure dei pochi passanti rendendoli inquietanti fantasmi diurni. L’aria era immobile, silente, e in quel momento egli pensò che non sarebbe mai più accaduto niente, il mondo pareva essersi fermato dopo un’esplosione nucleare, bollito dal calore di una bomba che aveva liquefatto la vita come fosse un ghiacciolo.
Rasente i muri, sfruttando le rare lame d’ombra, Pasolini risalì via Ostiense, dietro la centrale, dove gli scheletri dei palazzi in costruzione parevano vele alzate contro un vento inesistente. Andando verso di loro la strada si fece sterrata, piena di sassi e polvere. Una sottile patina rosa che copriva come borotalco le cose. Accanto al primo palazzo, quello più grande, un cumulo di macerie alto come un monte nascondeva la buca di uno scavo, le fondamenta nuove di un altro casone, un altro dente cariato sulla terra. Era domenica e il cantiere deserto. Tutto sembrava fermo e sospeso. Una tregua – Pasolini pensò -, oggi non c’è guerra.
Ma, mentre considerava quel silenzio guardando la città nascere dal nulla, sentì all’improvviso un richiamo soffocato, gridato a denti stretti come per non disturbare.
«A Spì datte ‘na mossa che qua vie’ nnotte se nun fai de prescia» disse la voce che gli sembrò di uomo anziano. «Allungame la robba e famo presto… »
Pasolini salì sulle macerie, attento a non far rumore. Si sdraiò sulla cima del monticello e cominciò a sbirciare.
Faccio come gli Indiani, pensò quasi stesse giocando. Guardo senza farmi vedere, rimango ad ascoltare.
Al limite del grande buco iniziava la recinzione del cantiere, una serie di pali di legno e di lamiere delimitavano la parte in costruzione. Poco più in basso del punto da dove lui guardava, nella lastra di metallo c’era un buco, come un’orecchia di carta all’angolo di un foglio. Accanto a quella breccia un carretto e un uomo grosso come un armadio, in canottiera. L’uomo era certo quello che aveva parlato e stava di spalle, ma anche se era girato dava mostra di essere nervoso e in apprensione. Si guardava attorno impaziente, con una mano si picchiava sulla coscia e con l’altra continuava a lisciarsi il velo di barba, quasi volesse darsi una carezza e rassicurarsi, tormentandosi la faccia per dirsi “non ti tormentare”.
Dopo pochi minuti da dietro la lamiera si sentì un rumore, qualcosa strisciare, quindi un fischio leggero, come se un passerotto avesse cominciato all’improvviso il canto. A quel suono l’uomo fece uno scatto e si abbassò verso il pertugio, poi prese qualcosa e cominciò a tirare. Come un prestigiatore, di colpo, gli apparve tra le mani una grossa sbarra di ferro, che con molta cautela posò sul carretto che gli stava accanto.
«Vabbene così, Spì» gridò nel buco a mezza voce, “butta pure tutto quanto, che ppoi se n’annamo via come du’ sospiri.»
Dall’altra parte della recinzione qualcuno continuò a passare travi di legno, tondini, materiale da costruzione, e in pochi minuti fu tutto caricato. Allora l’uomo disse solo «Daje», cominciando a muovere il carretto verso la strada. Passò sotto il monticello dove Pasolini, pur acquattato, vide chiaramente il sudore colargli dalla fronte, i muscoli rotondi e gonfi per lo sforzo. Rimase a guardarlo fino a che scomparve dietro l’angolo giù in fondo, sparire dentro il mondo senza rimorso.
Quando si voltò verso la lamiera, un ragazzetto se ne stava seduto accanto al buco. Avrà avuto dodici anni, sì e no, magro e sudato, e aveva la testa appoggiata contro il petto come se si fosse all’improvviso addormentato.
Pasolini rimase a guardarlo per qualche minuto pensando che non fosse cosa saggia starsene in quel modo, all’aperto, sul luogo di un furto appena commesso. Inoltre era un po’ preoccupato nel vederlo immobile, la schiena contro la lamiera, la testa abbandonata di una persona che pareva arresa. Pensò che potesse aver bisogno di aiuto e si fece avanti. Scese dalla collinetta, si pulì i calzoni strisciando il palmo della mano sulle gambe, poi girò attorno alle macerie e andò verso il ragazzo. Camminava leggero, andava cauto, convinto che quello sarebbe schizzato come un razzo vedendo arrivare uno sconosciuto. Il furto compiuto, la cattiva coscienza, normalmente avrebbero suggerito una fuga. Invece non dette segno di preoccupazione. Al rumore dei passi sulla ghiaia alzò di appena qualche centimetro la testa, sbirciò di sotto in su verso quel rumore, e poi riabbassò il capo contro il petto.
Pasolini gli arrivò di fronte, ritto in piedi, rimase interdetto non sapendo in quel momento cosa fare. Allora gli si sedette accanto, contro la lamiera, e a così poca distanza da lui comprese tutto. Sentì da dentro quel torace salire un raschiare sordo, lo stesso respiro aspro e tirato di uno che cerchi l’aria con fatica. La maglietta a righe era zuppa di sudore, gli stava appiccicata mettendo in risalto le costole sul fianco. Il cuore gli si strinse, ebbe paura che quel ragazzino magro e lungo si spezzasse davanti a lui come un grissino.
«Va tutto bene?» gli domandò allora.
Il ragazzo fece sì col capo, un paio di volte.
«È cche ci ho l’asma e nun respiro» disse. «Cor caldo e ‘sta polvere poi è ‘na traggedia. Me pija, e cce sta un po’, ma doppo passa.»
«Forse hai fatto uno sforzo troppo grande. Era roba pesante e con questa calura si respira male anche a star fermi» disse Pasolini senza malizia, con il tono di voce giusto per fargli sapere che lui aveva visto ma non si doveva preoccupare.
Il ragazzo infatti non ebbe reazione. Continuò a rimanere fermo, ad ansimare con quel suono aspro che però andava scemando. Rimasero così, in quella quiete rotta soltanto dal raschiare del respiro, finché anche quello sparì del tutto e fu silenzio.
«Ma tu che ccerchi qua? Che stai a spia’ la ggente che lavora?» fece il ragazzo, ma con un mezzo sorriso come a fargli capire che fidarsi si fidava, ma stava in guardia.
«Non cerco niente, andavo in giro» disse Pasolini ricambiando il sorriso. «Mi piace girellare tra i palazzi in costruzione, guardare come è qui, adesso, e pensare come era, e come sarà quando tutto sarà stato. Giro coi miei pensieri e poi spesso ho belle sorprese. Case sorte dal nulla, strani paesaggi, gente che arriva a vivere qui, incontri nuovi. A volte trovo qualcosa che non mi aspettavo. Come per esempio oggi te, che… lavoravi.»
«Ecche cce fai co’ sta robba? Io armeno cor fero ce campo. Riempo er caretto der Pazzo e faccio i sordi, che senza le lire nun se magna» disse il ragazzo in modo deciso, lo sguardo piantato negli occhi dell’altro, come a spiegargli una cosa naturale che solo lui, sventato, non sapesse, qualcosa che certamente non sapeva fare.
Pasolini rimase colpito dallo sguardo, dalla decisione, dalla forza che quello scricciolo sprigionava. In quel momento gli parve davvero di essere vivo, tra la polvere e i fantasmi dei palazzi qualcuno gli insegnava quello che altrimenti non si può imparare. Quello che è brutto e bello, quello che puzza e profuma, che vive eppure fatica a respirare. Così non disse nulla, allargò solo un sorriso e appoggiò la testa contro la lamiera lasciando che il caldo gli coprisse le guance, gli avvolgesse il collo e le spalle in una carezza totale.
«Comunque, io so’ Renatino, ma tutti me dicono Spino perché so’ mmagro e pungo, nun so’ se me spiego» disse il ragazzo allungando la mano. «E io mi chiamo Pier Paolo, ma chiamami pure come ti pare», rispose Pasolini ricambiando una stretta forte e sudata.
Fu così che nacque l’amicizia tra Pasolini e Renato Panizza, detto Spino, in un giorno di un luglio infame di caldo, con i soli palazzi in costruzione testimoni di quella conoscenza tra un poeta e un ragazzino.
Parlarono molto, quel pomeriggio, della famiglia di Spino, di origine abruzzese, venuta a Roma per vivere meglio di quanto potesse fare in campagna, dove abitava, a Monteverde in un casermone, del fiato che gli mancava a causa del cemento e della passione sua, il calcio, che giocava a fatica per quel respiro mozzo che non lo lasciava in pace. Scoprirono in quel modo cose comuni, strane per due persone a prima vista tanto diverse. Anche il poeta amava il pallone, amava giocare, e con il ragazzino intavolò una lunga discussione sul football, su squadre e formazioni, su come si deve impostare il gioco in contropiede.
Un paio di ore più tardi, il sole un po’ più basso, Spino chiese a Pier Paolo se avesse nient’altro da fare, se avesse voglia di accompagnarlo verso Monteverde, dietro i casermoni, dove in mezzo ai palazzi in costruzione aveva un appuntamento con la sua banda. Catena, er Manetta, Montesano, e tutti gli altri con cui aveva fissato una partita.
«Ben volentieri, Spino, ma a una condizione: che possa giocare anch’io. Io sono bravo. Sono un’ala sinistra eccezionale. Lo sai fare tu il doppio passo alla Biavati?» e mentre parlava si era già alzato, aveva agganciato un pallone immaginario e con il piede gli aveva dato una carezza, poi era corso in avanti danzando in leggerezza con una rapida mossa di gambe, un ritmo binario concluso con un tiro potente a un sassetto, verso la lamiera che risuonò come un gong cinese.
«Ammazza Pa’, quanto sei gajardo. Ma ‘ste cose le devi da fa’ cor pallone, che a gioca’ coll’aria so’ capaci tutti. Annamo va’, che è tardi, movete er culo…»
Arrivarono a Monteverde, sullo spiazzo, che già il pallone girava tra le gambe di una decina di ragazzotti scalmanati. Spino chiamò er Manetta, uno spilungone grande e grosso che sembrava il capo. Gli presentò Pier Paolo, e disse: «A Mane’, questo è ‘n amico, è uno gajardo a ggioca’. È un’ala sinistra ma dice che saffa’ anche er mediano».
Il Manetta squadrò Pasolini, gli strinse la mano: «Per me vabbè, er campo è ggrande, un cojone in più o in meno nun fa diferenza».
Poi chiamò Catena e gli disse: «Mo’ scegli i pischelli, famo le squadre e cominciamo, prima che venga notte. Io me so’ rotto».
Così si divisero i presenti, cinque per parte, scegliendo a turno dal gruppo in mezzo al campo. Spino si mise in porta, per via del suo respiro, e Pasolini all’ala, a lato del Manetta. Al via, più che una partita sembrò una rissa. Là dov’era il pallone si creava un’orda di gambe e calci, una mattanza. Le urla riempivano lo spiazzo tra i palazzi fino a stiparlo, richiami per la palla, maledizioni e bestemmie. Soltanto Pasolini, in mezzo a quella pazza danza cercava di dare un senso al gioco, di avere un piano. Se ne stava diligente all’ala, chiedendo palla, e quando l’aveva tra i piedi non pensava solo a scartare: urlando consigli, agitando la mano, ordinava ai compagni la giusta posizione, richiamava ora uno ora l’altro, smistava il pallone.
Forse fu perché era un adulto, forse fu soltanto la passione con cui giocò quella partita, neanche fosse un’importante finale, ma a quei ragazzi il poeta sembrò un pazzo soave, una specie di profeta giunto da lontano a spiegare loro il mistero della palla. In mezzo a quel caos originario, dietro quella guida, er Manetta intuì realmente il senso del gioco. Capì che non gli conveniva caricare come un toro tutte le volte che la palla gli passava davanti, ma usando Pasolini come un muro poteva fare un triangolo e scambiare e poi, senza l’assillo degli altri ragazzetti addosso, aspettare il pallone di ritorno, dopo aver osservato dove fosse piazzato Montesano, e dove er Brutto, decidendo al meglio cosa fare.
Alla fine della partita, morti sfatti, seduti sul prato presso la fontana, er Manetta chiese al poeta se ci volesse stare, se avesse voglia di tornare ogni tanto al prato per fare qualche partita.
«Me piacerebbe davero fa’ ‘na squadra, co Spino in porta e noantri nove pischelli avanti. ‘Na squadra vera, nun so se me spiego. Te poi fa’ l’ala e anco l’alenatore. Ce stamo io, er Catena, Montesano, er Brutto, ‘o Zoppo, Remo, More’, Spino e Agnolo er Pugnetta. Famo trema’ tutto Monteverde e magara annamo a briscola’ puro da qualche antra parte».
Pasolini accettò con gran piacere. Disse che era felice, che era proprio contento. Si strinsero le mani, le pacche sulle spalle furono tante, e infine si lasciarono con un appuntamento. Si sarebbero visti fra tre giorni, per fare la squadra e conoscersi un po’ meglio. Poi avrebbero cercato un altro gruppo per provare a fare una partita vera.
Mentre Pasolini se ne andava, tornando verso l’Ostiense, Spino lo chiamò urlando da lontano. «A Pa’, ma nun c’avemo er nome! Te che parli bbene dacce ‘na mano. Come se chiama ‘a squadra, come se chiamamo?».
Qualcuno da in mezzo al gruppo disse «Fij de ‘na mignotta» e scoppiarono risa, altre proposte vennero scartate, fino a che pian piano nella banda scese il silenzio e ognuno guardò verso il poeta che stava pensando. «Io propongo Caos, che mi sembra appropriato, per lo stile del nostro gioco, ma anche per la situazione» e allargò lo sguardo verso i casermoni, e i mucchi di cemento, e la sporcizia che contornava il campo mezzo spelato.
«Caos vuol dire anche confusione, la confusione dalla quale proveniamo tutti, dalla quale si dice sia stato creato il mondo, da dove tutto è nato e nella quale alla fine tutto si perde.»
Fu in questo modo, mentre il sole tramontava dietro i palazzi, che un poeta e dieci ragazzi fondarono il “Caos” di Monteverde.
Pasolini fu di parola. Almeno due volte alla settimana arrivava verso sera al campetto dove l’aspettava la banda di Spino e del Manetta. Spesso cercava di dare loro qualche indicazione tattica, con molta fatica, perché la masnada, fedele al nome che si era data, era poco propensa ad ascoltare, a imparare qualsiasi disciplina. Ci volle del tempo, ci vollero anche pazienza, richiami, urla, bisticci, litigate, ma certamente a quei ragazzi dalle vite sbandate trasmise un po’ della passione che ogni volta metteva quando correva sul campo, lungo la linea di fondo, calciando il pallone. E dopo il gioco, intorno alla fontana, minuti passati in silenzio, oppure a raccontare le gesta del Bologna che da ragazzo aveva amato e visto giocare come si può vedere solo in un sogno un desiderio.
«Sapete» diceva ai ragazzi sudati, «giocare a calcio è come dipingere, e come comporre poesie, scrivere un racconto. Per questo va fatto con passione. Ognuno di voi ha un modo suo particolare di correre, di fare un lancio, di contrastare, e quando uno riesce a realizzare quello che ha in testa allora è davvero contento. E questo è il bello del gioco.»
In poche settimane il “Caos” diventò quasi una squadra, con un qualche senso e una precisa formazione, dieci ragazzi rapidi e un poeta, con il suo fuoco, ma fino ad allora non avevano ancora incontrato un vero avversario.
«A Pa’, me pare che mo’ ‘semo forti davero, ma stamo a ggioca’ sempre co’ ‘sti du’ pischelli intorno a Monteverde. Robba da poco. Me piaceresse vede’ che combinamo affa’ ‘na partita a l’estero, in trasferta» disse una sera il Catena bevendo alla fontana.
Convennero che era il momento di provare. A fine agosto Pasolini prese accordi con una squadretta che giocava all’Ostiense. Ci fu all’inizio qualche discussione. La squadra era formata da ragazzi attorno ai quindici anni, e la presenza di un uomo adulto fu considerata sleale. Pasolini trattò. Venne anche il Manetta. La discussione si alzò di tono e durò a lungo, finché non si decise, per essere alla pari, che per la parte ostiense avrebbe giocato il fratello di Filippetto Giordano, grosso come un armadio e di trent’anni, scaricatore ai magazzini generali.
«Così so’ cazzi» fece Filippetto con un gesto di sberleffo verso il Manetta.
«Sì ma ppe vvoi» rispose questo duro duro «che nun ce lo sapete che è er Caos de Monteverde. È ‘na forza pura. Giocamo cor modulo che c’aveva er Bologna, c’avemo n’ala che è come ‘n arioplano, e du’ mediani che davero nun se passa. Noantri nun giocamo ar calcio, noi semo poeti.»
La partita si giocò il 30 agosto del ’54, e fu la prima di una serie di vittorie del “Caos”. L’esordio in un campo avversario non fu il migliore perché, a dispetto delle dichiarazioni del suo capitano, er Manetta e gli altri tradirono l’emozione del debutto. Iniziarono molli, senza grinta. Er Brutto, a cui era affidato il centrocampo, si impappinò un paio di volte perdendo palla, tra le bestemmie e le urla dei compagni. Presero un gol balordo, per colpa di Spino che si era distratto e non aveva fatto attenzione alla rimessa che lo Zoppo gli lanciò dal fallo laterale, cosi ché si infilò nel mezzo un ostiense, Duccio er Papale, che piazzò una botta a fil di palo, tra gli sfottò della gente.
Pasolini però non disperava. Era convinto del valore della squadra e, visto che dopo la rete era sceso il morale, chiese al Brutto di spostarsi all’ala e lui si mise al centro, a smistare palloni e a fare gioco. Così, sotto la sua guida, a poco a poco la squadra riprese convinzione e fece faville. Segnarono il Catena, Montesano, due gol il Manetta e uno anche Pasolini. L’ultimo, girando al volo un passaggio del Brutto. Finì 5 a 2, e fu un trionfo, perché non fu sublime solo il risultato, ma la vittoria ottenuta su rimonta, il carattere e la qualità del gioco dimostrati. Persino il pubblico, pubblico avverso che all’inizio aveva fischiato, alla fine riconobbe il valore della squadra, di quei ragazzi che adesso si sentivano campioni.
Filippetto Giordano, moscio moscio, pattuì con il Manetta la rivincita, ma perse anche quella, per 8 a 1. Poi fu la volta di un giro a Testaccio, 6 a 0 per il “Caos”, tondo tondo, 5 a 1 al posteggio dietro San Paolo, con la Garbatella. Il ritorno fu un 8 a 3, quasi un massacro.
In poco tempo la fama di questa squadretta girò i quartieri e arrivò persino a Ostia, un pomeriggio. Pasolini era con il ristoratore Luigi Orlandi, detto Giggio, e stavano facendo due chiacchiere al Bagno Ondina. Un gruppo di ragazze si era dato da fare per organizzare una partita sulla spiaggia. Turisti stranieri, ragazzi inglesi contro i locali, che in verità non avevano nessuna voglia di giocare. Quegli altri invece erano capaci, gente potente e bene allenata che fece un boccone dei romani. I bagnanti facevano contorno sulla spiaggetta, urlavano incitamenti e insulti, ridevano, erano davvero vivi. Pasolini si perse dentro quella confusione, anche lui divertendosi a seguire la partita in mezzo alla bolgia che si era creata. Fu quando Giggio Orlandi imprecò per la pochezza della compagine italiana che pareva senza passione, senza rispetto per il gioco, che il poeta gli parlò del “Caos” di Monteverde.
«Perché non venite a giocare qui, all’Idroscalo? C’è la squadretta dei ragazzi che è ‘na bbomba. Voglio proprio vede’ i tuoi pischelli che sanno fa’ contro quelli dell’Ostia. Sono ragazzi sui diciott’anni, e molto tosti. Io ce metto la coppa. Famo er Trofeo del Lido, vedrai che rrobba!» disse Giggio dopo il racconto.
Si decise per la sera del 10 settembre, una partita secca, da giocare sul campetto all’Idroscalo. Il Manetta e gli altri furono perplessi.
«A Pa’. Ma quelli so’ gajardi, so’ più grandi de noi, e menano duro!». «Ma noi siamo una squadra, non vi ricordate? E poi non è mai detta l’ultima parola. Abbiamo già dimostrato di essere capaci di dare un senso al nostro giocare. Nella vita bisogna provarci, spendere fino in fondo quello che abbiamo, a rischio di sbagliare» rispose Pasolini, e li convinse.
Sul campo dell’Idroscalo di Ostia il “Caos” di Monteverde giocò la partita secondo la sua fama. Giggio Orlandi procurò anche delle vere maglie che a molti ragazzetti andavano un po’ larghe. Remo e il Pugnetta, per esempio, giocarono con maniche arrotolate e un salsicciotto attorno ai calzoncini, tra le risa e gli schiamazzi dei presenti. Al Manetta, alto e allampanato, la maglia gli arrivava all’ombelico. Forse per questo, o per il fatto che l’impegno gli sembrò più grande dell’onore, prima di entrare in campo si avvicinò a Pasolini e sottovoce gli disse: «A Pa’, fa’ tu er capitano, io nun me ce la sento».
Così fu lui ad andare al centro, a presentarsi all’arbitro, tal Moricone, e a stringere la mano all’altro capitano. Nel sole che intanto tramontava, il poeta vide avanzare in controluce l’ombra di un ragazzo snello, un’ombra perfetta, che si muoveva con una grazia leggera, scivolando. La testa era una corona di riccioli, gli occhi due tondi azzurri, una bellezza che per un momento gli tolse il fiato di netto.
«Piacere, io so’ Riccetto» gli disse allungando la mano. «Nun stamo gnanche a comincia’, tanto per voi è finita» fece allargando un sorriso disarmante. Pasolini disse qualcosa, controllò il sorteggio, scelse il lato del campo con voce esitante e poi ricambiò la stretta all’arbitro, e all’avversario.
Per tutta la partita giocò bene, come al solito si impegnò fino alla morte, ma ogni volta che si avvicinava all’area avversaria evitava di guardare verso Riccetto, che era il portiere, fuggiva lo sguardo di quegli occhi azzurri che non lo lasciavano respirare. Chiamava la palla, parlava ai compagni. Pensava a giocare.
L’Ostia Idroscalo era davvero tosta, ma il “Caos” non fu da meno e, pure se gli altri erano più esperti e meglio organizzati, i ragazzi del Monteverde ci misero il cuore, corsero e soffrirono come si doveva, giocando di fino o picchiando quando occorreva.
Il punteggio fu davvero un’altalena: prima marcò l’Ostia, poi pareggiò il Catena con una sforbiciata degna di Parola. Segnò ancora l’Ostia, con un certo Martini, e fece pari il Moretto, su punizione. Quindi Pasolini mise in porta una sventola tirata da lontano, e ancora pareggiarono gli altri con un rigore assegnato giustamente per un intervento del Pugnetta, un fallo di mano.
Alla fine del tempo regolamentare, dopo tutti quei colpi di scena il punteggio era ancora in parità, né vincitori né vinti. L’arbitro chiamò al centro i capitani e disse: «Famo i supplementari, un quarto d’ora ognuno, la coppa la devemo puro da’ a qualcuno’», ma anche quel tempo aggiunto non decise niente. Segnò ancora l’Ostia e ancora il Monteverde.
Così fu chiamato Giggio Orlandi e Moricone gli chiese: «Che ffamo? Se proprio vuoi da’ ‘sta coppa suggerisco i rigori. Come da regolamento internazionale. Tirano cinque volte per parte e chi segna segna».
Giggio annuì e si continuò la sfida.
Calciarono prima i locali e fecero il punto, poi fu la volta di Remo che tirò fuori. La disperazione del “Caos” si sentì chiara, salì più alta delle urla dell’Ostia che se la rideva. Ma dopo un nuovo turno di rigori andato in pari, fu uno di casa a sbagliare il tiro, e il “Caos” andò in pareggio fino all’ultimo giro, quando Spino parò una botta micidiale che un tale Andreucci gli aveva sparato nell’angolo di destra. Una grande presa. I suoi compagni fecero festa, gli furono addosso, con pacche, abbracci e baci tanto che per un momento rischiò di soffocare. Pasolini fu l’ultimo a tirare, quando era pari il punteggio. Il tiro decisivo. Il poeta prese con le mani il pallone, lo strinse come se volesse schiacciarlo, poi se lo fece rimbalzare qualche volta accanto, mentre lui era serio serio, come se stesse pensando. Che pensa in quei momenti un giocatore? Ha la mente sgombra, oppure è in preda al terrore che un istante di follia butti al vento tutto? Sono solo undici metri, la porta davanti è immensa, eppure far passare il pallone sembra un’impresa. Quella sera, al campo dell’Idroscalo, Pasolini era il “Caos”, era dieci ragazzi con un sogno affidato ai suoi piedi, a quell’unico calcio da tirare. Dieci ragazzi dentro di sé, dentro il suo petto e davanti a lui gli occhi azzurri di Riccetto che l’avevano fatto di colpo innamorare.
Il poeta posò il pallone sul dischetto, fece due passi indietro fissando la terra. Poi scattò in avanti e tirò senza guardare. Il pallone si infilò in rete e lui sentì un boato, mentre il Manetta, Spino, il Catena già gli saltavano addosso. Dal mucchio dei compagni, un temporale di abbracci, vide Riccetto sdraiato sulla linea di porta.
Mentre Giggio arrivava con la coppa promessa, e i ragazzi del “Caos” erano stelle, lui andò verso il portiere, col cuore in tumulto. «Mi dispiace davvero» gli disse. Il ragazzo piangeva. Le urla felici, le lacrime negli occhi del portiere battuto.
Pasolini sentì che era tutto perduto.
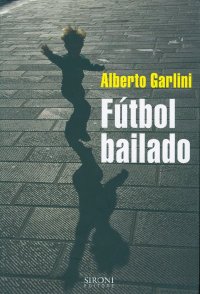
Alberto Garlini
Fútbol bailado
Sironi Editore, Milano 2004
Italia, primavera del 1975. Nei pressi di Mantova, Pier Paolo Pasolini sta girando Salò o le 120 giornate di Sodoma. Poco distante, nei dintorni di Parma, Bernardo Bertolucci lavora al film Novecento. Nel giorno del compleanno di Bertolucci, viene organizzata una partita di calcio tra le due troupe. Il campo è quello della Cittadella, a Parma, intorno al quale sono raccolti tutti i protagonisti di questa storia: Pasolini corre come un forsennato, Bertolucci si improvvisa allenatore; sulle gradinate, tra i numerosi spettatori, si aggirano Alberto, un bambino intimorito dalla solitudine, e Vincenzo, un terrorista nero con una agghiacciante missione da compiere. Il risultato della partita è in sospeso quando, all’inizio del secondo tempo, entra in campo un sedicenne dalle lunghe cosce, lento e affascinante. Si chiama Francesco, viene dalle giovanili del Parma e gioca con una grazia dirompente. Pasolini, guardando il suo fútbol bailado, calcio danzato imparato nelle strade e nelle piazze, decide di cambiare il finale del film: il nero di Salò, della dominazione fredda dell’uomo sull’uomo, si tinge di una nuova speranza. L’autore avverte che, pur rifacendosi liberamente ad alcune vicende accadute, il libro è opera di fantasia. I riferimenti a personaggi, episodi, dialoghi attribuiti a personaggi realmente esistenti o esistiti devono essere considerati all’interno della finzione narrativa.
Alberto Garlini è nato a Parma nel 1969 e vive a Pordenone. Nel 2001 ha pubblicato una raccolta di poesie, Le cose che dico adesso, Nuovadimensione. Nel 2002 ha pubblicato con Sironi il romanzo Una timida santità, vincitore del Premio Vigevano 2003. Collabora alle pagine culturali del «Messaggero Veneto». È tra i curatori della manifestazione culturale Pordenonelegge.
Due recensioni
http://elsinore.splinder.com – 13 maggio 2005
L’attualità, spesso, si diverte a prendere a calci la fantasia, umiliandola, banalizzandola. E la cronaca, quando è nera ancor di più, di questo è maestra, pur se nulla vi sarebbe da vantarsi. Così accade che, pochi mesi dopo l’uscita di un libro che ripercorre, in sottofondo, la storia finale di Pier Paolo Pasolini, Pino Pelosi (colui che secondo la giustizia, quella stessa giustizia che ha stabilito che per piazza Fontana non vi siano colpevoli, ha ucciso il poeta e regista nel novembre 1975, come recita la sentenza di primo grado, in collaborazione con ignoti), ritratti. O meglio, fornisca una versione che si avvicina molto, forse troppo, a quella del libro. Coincidenze, null’altro, è ovvio. Coincidenze che rendono ancora più reale, e sofferente, quel parto della fantasia che è Fútbol bailado, romanzo di Alberto Garlini che, fossimo in un paese serio, sarebbe stabilmente ai vertici delle classifiche di vendita e invece, in questa penisola dove chi legge è guardato storto, langue in quarta fila. Se fossimo in Brasile, addirittura, ve ne sarebbe una copia in ogni casa, per la tematica trattata. Che è, lo indica chiaramente il titolo, il calcio, il fútbol. Non il football, troppo duro il suono inglese per adeguarsi al gioco di Francesco Ferrari, il protagonista di queste 477 pagine. Fútbol, alla spagnola, armoniosamente, dolcemente. Bailado, ballerino. Una danza con il pallone. Roba da brasiliani, appunto. Da Garrincha, da passeri. Da fuoriclasse.
E Francesco Ferrari lo è. Un campione vero, pulito, che non può peccare né sentirsi in colpa perché gioca troppo bene, uno di quelli che giocano per il pubblico e per il divertimento. Più per quest’ultimo, a dire il vero. Il risultato? Non ha alcuna importanza, è un incidente secondario. È il gesto tecnico l’essenza del gioco, un gesto da svolgere a ritmo lento, blandendo il pallone, carezzandolo. Non serve la potenza, quando si ha il controllo. Quando si può indirizzare la sfera di cuoio dovunque si voglia, lasciandola danzare nell’aria, dopo il colpo, sino a vederla depositarsi in rete, alle spalle dei portieri, che si fermano ad applaudire. Ma questo, seppure in poesia, è ancora football. Per diventare fútbol deve uscire dallo stadio, dal rettangolo bianco che ne delimita le possibilità e che lo ingabbia con le sue regole. Perché il fútbol bailado è come una specie di fiume che non si può arginare: gli uomini possono stringere gli argini, possono togliere la ghiaia e pensare di farla franca, ma il fiume prima o poi la fa pagare: alla prima pioggia insistente, trasborda, sconfina, inonda, contagia. E così fa il fútbol, che si gioca dove cade il pallone. Nelle piazza, negli autogrill, in posti irregolari. Posteggi, strade in disuso, boschi di mele, aiuole davanti ai monumenti. Cortiletti interni dei palazzi. Ad Assisi, a Siena, una partita di due giorni, a Porzûs, commemorando l’eccidio partigiano.
[…] Il fútbol bailado invece è puro. E con la sua purezza lega l’uno all’altro i diversi momenti del libro, le diverse storie che si intrecciano, a volte confondendo realtà e fantasia, riportando alla mente la stagione di quando ci si credeva, ci si illudeva, tutti puri. La stagione dell’Italia mundial, dell’Heysel, che ruppe l’ultima falsa ingenuità, del calcio-scommesse, di Pasolini.
Ed è proprio il poeta e regista ad essere protagonista di alcuni passaggi del libro, narrati con sapienza da documentarista. La giovinezza, l’adolescenza, la scoperta dell’altro e della passione, l’amore infinito per il cinema, spezzata nei suoi film, e per il calcio. Quel calcio che sarà presente anche nell’ultima sera della sua vita, sul lungomare di Ostia.
“Oggi è il 2 novembre, è mezzanotte, siamo a Ostia e abbiamo una partita da giocare…”. Così parlando il ragazzino calcia il pallone in mezzo alla congrega degli assassini, dei terroristi, dei marchettari. Il pallone vola alto, altissimo, fino al nero del cielo e ricade esattamente in mezzo al gruppo. E gli assassini, i terroristi, i marchettari guardano la sfera come se fosse un’apparizione ultramondana. La calciano increduli per la sola ragione di saggiarne la consistenza materiale. È vera, risponde come dovrebbe, è una palla di cuoio a scacchi bianchi e neri. Un calcio tira l’altro e a Ostia, il 2 novembre a mezzanotte, si gioca una partita di calcio. Per pochissimi istanti ma si gioca. […] Tutti capiscono immediatamente la fine, il momento in cui la morte viene a reclamare i suoi diritti: un tiro a vuoto del ragazzino dalla tuta blu finisce in un canaletto senza che Pasolini corra a raccoglierlo. Vincenzo e il ragazzino se ne vanno via, insieme. Quando non sono che ombre confuse nella nebbia, come in un rito religioso, in un silenzio di erbe e lune grigie, Pasolini viene massacrato.
I diversi piani del romanzo si compongono pagina dopo pagina. Distraggono il lettore dalla retta lettura. Lo conducono ad Assisi, là dove san Francesco predicava agli uccelli, a Porzûs, a rivivere la strage sistematica compiuta da alcuni partigiani ai danni di altri partigiani, sul set dei film di Pasolini, nei campi di calcio, a Saintes-Maries-de-la-Mer, meraviglioso angolo di Provenza dove il mare ed il cielo si riuniscono, a Ronda, in Spagna, dove si svolse il massacro narrato in Per chi suona la campana. È un percorso ad ostacoli, dove si affacciano più personaggi in una storia che, iniziata nel marzo 1975 a Parma, si conclude nell’ottobre 1982 a Ronda, con una postilla torinese nove anni più tardi.
Avanti e indietro nel tempo il lettore è accompagnato dolcemente, quasi tenuto per mano affinché non si smarrisca. Ed è proprio questo uno dei pregi migliori del libro. Il ritmo, che avvinghia dalla prima all’ultima pagina, zigzagando tra i diversi rivoli delle storie, senza perdere mai di vista il traguardo finale […].
un’analisi di Luca Tassinari (letteraturalenta.net, 8 novembre 2005)
Ho chiuso il romanzo di Garlini,Fútbol bailado, un paio di settimane fa, e ho dovuto aspettare che le impressioni in parte alate e in parte abissali che mi ha lasciato si depositassero da qualche parte, prima di riuscire a decifrarle. Una difficoltà simile a proferir parola su una mia lettura me l’hanno lasciata solo due libri prima d’ora: Memorie del sottosuolo di Dostoevskij e Il maestro e Margherita di Bulgakov, e si tratta di due libri non privi di punti in comune con questo.
In Fútbol bailado c’è un personaggio che racconta al modo dell’uomo del sottosuolo, pur senza comparire mai: al di sopra del protagonista (omonimo dell’autore) e delle narrazioni autonome degli altri personaggi (fra i quali Pasolini, un calciatore mistico, un artista innamorato della luce, un cupo terrorista nero idealista, San Francesco, una pletora di figuranti) c’è questo “autore implicito”, un’entità estranea alla storia narrata ma in possesso di tutte le sue chiavi interpretative. Con Il maestro e Margherita, Fútbol bailado condivide la rappresentazione allegorica di una realtà caotica e irriducibile a discorsi ragionevoli e sintatticamente bene ordinati.
La trama è complessa e aggrovigliata. Mi limito ad alcune indicazioni generiche: l’infanzia di Pasolini e la partecipazione di suo fratello alla Resistenza; una partita di calcio fra la troupe pasoliniana di Salò e quella bertolucciana di Novecento; la morte di Pasolini; lo scandalo del calcio scommesse del 1980; il Mundial del 1982. Attorno a queste date e a questi eventi si sviluppano le storie dei personaggi principali, di cui Garlini ricostruisce biografie più o meno sviluppate nei particolari, ma che passano sempre per i punti critici della vita umana: l’infanzia, l’adolescenza, la maturità e, per alcuni, la morte. Tutte queste vite si intrecciano l’una con l’altra fino a formare una sorta di saga familiare, se pure di una famiglia formata da vincoli più spirituali che di sangue.
Nonostante l’abbondanza di dati reali, Fútbol bailado è un racconto più mitologico che realistico, dove gli eventi storici e le vicende dei personaggi sono caricati di significati paradigmatici. Pasolini rappresenta un ideale di santità laica capace di spingersi fino al sacrificio di sé. Francesco Ferrari (il calciatore-mistico che restituisce tutto il ricavato della sua attività professionistica per dedicarsi a coltivare un calcio ideale nelle piazze e nelle squadre dilettanti di periferia) non è un personaggio realistico, ma il simbolo di un desiderio di pulizia morale. Gli anni Settanta non sono solo gli storici “anni di piombo”, ma anche il sogno (infranto) di un’Italia sprovincializzata e ricca di fermenti vitali, artistici, morali.
La materia narrata a volte assume un valore simbolico che definirei senz’altro religioso, trasformandosi in una vera e propria agiografia di un’umanità santa e perfetta che vive più nei sogni e nelle speranze dell’autore (implicito o meno) che nella realtà: il fútbol bailado eponimo, una sorta di calcio comunitario giocato con francescana gioia e purezza di spirito nelle piazze dei paesi; un’installazione perfettamente riuscita che suscita nei visitatori di una mostra sentimenti di pace universale e appartenenza spirituale a un’ipotetica comunità umana; la nascita di un figlio dall’unione in camera caritatis tra l’artista e il calciatore-mistico morente.
D’altra parte, però, non manca una rappresentazione molto cruda e diretta della negatività da cui nascono gli slanci idealizzanti di cui sopra: la vita misera e violenta delle periferie di trent’anni fa; la cattiveria atroce dei poveri e quella travestita da trasgressione dei ricchi; la sanguinarietà del potere e del terrorismo; lo sgomento e il senso di colpa di fronte all’insensatezza della vita e della morte. Il romanzo di Garlini ondeggia costantemente tra un realismo cupo e disperato e un simbolismo luminoso e ricco di speranza, tra un’attrazione quasi nichilista verso l’abisso dell’insignificanza e il desiderio di trovare nelle vicende umane un elevato senso morale. Anche questa tensione ricorda l’uomo del sottosuolo che urla e strepita contro i vizi e le ipocrisie individuali e collettive della sua epoca, ma poi dichiara di non voler credere che gli uomini siano destinati a compiere soltanto il male. Bulgakov estende questo desiderio di bene perfino al diavolo.
Nella resa narrativa di questa oscillazione tra male naturale e bene ideale, la prosa di Garlini è nettamente più efficace e credibile quando lavora sul lato dell’abisso, mentre si riveste di una patina didascalica e melodrammatica quando si sposta dall’altro lato. Le miserie umane, il dolore e il senso di colpa, la violenza e la morte sorgono spontaneamente dalla storia narrata, come in un racconto naturalistico, mentre le aperture ai significati elevati e idealizzati oscillano tra un sentimentalismo un po’ laccato e tirate al sublime un po’ forzate e romanticheggianti. I personaggi sono molto umani quando si muovono nelle bolge infernali della miseria e della violenza, mentre assumono posture un po’ ieratiche e imbalsamate quando si incamminano verso il paradiso. D’altronde si sa che rendere narrativamente il lato buono della vita umana schivando la melensaggine è un’impresa estremamente difficile, e forse l’unica strada per arrivarci è davvero quella di affidare le buone azioni e gli ideali positivi ai diavoli e alle streghe.
A me sembra che questa differenza di resa stilistica indichi anche una differenza di rapporto tra l’autore e la materia narrata. Mi pare che i temi della santità e della tensione umana verso l’eterno, il vero, il giusto siano per Garlini un mito, forse un mito generazionale, e comunque più la rappresentazione di un desiderio che di un’esperienza. Per contro, mi pare che la materia “truce” e in modo particolare la violenza naturale della vita e il senso di colpa di fronte alla morte siano temi che scaturiscono direttamente da frammenti di vita vissuta. Il fatto che l’autore tratti la santità con un registro narrativo alquanto sovraccarico e leggermente in falsetto, poi, mi fa pensare che questo desiderio di bontà e di pulizia non abbia una presa sicura sulla coscienza, ma sia inserito a forza nella narrazione con un intento giustificatorio, quasi a dire ehi, considerate che io, il narratore, non sono privo di pensieri elevati, e se questa materia che vado raccontando è orrenda e ricolma di miserie non è colpa mia….
Per concludere, dato che io sono quasi sicuro che Garlini non abbia detto in questo libro tutto quello che aveva da dire, scommetto che ne scriverà altri, e mi permetto di esprimere la speranza che nei prossimi arrivi a separare completamente la sua naturale inclinazione all’abisso dall’artificiosa rincorsa al sublime. Che decida una volta per tutte, insomma, se vuol essere un uomo del sottosuolo o un buon diavolo.



