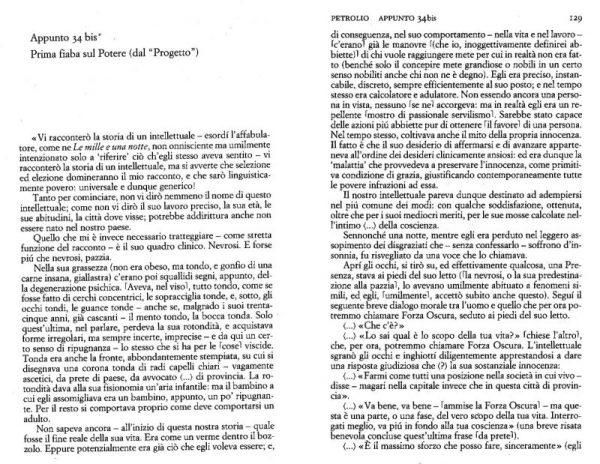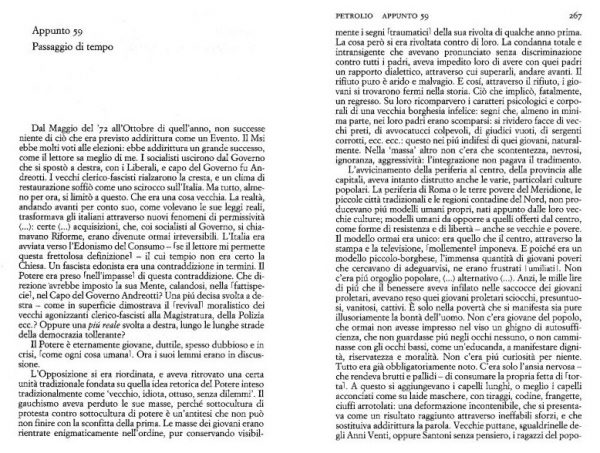Il Satyricon e Petrolio: due falsi realismi a confronto
di Chiara Portesine
Genova, luglio 2013
Premessa
Il confronto tra due autori all’apparenza incolmabilmente distanti (dal punto di vista anagrafico e ideologico) non è sorto da un capriccio stravagante o dalla necessità scolastica di un temerario collegamento interdisciplinare; il punto di partenza è paradossalmente imputabile agli studi umanistici di questi cinque anni. Non perché Petronio venga studiato compulsivamente dalla quarta ginnasio o perché Pasolini sia l’unico referente testuale dell’antologia di italiano (addirittura Petrolio non viene neppure citato nella nutrita bibliografia dei due testi in uso, come se fosse un romanzucolo minore, con le sue esigue 583 pagine…); il liceo classico mi ha insegnato piuttosto un approccio dinamico e polemico con i testi presi in analisi, educandomi ad un rifiuto dell’accettazione passiva e cattedratica nei confronti degli Autori-Autorità, e ad instaurare con la cultura e con il passato un dialogo di interscambio e di confronto piuttosto che di incondizionata sudditanza. In sintesi, l’eredità più preziosa degli studi umanistici per me è stata la curiositas.
Proprio grazie ad essa, dopo aver letto la prima pagina di Petrolio, in cui Pasolini dichiara il suo intento programmatico di scrivere «un Satyricon moderno», ho cominciato ad investigare le cause, le somiglianze, i punti di contatto e di antitesi tra i due testi, a considerarli come due insiemi tra i quali instaurare una corrispondenza biunivoca. Sono stata archeologa e psicologa, filosofa e critica in miniatura, e ad ogni scoperta di complementarietà mi sentivo orgogliosa; non della mia (modesta) analisi, ma del bagaglio culturale, della vivacità intellettuale, della spontaneità di collegamenti che, dopo tante versioni, analisi del testo, parafrasi e esegesi degli antichi, erano entrati a far parte della mia identità. I classici mi avevano insegnato ad aver qualcosa da dire e a non accontentarmi del già detto.
La trattazione che segue è un parziale e circoscritto tentativo di risposta ad uno dei perché? che due testi intramontabili (anche se differentemente accolti nei canoni moderni, in quanto soltanto i posteri potranno dare un giudizio definitivo sulla portata letteraria di Pasolini) non finiranno mai di presentare a chi si addentrerà nella selva oscura delle loro pagine. E questo è proprio ciò che trasforma il libro in un classico: l’impossibilità di pervenire a un’analisi risolutiva. Questo è l’abisso (e il paradiso) della cultura classica.
Pasolini e Petronio: i narratori egoisti
Questo romanzo non comincia.[1]
L’inizio di Petrolio è un atto di cannibalismo letterario: Pasolini nega i canoni costitutivi della forma-romanzo a partire dal rito iniziatico dell’incipit, luogo della narrazione deputato alla “seduzione adescatoria” dell’autore: la filiazione magico-rituale delle prime righe è determinante per collezionare proseliti, per eccitare l’interesse del frequentatore medio di biblioteche, inzuppato di fretta cronica, che chiede ai libri soltanto una cosa: essere convinto in modo categorico e istantaneo. Sì o no. Nell’Appunto 102, L’Epochè: storia di due padri e di due figli, l’autore di Petrolio anatomizza con programmatico sarcasmo la sacralità di questo tabù di indolenza letteraria:
Lasciatemi fare qualche preambolo – disse il terzo narratore – qualche preambolo cautelativo, magari un po’ brillante. Esso in realtà serve a nascondere, come sapete, il momento tragico dell’inizio, che è sempre, come dire, un’autotomia. Inoltre il raccontare mette a repentaglio, e quindi a soqquadro, l’essere. Il soggetto narrante, di fronte alla propria frase fondatrice, entra in stato di crisi. E si tratta della vera e propria crisi tipica del rapporto col sacro. Il racconto è nel recinto sacro. E l’approccio a tale recinto richiede sempre un lungo cerimoniale, abbastanza coatto. E anche buffo.
Pasolini rifiuta l’ammiccamento malioso dell’ouverture borghese; il silenzio del primo Appunto ha il dinamismo anarchico di uno schiaffo al pubblico, una denuncia alla complicità omertosa dei lettori rispetto alle convenzionalità monocordi della letteratura di consumo. L’intero romanzo è giocato su questo intento programmatico di “rottura della quarta parete cartacea”, con l’intromissione perforativa e performativa dell’autore all’interno dell’andamento narrativo; l’io pasoliniano, in qualità di avvocato difensore e giudice del proprio operato, nonché di filologo, redattore di glosse, copista e aiuto-narratore ludicamente onnisciente, svela programmaticamente lo scheletro dei suoi espedienti (piro)tecnici, come un prestigiatore che riveli i trucchi del mestiere in medias res.
mi sono rivolto al lettore direttamente e non convenzionalmente. Ciò vuol dire che non ho fatto del mio romanzo un “oggetto”, una “forma”, obbedendo quindi alle leggi di un linguaggio che ne assicurasse la necessaria distanza da me, quasi addirittura abolendomi, o attraverso cui io generosamente negassi me stesso assumendo umilmente le vesti di un narratore uguale a tutti gli altri narratori. No: io ho parlato al lettore in quanto io stesso, in carne e ossa (…). Ho reso il romanzo oggetto non solo per il lettore ma anche per me: ho messo tale oggetto tra il lettore e me, e ne ho discusso insieme (come si può fare scrivendo da soli). [2]
L’autore non è disposto quindi ad immolarsi in nome della sua opera, a rendersi un dato implicito del romanzo, un «anonimo edificatore che ha avuto la modestia di cancellarsi davanti alle sue cattedrali, l’innumerevole autore delle canzoni popolari» [3]. L’io pasoliniano è orwellianamente ubiquo, non come personaggio tra i personaggi, ma con la corporeità biologica di un globo oculare che sorveglia, sottopone ad esame, convoglia le pulsioni centrifughe dei lettori. Ogni pagina di Petrolio è il risultato di un processo di vivificazione dell’oggetto-libro (e di oggettivazione del soggetto-autore). «Io vivo la genesi del mio libro» scrive Pasolini nell’Appunto 6 sexies (pag. 53); questa gestazione organicistica, tuttavia, non sfocia nel magma caotico di una fusione tra scrittore e scritto, ma trapassa simmetricamente nel suo opposto, ossia in un processo di demolizione e mortificazione dell’ego:
Nel progettare e nel cominciare a scrivere il mio romanzo, io in effetti ho attuato qualcos’altro che progettare e scrivere il mio romanzo: io ho cioè organizzato in me il senso e la funzione della realtà; e una volta che ho organizzato il senso e la funzione della realtà, io ho cercato di impadronirmi della realtà. Impadronirmene (…) in sostanza brutalmente e violentemente, come accade per ogni possesso, per ogni conquista. Nello stesso tempo in cui progettavo e scrivevo il romanzo, cioè ricercavo il senso della realtà e ne prendevo possesso, proprio nell’atto creativo che tutto questo implicava, io desideravo anche di liberarmi di me stesso, cioè di morire. Morire nella mia creazione: morire come in effetti si muore, di parto: morire, come in effetti si muore, eiaculando nel ventre materno. [4]
Petrolio viene così ad assumere la dualistica forma di romanzo di formazione e di deformazione («mi presi e mi smembrai. Quello che avevo fatto con il Dio di Saulo lo feci con Saulo. Dopo essermi ricostruito, mi smembrai. Dovevo essere tutti.» [5]), in una costante scoperta e castrazione dell’io. Lo stesso protagonista, Carlo, è uno strumento di collaudo per questo esperimento di frantumazione letteraria; Pasolini cuce e scuce il suo corpo come un demiurgo-macellaio, a partire dalle prime pagine del romanzo, in cui, dopo la visione autoindotta del proprio cadavere supino sul cemento, avviene la scissione della sua «carne di piccolo borghese intellettuale e imbelle» in due entità inconciliabilmente simmetriche: Carlo di Polis («il corpo di un buono, di un obbediente (…) il corpo di un uomo che ha amato nei giusti limiti la madre, e contro i padre ha lottato , sì, ma come doveva, sapendo ben distinguere le proprie colpe dalle sue» [6]) e Carlo di Tetis, la componente mefistofelica e maniaca, l’animalità della libido svincolata dalle remore del benpensantismo sociale. I due dèmoni coscienziali si spartiscono la paternità del corpo; l’arcangelo cherubino ha diritto di prelazione sulla larva di pelle morta («oggetto di pietà un po’ ripugnante, e basta»), il suo deuteragonista satanico estrae dal ventre il feto di un nuovo anticristo dell’eros. La frattura allegorica messa in atto da Pasolini (il parto cesareo della componente animale dal grembo addomesticato del borghese) non è altro che la presa di coscienza della problematicità scismatica della personalità moderna, in bilico tra la spettacolarizzazione e la negazione del corpo.
Pasolini annuncia a più riprese l’avvento/epifania di narratori secondari, di cui sistematicamente vanifica l’attesa svelandosi come unico e ultimo referente. A questo proposito risulta chiarificatore l’esempio dell’Appunto 6 bis dal titolo I personaggi che vedono nel quale, disquisendo dei presunti pedinatori di Carlo, incaricati da un umbratile potere politico di sorvegliarne e piantonarne ogni spostamento, Pasolini prima dichiara la sua totale inesperienza di ogni ambiente che si collochi nello spazio del potere che gli impedisce addirittura di immaginare la strada, l’edificio, l’appartamento in cui le riunioni si svolgono e i tipi fisici dei personaggi che si radunano, attestando e subito confutando la propria attendibilità di narratore («Non lo faccio per civetteria – ma il lettore non si fidi di me -»); al termine dell’appunto sembra consequenzialmente esautorarsi e passare il testimone a un personaggio intradiegetico, annunciando che «Tutto ciò che Carlo farà sarà come visto da un sicario che non giudica. Ciò che io dirò in proposito altro non è che il succo della relazione orale – e perciò parzialmente dialettale – che ne farà in proposito.» La manomissione linguistica è soltanto la prima e più epidermica delle sue finzioni letterarie: il verbale riportato nell’Appunto successivo non è una grossolana e burocratica cronistoria intrisa di inserti encomiastici, quale potremmo aspettarci da un io narrante descritto come un giovane catecumeno ai suoi primi lavori, un mero e solerte picciotto, ma un pedinamento lirico-filosofico-esistenziale, pasoliniano fino al midollo, mentre l’autore aveva poco prima garantito un remissivo eclissarsi. Nonostante le sue goliardiche e vanificate uscite di scena, Pasolini rimane l’unico narratore (e oserei dire personaggio) dell’intero libro, senza per questo ridursi a biografo e agiografo di se stesso; l’autore piuttosto è oppresso da un complesso edipico nei confronti del narratore tradizionale, rispetto al quale è consapevole di non avere il moralismo necessario ad apparire agli occhi dei lettori come la risposta definitiva all’interrogativo dell’esistenza.
Ogni autore è un dittatore, si sa. Ma è un dittatore mite. E’ un dittatore pronto sempre a pentirsi, a fare marcia indietro, magari a lasciarsi uccidere. E’ un dittatore che non perde occasione di prostrarsi davanti all’ultimo dei suoi presunti sudditi. E’ un dittatore che va mendicando l’attenzione della sua corte. [7]
Petronio possiede invece una consapevolezza del mezzo narrativo e dell’uso così prepotentemente soggettivo da lui coniato da potersi permettere il ruolo blasonato di narratore onnipresente e al contempo implicito. La sua identificazione con un personaggio garante della morale e dell’ordine costituito è impossibile se non addirittura un crimine di gretta incompetenza. Ad una superficiale e cutanea lettura antologica, si potrebbe commettere l’abominio di confondere il narratore interno, Encolpio, ossia il personaggio che racconta in prima persona le sue peripezie, con l’autore effettivo, sornionamente non pervenuto. Il primo è lo stereotipo di un antico “chierico vagante”, uno spiantato avventuriero immerso nei miasmi di un’imprecisata Greca Urbs [8] , un personaggio (e di conseguenza un narratore) de-sublimato e mitomane [9] in quanto portato ad immedesimarsi con zelo adolescenziale negli eroi della letteratura antica (il referente d’elezione è il larga parte Omero). Umorale e incline a una passionalità turbolenta, ex scolaro diligente che ha attinto dalla cultura il minimo sindacale di retorica dottrinale da erogare ai banchetti, Encolpio non cerca il riconoscimento mimetico del lettore colto cui l’elitarissimo Petronio vincolava il Satyricon, quanto piuttosto il sorriso d’intesa e di complicità fruibile in un microcosmo marcatamente intellettuale. Come scrive Gian Biagio Conte:
Il modo ironico (molto più del modo didattico e del modo fantastico) è particolarmente elitario, in quanto l’ironia esiste solo virtualmente in testi che l’autore vuole così programmati, e di fatto si attualizza soltanto grazie alla collaborazione di un lettore capace di soddisfare certe esigenze: di perspicacia, di formazione letteraria adeguata. Il che implica nel lettore una competenza specialistica, non generica. Una competenza ideologica, valutativa. [10]
Il gioco parodistico architettato da Petronio nei confronti delle trame stereotipe del romanzo greco, reso sterile dal marketing di una reiterazione di consumo, risultava un ammiccamento erudito che soltanto una platea di aristocratici intenditori era in grado di degustare. Il romanzo ellenistico aveva eletto a suo canonico “protagonista a due piazze” una coppia di innamorati, separati da un variegato groviglio di macchinazioni della sorte, che in nome della fides nei confronti del partner si sottomettevano a rischiosi azzardi, torture e sevizie per evitare di violare l’impegno morale (e moralistico) alla dea fedeltà. Il lieto fine (ossia la tanto sospirata unione coniugale) è il coronamento del perbenismo popolaresco e borghese della Trivialliteratur (di allora non meno che di oggi). Petronio ribalta questo stucchevole sottoprodotto dell’industria letteraria presentando una coppia di fedifraghi omosessuali, che non esitano ad allacciare rapporti di trasgressiva perversione con amanti di ambo i sessi, in una dinamica erotico-priapea agli antipodi rispetto alla castità preconcetta dei modelli.
Encolpio non è l’unico io narrante del Satyricon; in alcuni segmenti narrativi Petronio ricorre a narratori di secondo grado, integrati e deformati dall’ambiente sociale di cui sono chiamati a rendere conto. L’autore si serve dei loro corpi come di fantocci illustrativi, forzandone fino al parossismo coloristico le impurità linguistiche, i vizi culturali retaggio di un nozionismo libresco e la lordura fisica come immagine di una decadenza interiore e storica.
Così ad esempio nella celebre Cena di Trimalcione, il ritratto del padrone di casa è preceduto e preparato dalle caricature carnevalesche e “felliniane” dei convitati, la cui caratterizzazione evoca i personaggi dell’Atellana, del mimo drammatico e della commedia menandrea, depurati dalla schematicità statica della tradizione popolare e fotografati nella loro più pura e grottesca fattura di parvenu. Saturi di superstizione e credulità magico-esoterica, digiuni di galateo simposiale e affetti da una cronica misoginia aprioristica, descrivendo se stessi, caratterizzano simmetricamente il loro vicino di triclinio, in un incastro analogico di rimandi autoreferenziali. Nel suo magistrale capitolo dedicato al realismo petroniano, Erich Auerbach condensa il gioco ottico di diffrazioni e rifrazioni sovrapposte nella Cena in una pagina di invidiabile (ed invidiata) sintesi letteraria:
(…) Quella che ci viene presentata non è la cerchia di Trimalcione come realtà obiettiva, ma invece un’immagine soggettiva, quale si forma nel capo di quel vicino di tavola, che però di quella cerchia fa parte. Petronio non dice: – E’ così -; lascia invece che un soggetto, il quale non coincide né con lui né col finto narratore Encolpio, proietti il suo sguardo sulla tavolata, un procedimento assai artificioso, un esperimento di prospettiva, una specie di specchio doppio che nell’antica letteratura conservataci costituisce non oserei dire un unicum, ma tuttavia un caso rarissimo. (…) Si tratta del soggettivismo più spinto, che viene maggiormente accentuato dal linguaggio individuale da una parte, e per intenzione di obiettività dall’altra, dato che l’intenzione mira, per mezzo del procedimento soggettivo, alla descrizione obiettiva dei commensali, compreso colui che parla. Il procedimento conduce ad un’illusione di vita più sensibile e concreta in quanto, descrivendo il vicino di tavola, il punto di vista viene portato dentro all’immagine, e questa ne guadagna in profondità così da sembrare che da uno dei suoi luoghi esca la luce da cui è illuminata [11].
A questo punto sorge un inestricabile quesito: lo sguardo occulto ma dissacratorio di Petronio può essere tacciato di moralismo [12] e di snobistica condanna etica del suo microcosmo di personaggi? Conservatore per indole e missione estetica, vagheggiatore di mitiche età dell’oro culturali, Petronio a mio parere non può tuttavia essere accusato di ricoprire il ruolo di giudice e delatore dei suoi personaggi. La sua denuncia è rivolta al progresso regressivo della storia, ad una decadenza epocale imputabile a cause di recessione umana. Petronio si limita a immatricolare le nuove classi in ascesa con un paternalismo distaccato e neutrale; non prova ripugnanza nei confronti della trivialità canagliesca dei liberti né indulge ad uno sguardo di pietistica simpatia. Il sistema di valori culturali e morali di cui è orgoglioso portatore è stato surclassato e annichilito dal riflusso delle gerarchie sociali; la piramide si è capovolta, e all’aristocrazia in declino non resta che prendere atto della nuova forza egemonica (seppur con qualche riserva intellettuale, come risulta evidente dall’esasperazione iperbolica dell’ignoranza di Trimalchione, che rasenta picchi di analfabetismo quando stravolge l’episodio del «Ciclope che storse ad Ulisse il dito pollice con un tronchesino» [13] o quando, facendo rivoltare nella tomba il povero Omero, ricorda che «ai tempi in cui Ilio fu presa, Annibale» [14] (improbabile contemporaneo) fu l’inventore della lega corinzia, facendo fondere su un rogo improvvisato statue d’oro e d’argento. Clamoroso e parodistico stravolgimento è anche la sostituzione di Castore e Polluce con Diomede e Ganimede, o di Agamennone come rapitore di Elena in sostituzione di Paride [15]); la mancanza assoluta di un contraddittorio contribuisce a sottolineare l’ottuso clima di grettezza intellettuale del grottesco simposio.
Egli contempla quel sotto mondo che sta ormai diventando il mondo [16] con l’imperturbabile indifferenza delle divinità epicuree, albergate nella noncuranza dei propri intermundia. Quello petroniano è un disincanto partecipe, che deforma lo spazio per scandagliarne al meglio il gioco cromatico di prospettive.
Tanto Pasolini quanto Petronio, con le debite distinzioni di epoca, stile, retroterra culturale e storico, intridono del proprio travolgente soggettivismo ogni pagina dei loro romanzi, senza lasciare spazio né all’obiettività equanime del verismo né al protagonismo di maliosi narratori secondari. La loro identificazione con il romanzo trascende in una forma di panteismo letterario, in cui ogni parola e sintagma vive inderogabilmente a causa e attraverso l’autore. Entrambi rifiutano per indole e missione estetica di subordinarsi al sistema dei loro personaggi, imponendosi come insopprimibili e univoci catalizzatori dell’attenzione del lettore. Le storie da essi narrate non esistono se scremate e nettate dal loro ingombrante ed egotico io. Non sono disposti neppure per un istante a perseguire l’annichilimento programmatico del narratore prospettato da Verga, secondo il quale «l’opera d’arte doveva sembrare essersi fatta da sé, aver maturato ed essere sorta spontanea come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto col suo autore e il cui autore abbia avuto il coraggio divino di eclissarsi e sparire nella sua opera immortale.» [17]
Per questo ritengo che si possa parlare di narratori egoisti, non altrettanto umili ma sicuramente intramontabili al pari degli stoici patrocinatori dell’oggettivismo ottocentesco.
La favola come allegoria e come forma di identificazione sociale
A partire dalle remote ed embrionali forme comunicative del linguaggio umano, la favola ha avuto la funzione pregnante di catalizzare istanze ed esperienze del singolo e della collettività e di trasporle sul piano simbolico (e quindi sublimato) del camuffamento allegorico. All’apparenza più innocua e prosaica del mito (baule etico d’elezione di un’intera civiltà) , relegata a sotto genere di consumo infantile e pedagogico, confusa con la parabola o ridotta a mera amplificazione di proverbi popolari, in realtà è uno dei larvali prerequisiti antropologici di ogni cultura (insieme al ritmo musicale, l’articolazione verbale e la religione). Anche il processo di scrematura del repertorio favolistico messo in atto da una società (con la selezione naturale di determinati intrecci giudicati – o meglio “percepiti”, essendo un processo a-logico – rappresentativi di una collettività) rivela la maturazione autogena di veri e propri canoni narrativi violentemente caratterizzanti. Basti pensare all’attestata consuetudine, da parte della letteratura fiabesca e dell’oralità popolare, di semplificare la personalità di un individuo attraverso il paragone simbolico con un animale e alle siderali differenze, nell’attribuzione morale di vizi e virtù al mondo ferino, che sussistono tra un popolo ed un altro (ad esempio il maiale, animale negletto, metafora di lordura e di trivialità per la cultura occidentale, nel calendario cinese è uno dei segni più nobili, simbolo di generosità ed operosità lavorativa).
Se dal piano del vivere associato ci rivolgiamo a quello della narrazione individuale, la scelta di inventare o riportare una specifica favola si traduce nel programmatico (anche se inconscio) statuto di contrassegnare un personaggio, una situazione, un’etnia, una classe sociale. (Aforisticamente si potrebbe riassumere il concetto asserendo che “Noi siamo le favole che raccontiamo”).
Petronio si avvale copiosamente dell’espediente della favola soprattutto durante la Cena di Trimalchione, a metà della quale al lettore pare di assistere ad un vero e proprio agone novellistico tra gli sconci convitati. Dopo la parata gastronomica e la spettacolarizzazione quasi nauseante di cacciagione grondante di sangue e vino, la digestione dei gozzovigliatori è marcatamente letteraria (d’altronde, non stupisce il fatto che un manipolo di rozzi liberti arricchiti fruiscano della cultura al pari di una prassi nobilitante per smaltire la sbornia). Dal momento che l’auditorio è imbevuto di esorcismi superstiziosi e rituali apotropaici (l’inizio e la fine della Cena sono circolarmente contraddistinti da due episodi paralleli di scongiuri popolareschi, il primo è l’ingiunzione, da parte di uno dei servitori, di entrare nella casa di Trimalchione con il piede destro, segno di buon auspicio [18], il secondo è l’aspersione di vino sotto la tavola e sulla lucerna per esorcizzare il canto del gallo udito dai convitati e simbolo di morte [19]), la novella proemiale raccontata dal convitato Nicerote non può che essere un racconto di magia. Luca Canali, nel suo saggio-traduzione dal titolo L’erotico e il grottesco nel Satyricon, così introduce la favola che ci accingiamo ad analizzare:
In questo sottomondo emergente, con tutta la sua potenza torbida e vitale, non poteva mancare come unica sublimazione e “metapsichica”, fra così straripante fisicità senza orizzonti e quasi senza cielo, l’elemento magico. Ma la magia ha i toni foschi della tregenda, la cupezza della cronaca nera, la maledizione della violenza, della lubricità, della follia [20]
E’ la celebre novella “del lupo mannaro”, preconizzatrice della poesia sepolcrale e del romanzo gotico/noir; il narratore riporta la propria esperienza asserendo di aver assistito in un cimitero alla metamorfosi di un suo conoscente in lupo (pienamente convinto della veridicità del suo racconto e senza essere messo in dubbio dalla credulità dei compagni di tavola [21]). Trimalchione si inserisce nel grembo del soggetto macabro-magico e, pienamente imbevuto dell’agonismo sfrenato dei parvenu, dichiara di essere stato testimone oculare di una storia ancor più raccapricciante: durante una veglia funebre per un giovane morto prematuramente, le streghe circondarono la casa «latrando come il cane che insegue la lepre» [22] ed arrogandosi il diritto di prelazione sul corpo. Uno dei partecipanti, un nerboruto e ardimentoso Cappadoce, sguaina la spada e si slancia all’inseguimento delle chiassose fattucchiere, ma torna con le membra sfregiate e ricoperte di lividi. Medicato il ferito, la litania della veglia riprende, ma quando la madre prova ad stringere il corpo del figlio, si accorge di abbracciare un fantoccio di paglia. Le streghe avevano razziato gli intestini, gli organi, il cuore del fanciullo lasciando al suo posto un manichino di pelle vuota.
Lo sgomento instillato dal racconto nella combriccola di arrampicatori sociali risulta anch’esso superficiale e approssimativo, quasi un rituale della digestione collettiva; al termine di queste novelle macabre, infatti, l’auditorio è istantaneamente [23] disposto alla ricezione di sketches comici, caratteristici degli intermezzi circensi (come l’imitazione labiale dei trombettieri da parte di Trimalchione, l’ostensione di un’opulenta «cagnetta nera indecentemente grassa e avvolta in una sciarpa verde», copiosamente imboccata di pane bianco come una divinità del grottesco, e la presentazione quasi epica del presidium domus familiaeque [24], uno spropositato cane che viene incitato alla zuffa con la profumata e matronale cagnetta, in una sorta di volgare e casereccia ripresa dei modelli gladiatori del Colosseo).
Le prime due fabulae hanno dunque una funzione descrittiva dell’ambiente, e contribuiscono a quel processo di focalizzazione interna del retroterra sociale che ci permette di inquadrare i personaggi e le rispettive classi di appartenenza dagli indizi (sebbene deformati) che gli individui presi a campione danno di sé. Come chiosa Gian Battista Conte:
Petronio è maestro nell’arte di evocare gli stereotipi sfruttando la loro banalità stessa o di comunicare alle sue descrizioni un’aria di inautenticità sufficiente per provocare una lettura sdoppiata (e quindi umoristica). [25]
Il declamatore licenzioso della terza novella (nota come Il fanciullo di Pergamo) è Eumolpo, che racconta in prima persona – espediente tipico della fabula Milesia e del mimo – la sua esperienza di amore pederotico per il figlio dell’uomo che gli aveva dato ospitalità nella città asiatica. Ingraziatosi la fiducia dei genitori, con moralistiche requisitorie contro l’amore efebico, Eumolpo riesce a diventare precettore esclusivo del delicato puer, al fine di evitare che «avesse accesso alla casa qualcuno che attentasse al suo pudore.» [26] Un pomeriggio, in un momento di torpore postprandiale, rimasto solo con il fanciullo a causa di una riduzione dell’orario scolastico e accorgendosi del suo sonno soltanto simulato, gli sussurra all’orecchio: «Venere signora, se io potrò baciare questo ragazzo in modo che non se ne accorga, domani gli regalerò una coppia di colombe.» Il giovane, allettato dal gustoso compenso, inscena un rumoroso russare, offrendosi al piacere di Eumolpo, e il giorno successivo riceve le pattuite colombe. Il gioco perverso si ripete, con crescenti ricompense da un lato (due galli da combattimento e un cavallo) e con più esplicite profferte sessuali dall’altro (carezze lascive e un rapporto completo); il secondo indennizzo però, il destriero promesso, non viene elargito dallo scaltro Eumolpo, preoccupato di non rendere sospetta la propria ingiustificabile generosità agli occhi dei genitori del ragazzo. Offeso dal commercio impari, ai tentativi lussuriosi dell’insaziabile narratore, il puer risponde «O dormi, o lo dico subito a mio padre»; assuefatto però al vizio, il giorno dopo è il fanciullo ad accennare con noncuranza ad una ripresa dell’intesa pederastica, diventando un patologico e morboso schiavo delle sevizie di Eumolpo, che all’ennesima richiesta di amplesso risponde estenuato: «O dormi o lo dico subito a tuo padre», in un beffardo parallelismo di vendetta.
La novella viene ad inserirsi al momento dell’incontro tra Eumolpo ed Encolpio, in una pinacoteca di quadri preziosi, e ha l’effetto catartico di rincuorare l’io narrante, vessato dal dolore per l’abbandono dell’amante, e soprattutto di stabilire le fondamenta di empatia sostanziali per la futura amicizia. Riconoscendosi nei preziosismi verbali e nel lirismo libresco di Eumolpo, ma anche nel suo sano culto per la religione del corpo, Encolpio subodora la loro reciproca affinità, che li renderà compagni di peripezie avventurose e pervertimenti erotici. La favola acquista in questo caso una valenza riconoscitiva, uno strumento di identificazione segnaletica.
La quarta storia è narrata sempre per bocca di Eumolpo sul ponte della nave di Lica in forma di exemplum per la sua requisitoria misogina contro la volubilità e la libidine delle donne. Si tratta della rinomata Novella della Matrona di Efeso, un antologico esempio di fabula milesia, un licenzioso schema letterario tracciato da Aristide di Mileto nel II secolo a.C. nei suoi Mιλησιακά, reperibile anche in una favola del corpus di Fedro e nell’esopica “Υυνή καί γεωργός”. E’ del tutto probabile che esistesse, per le edizioni in lingua latina, una fonte comune, verosimilmente riconducibile allo storico di età sillana Cornelio Sisenna, traduttore e rifacitore di Aristide. Caratteristica peculiare del genere era l’erotismo salace, ai limiti dell’oscenità, che Petronio, attraverso una complessa strategia narrativa, ha reso funzionale alla traslitterazione del rapporto triangolare dei suoi personaggi Encolpio-Gitone-Lica-Trifena, variamente assortito nel corso delle peripezie dell’intreccio. Lo statuto di licenziosità programmatica risulta a partire dalla scelta dell’ambientazione, Efeso, la città ionica della Microasia tradizionalmente ritenuta corrotta e lubrica. […]
La salacità sensuale e misogina della narrazione incontra il plauso sguaiato dei marinai (meno ricchi ma parimenti rozzi rispetto ai parvenu di Trimalchione), mentre desta nei personaggi petroniani moti controversi e fortemente legati alla soggettività dei riceventi: Trifena, traslitterazione corporea e realistica della Matrona di Efeso, arrossisce, punta sul vivo dalla sublimazione allegorica di una voluttà che riconosce come propria, ma, quasi a suggello e conferma di essa, «appoggia il viso sul collo di Gitone.» La sua carnalità orgiastica e avulsa dai condizionamenti sociali, che la accomuna a tutti i personaggi femminili presenti nel Satyricon, di qualunque età e classe sociale, è anche e soprattutto un’accusa politica al benpensantismo borghese dell’età neroniana: dal testo petroniano sono bandite le virtù ipocrite della tradizione funeraria, che certificava la fedeltà, la castità, la pudicizia e la temperanza delle mogli, mondate e disinfettate dalla statuaria e dai carmi luttuosi di tutti quei vizi e quelle perversioni attestate invece dagli storiografi, dagli autori di satire e dai prosatori come inclinazioni peculiari proprio della fosca corte di Nerone. Rispetto alle figure di avvelenatrici, concubine ed insaziabili manovratrici del princeps, le matrone venivano rappresentate come castigate custodi del focolare domestico, ricoperte dai severi panneggi della stola, comparsa in età protoimperiale come visiva “protezione dalle offese” perpetrate dalla voracità oculare dei passanti, sostituendo la nudità classica della cultura greca [27].
Petronio denuncia questa castrazione della sfera dionisiaca ed impulsiva, con un prepotente ritorno ad una corporeità non mediata e incanalata nella sfera matrimoniale (nessuna delle donne da lui descritte accenna a pretese o sogni nuziali).
Al contrario della reazione di Trifena, Lica è punto nel vivo laddove la sua virilità è più fragile: la novella gli ricorda l’onta dell’abbandono e dell’adulterio della moglie Edile, portandolo ad identificarsi con il marito frodato e ridicolizzato dalle macchinazioni di una serva e di una femmina infoiata. «Se il governatore fosse stato giusto – asserisce con un moralismo di comodo – avrebbe dovuto far riportare nella tomba il corpo del padre di famiglia e farci inchiodare la donna sulla croce.» [28]
L’intreccio favolistico acquista, sulla nave di Lica, una valenza mimetica, di immedesimazione forzata dei personaggi, costretti ad uno smascheramento pubblico della loro corruzione e alla contaminazione del loro passato, e parallelamente ha la funzione di chiarificare agli occhi del lettore le dinamiche endogene dei personaggi.
In Pasolini l’intreccio favolistico acquista un’esplicita valenza di allegoria politica; la Prima fiaba sul potere (dal “Progetto”) dell’Appunto 34 bis [29] è quasi una parabola dell’ascesi al paradiso/inferno della potestà egemonica.
L’affabulatore avverte che sarà «linguisticamente povero, universale e dunque generico», ma sappiamo già di non dovergli dar credito. Il protagonista della storia è un intellettuale sui trentacinque anni, «non obeso ma tondo e gonfio di una carne insana, giallastra, di una sfericità disarmonica e molle» che genera nell’osservatore «lo stesso senso di ripugnanza che si ha per le cose viscide». Una notte appare ai piedi del suo letto una Forza Oscura, che gli domanda quale sia lo scopo ultimo della sua vita. L’intellettuale, uomo efficientemente mediocre, borghese anche nei sogni, risponde: «Farmi come tutti una posizione nella società in cui vivo.» La presenza demonica, la cui «abiezione era come una crosta», gli concede di raggiungere il potere a patto che sia lui a determinare le modalità della sua scalata sociale. Non il prestigio letterario e l’untuoso plauso delle sette accademiche, non una rapida carriera aziendale, non il semplice successo in seno al «grande partito di potere [presumibilmente la Dc] in cui sarebbe stato per il Diavolo facilissimo guidare gli scambi di favori»; l’intellettuale vuole raggiungere il Potere attraverso la Santità. Da quel giorno hanno inizio le sue pratiche di ascetismo pubblico, «in un convento al centro della città natale, molto frequentato», e lì l’odore di Santità si diffonde come un’esalazione segnaletica; i fedeli annusano e riconoscono il padrone, attendono soltanto stigmate e piaghe davanti a cui prostrare le schiene. Ma all’apogeo della divinizzazione popolare, l’intellettuale si accorge di essere diventato veramente un santo («Era la santità che il Diavolo gli aveva fatto raggiungere: la Santità, non la finzione della Santità. La Poesia, non la Letteratura»). In preda alle convulsioni di un raptus, riceve sui palmi delle mani le cicatrici di due lunghe stigmate lorde di sangue (la santificazione d’altronde è opera del Diavolo, in una sorta di deificazione del peccato). La folgorazione si trasforma in estasi mistica; la contemplazione dell’Assoluto non ha la pregnanza profetica di un Paradiso dantesco, anzi «Dio aveva un viso anonimo» e si rivela all’intellettuale come unico mandante della sua – non richiesta – Santità; «il Diavolo non esiste, il Male non è che un’esperienza transitoria. Bisogna passarci in mezzo, ecco tutto.» Il Padre Eterno ha scelto il suo pervertimento di provinciale ambizioso per redimere il genere umano, e incarica l’intellettuale-martire di diffondere il messaggio celeste tra gli uomini. L’unica clausola (in Pasolini anche Dio, d’altronde, è un burocrate) è quella di non voltarsi a guardarne la Luce, in una rievocazione e traslitterazione biblica del mito di Orfeo. Ma una «forza che alla cervice lo obbligava a torcersi indietro», scaturita non da un’insopprimibile ed ellenica curiositas ma da un «rigurgito di bassi sentimenti», una piaga di ammorbante umano che macchia la tunica immacolata della Santità, lo costringe a voltarsi; all’intellettuale non resta che il tempo di vedere «il sorriso da mendicante del Diavolo» deformare la bocca di Dio prima di sentire il proprio corpo farsi pietra. Quell’amalgama di impurità mineralogiche dai carnosi riflessi fulvi in cui si sono trasformati i suoi tessuti biologici è destinato a diventare un enigma insolubile per i geologi (e per gli uomini) di tutti i tempi; «le ricerche – conclude amaramente Pasolini – danno sempre dei buoni risultati parziali.»
Questa favola, che, nella scaletta programmatica di Pasolini avrebbe dovuto essere seguita da altre storie (Il popolo e il potere prima del ’68 e Un delitto onirico di Carlo, che avrebbe disinnescato una “bomba visionaria” nella stazione di Torino), è inserita nel contesto salottiero di un ricevimento intellettuale di Sinistra (nel quale il narratore di è divertito a schizzare un’epigrafica galleria di ritratti, tra cui spiccano quelli di Alberto Moravia, Antonello Trombadori, Giulio Andreotti e Pasolini stesso). Il senso del grottesco dei convitati, antifascisti per moda o per convenienza d’immagine pubblica, è all’apparenza meno esplicito di quello dei debordanti convitati trimalchioneschi, ma non meno dissacratorio. I volti degli anziani intellettuali vengono descritti come «visi tanto terribilmente e mostruosamente marchiati, bruttati, scavati, gonfiati dal tempo quanto ben tenuti, curati, spiranti agio, benessere e fraternità nella verità.» [30] Ogni sottogruppo in cui si articola il ricevimento reca nei vestiti, nelle acconciature, nei rituali di ammiccamento reciproco, il contrassegno gerarchico del proprio potere, la dose di autorità certificata dal contesto. Quelle maschere di decadenza non sperimentano i dubbi generazionali del cambiamento storico, perché i loro figli sono il rassicurante prodotto della loro stessa sottoideologia.
Tutti i convitati, dal letterato connivente con il macropartito del momento al politico ipocrita che gode della patina di eroismo post-resistenziale, sono i protagonisti della favola del Potere; senza nome come l’intellettuale-santo, costituiscono un esercito di zelanti funzionari che sognano l’eccitazione di una promozione, in una scalata nominalistica di ruoli da far incidere a caratteri gotici sulla porta dell’ufficio. Ma Pasolini ricorda, con i toni di un’Apocalisse figurata, che l’ascesi è soltanto una discesa al contrario.
Una sezione successiva al viaggio iniziatico degli Argonauti [31] (ossia la mitizzazione delle ricerche petrolifere ultimate da Carlo in Medio Oriente per conto dell’Eni) è intitolata Racconti colti; riportare la sintesi puntuale di tutte le novelle risulterebbe verboso e richiederebbe una contestualizzazione articolata. Per una schematizzazione illustrativa rimando alla nota a piè di pagina [32], limitandomi a commentare soltanto la prima, riportata nell’Appunto 41 sotto il nome di Acquisto di uno schiavo. Il protagonista, l’anglosassone Tristam [33], è un biondo, adolescenziale, stupido, spiritoso giornalista del «Guardian» che, venuto a conoscenza dell’esistenza di un mercato di schiavi neri alla periferia di Khartoum, decide di mettersi in viaggio con l’intento di acquistare una schiava (deponendo il retroterra professionale di anticolonialismo e terzomondismo filantropico). Scartando l’assortimento mercantile di donne nere (per il loro modo irriverente e paritario di offrire il proprio corpo al compratore, vicine alla prostituzione occidentale più che al rapporto di insubordinazione schiavistico vagheggiato dal giornalista europeo) e la rassegna suppletiva di maschi bruni (troppo seri e in «preda ad un drammatico senso di pudore offeso legato a chissà quali tabù»), Tristam fa cadere la scelta su una bambina, Giana, «sottomessa e orgogliosa come un soldatino». Avvolta in un fagotto a fiorellini sudicio, quella schiavetta era inzuppata, agli occhi di Tristam, dell’odore stesso della povertà; avrebbe educato il suo corpo alla sottomissione storica, insegnando e apprendendo il neocapitalismo con l’esercizio della sua violenza frettolosa di padrone geografico, ereditaria e culturale.
Tristam, presto sazio delle sevizie erotiche (anche perché la bambina accettava con laconica naturalezza ogni forma di supplizio, de-sublimando l’eccitante idea dello stupro e della lotta per la sottomissione), escogita un perverso gioco di sanzioni; la bambina viene punita con il digiuno o le vergate per una serie di colpe progressivamente brevettate e inserite in un manuale (simile ad un registro dei conti burocratico). Ma anche questo allettante espediente incontra soltanto la bovina passività della schiava, avulsa (per indole geografica) dai meccanismi di dipendenza reciproca del rapporto servo-padrone. L’ultimo tentativo di fomentare un seppur positivo atto di subordinazione è quello di una paternalistica affrancazione; il giornalista biondo affida la sua insoddisfacente e malfunzionante bestiolina esotica ad una missione cattolica (dove i piccoli ospiti, «se non fosse stato per la profonda pace e per una certa proprietà dei loro poveri vestitini bianchi, sarebbero sembrati dei fucilati»). Quando sta per varcare la porta, ebbro del suo stesso atto morale, guarda la schiava, pregustandone la definitiva (anche se posticipata) attestazione di egemonia etnica, di originaria superiorità culturale: la gratitudine. Invece Giana gli rivolge le spalle, senza voltarsi, indifferente alla libertà quanto alla schiavitù.
All’implicita domanda inerente ad una possibilità di interrelazione etnica tra le due culture che sia differente dalla reiterazione di meccaniche neocolonialiste, Pasolini risponde nell’amara anti-morale riportata in calce :
L’alterità del mondo di Giana, che non si era voltata, comprendeva anche il mondo magico (per lui, progressista, il mondo magico altro non era che superstizione, di cui, per la verità, non conosceva che i quattro dati banali che conoscono tutti), ma non era in questo che si esprimeva; anzi, Tristam istintivamente attribuiva a Giana, almeno in modo estremamente rozzo e solo potenziale, il suo stesso sentimento di condanna verso di esso. Il suo giudizio negativo di uomo avanzato che interpretava il Terzo Mondo di Giana era una frustrazione totale, senza alcuno spiraglio di ragionevole speranza: e infatti nel momento inevitabile in cui si erano lasciati, andando ognuno per la sua strada, non si poteva dire né che Tristam avesse integrato la propria cultura con quella di Giana, né che Giana avesse integrato la propria cultura con quella di Tristam.
A parlare è il Pasolini antropologo ed etnografo che negli ultimi anni della sua vita, deluso dalla borghesizzazione del suo amato (e idolatrato) sottoproletariato romano, è alla disperata ricerca di una cultura primigenia, non defraudata dalla contaminazione civilizzatrice dell’Occidente; ma anche quest’immersione nel mondo tribale dell’Africa si converte in una deludente constatazione: l’impossibilità di venire a contatto con un’etnia primitiva senza contaminarla, senza infettarla attraverso le proprie sovrastrutture intellettuali, storiche, coscienziali. Il mito (e l’etnos) sono morti.
La favola acquista quindi il sapore di una dichiarazione di sconfitta esistenziale, all’io Pasolini prima ancora che alla generica umanità dei contemporanei. E’ una caustica e intima confessione di impotenza al lettore, e allo stesso tempo di delucidazione testamentaria di un cammino alla ricerca di un’autenticità primitiva che il narratore ha fino all’ultimo rincorso e idealizzato, con una brama morbosa di trovare una purezza inviolata, una traccia di vitalismo genuino nell’ombra corrotta della modernità. Nel secondo appunto alla favola-parabola sopra citata Pasolini traccia un ultimo, epigrammatico segno del proprio disinganno di uomo e di antropologo, dichiarando che «Ciò che è diverso non esiste.» E forse l’Alterità primordiale vagheggiata da Pasolini non è mai realmente esistita, configurandosi piuttosto come una mitologia privata, a cui l’autore si è consacrato accorgendosi (troppo tardi) di aver creato nulla più di una moderna Arcadia.
Due tipi di falso realismo: il realismo della deformazione e della mitizzazione
Nessuno dei due romanzi presi in analisi può essere definito a pieno titolo espressione di istanze realistiche, sebbene trasversalmente implichi un’analisi della realtà oggettiva e delle forze in essa agenti e reagenti. Tanto Petronio quanto Pasolini sembrano fotografare la dimensione dei loro personaggi in una chiave di registrazione se non oggettiva quantomeno plausibile, indubitabilmente filtrata dal setaccio della letteratura ma apparentemente verosimile. Sono ragionevoli gli sproloqui illetterati di Trimalchione, le ostensioni di sgargianti monili (inevitabilmente kitsch [34]) da parte della moglie Fortunata, la superstizione e la grettezza dei convitati; è esattamente quello che un lettore si aspetterebbe da una catalogazione rigorosa e aderente al vero della classe in ascesa dei parvenu, rozzi popolani che soltanto la tracimante ricchezza ha trasformato in classe egemone. Allo stesso modo appartengono all’immaginario comune le descrizioni dei torbidi abboccamenti mafiosi di cui è testimone Carlo, la seriale miseria degli alloggi della periferia romana, l’ingenuità primitiva del mondo sottoproletario rapportato all’immoralità che alberga nelle stanze del potere politico; tutto questo è passibile di discussioni e capovolgimenti, contestabile o condivisibile, tuttavia rimane essenzialmente credibile. Se avete seguito il ragionamento con un moto di assenso, approvando ciecamente la mia argomentazione, siete stati ingannati: siete caduti nella trappola dei falsi realismi. All’apparenza innocui cronisti dell’oggettività, Petronio e Pasolini simulano il verosimile, innestando su una matrice di attendibilità le personali istanze di narratori e uomini.
Non crucciatevi, siete in squisita compagnia: Huysmans, nella celebrazione del testo petroniano operata dal suo personaggio Des Esseintes, considera la storia del Satyricon come «une tranche decoupée dans la vif de la vie romaine» [35], aggiungendo addirittura che: «Pétrone ètait un observateur perspicace, un delicat analyste, un merveilleux peintre: tranquillement sans parti pris, sans haine, il décrivait la vie journalière de Rome, racontait dans les alertes petits chapitres du Satyricon, le moeurs de son epoque.» La realtà petroniana, al contrario, sebbene conservi una parvenza di adesione al dato concreto, è manipolata, deformata, trascesa, sconfinando in una proiezione letteraria di idee autoriali. Gli oggetti del quotidiano (i gioielli, gli abiti, le sontuose pietanze della Cena) non hanno un valore descrittivo o informativo, ma piuttosto simbolico e metonimico. I monili ad esempio non sono descritti qualitativamente, ma quantitativamente (i gioielli di Fortunata vengono valutati a peso -sei libbre e mezzo – ma non è dato sapere al lettore la natura mineralogica o l’aspetto estetico dei massicci bracciali). Lo spettatore assiste ad un progressivo ispessimento espressionistico dei contorni, anche attraverso il gioco del continuo cambiamento di focalizzazione e di prospettiva narrativa, che provoca una distorsione e rifrazione innaturale dell’immagine. Lo scopo di Petronio – esplicito soprattutto nello sconcio simposio trimalchionesco – è quello di forzare fino alla deformazione la caratterizzazione dei suoi personaggi, in modo da instillare nel lettore una sensazione di “denigrazione del reale” [36]. Questo meccanismo di alienazione (a tratti snobistica) inoculata nel lettore ne guida il giudizio e l’analisi, ed è strettamente connesso al tipo di destinatario ideale cui Petronio si rivolge: l’uomo comune, incapace di cogliere quest’ardita impalcatura di rimandi allusivi, avrebbe potuto fraintenderne il messaggio (come spesso ancora avviene), giudicandolo un divertissement della letteratura di consumo, piacevole ma superficiale. L’autore del Satyricon presuppone invece un pubblico aristocratico, dotato di un’intelligenza brillante e di vasta (anche se non necessariamente spropositata) cultura, ma soprattutto un auditorio consapevole del proprio inevitabile declino storico, che abbia già espresso preventivamente un giudizio su quel mondo di colorati ma effimeri parvenu, senza avere dunque il bisogno di chiarificazioni propedeutiche da parte dell’autore.
Concludendo con Erich Auerbach:
Petronio ci mostra il limite estremo a cui sia arrivato il realismo antico. (…) Si può dalla sua opera anche conoscere quello che tale realismo non poteva o non voleva dare. La Cena è un’opera di carattere puramente comico. I Personaggi che vi compaiono sono, sia singolarmente che nei legami con l’insieme, mantenuti coscientemente e secondo un criterio unitario nel gradino stilistico più basso, tanto per la lingua quanto per il modo in cui sono visti; a ciò si collega necessariamente il fatto che tutto quello che, psicologicamente o sociologicamente, accenna a sviluppi seri o addirittura tragici, deve essere tenuto lontano, ché altrimenti distruggerebbe lo stile sotto un peso eccessivo. (…) Il vecchio Grandet o Fedor Karamazov non sono caricature come Trimalchione, bensì realtà da prendere sul serio, avvolte in tragici intrichi, tragici perfino essi stessi, benché anche grotteschi. [37]
Il motivo di questa inattuabilità di fondo? La risposta risiede sempre nell’insuperabile argomentazione di Mimesis:
Per la letteratura realistica antica, la società non esiste come problema storico, ma tutt’al più come problema moralistico, e inoltre il moralismo si rivolge più all’individuo che alla società. (…) Se la letteratura antica non poteva rappresentare la vita quotidiana né seriamente né problematicamente e nemmeno nel suo sfondo storico, ma solamente nello stile umile, comico o tutt’al più idilliaco, senza storia e statico, si ha dunque non soltanto un limite al suo realismo, bensì anche, e soprattutto, un limite alla sua coscienza storica. [38]
Anche la ricerca di un approccio (apparentemente) documentaristico di Pasolini sfocia in un realismo fittizio: l’universo dei Ragazzi di vita, dei sottoproletari delle borgate romane cantati nelle Ceneri di Gramsci non è riconducibile ad una mera catalogazione fotografica, ad istantanee di una miseria periferica e suburbana. Pasolini attribuisce a questo microcosmo di povertà un’aura mitica; i sudici e verminosi abitanti della periferia, prodotti dal caotico processo di accumulazione urbanistica, diventano eroi incorrotti dell’immaginario pasoliniano, in una sorta di romanticismo proletario alla ricerca di un primitivismo originario. In Petrolio la differenza tra borghesi e sottoproletari è, prima di tutto, un’antitesi fisica, che si realizza nel corpo e nella gestione del corpo. I primi portano le stigmate della loro ripugnante volgarità di classe nell’amalgama disarmonico di quei nasi, quei grassi, quelle rughe, quelle collottole, quelle bocche, quei rossori, quei pallori, quei sudori [39]. La cifra della rispondenza tra fisico e ceto è una costante reiterata nella trama del romanzo; ne riporto alcuni esempi per scrupolo divulgativo:
Gli Dei-Padroni appartengono visibilmente alla razza borghese, magari con origini nobiliari ecc. ecc. Hanno i nasi duri, i menti melensi, le occhiaie colpevoli dei burocrati, dei professionisti, dei commercianti o degli industriali; la loro aggressività tutta sociale (perché fisicamente, anche se atletici, sono dei deboli) si mescola con il senso di colpa che l’ha generata. [40]
Alle origini di ogni figura della borghesia italiana c’è qualcosa di vignettistico, lo si sa bene. Ebbene, questo ingegner Giovanni xxx era effettivamente come voi lo immaginate: milanese di residenza, varesotto di nascita, ligure di abbronzatura, con un che di romano negli occhi e dei capelli neri un po’ brizzolati (brizzolatura che, chissà perché, aveva qualcosa di empio, di imperdonabile, tanto era inconsapevolmente volgare). [41]
(…) quell’offerta del corpo di piccolo borghese intellettuale, incapace di offendere e destinato a essere imbelle, a venire punito. Tutto ciò di cui si glorificava come di un privilegio non ostentato – la sua pelle bianca, la stoffa del vestito – quei calzini che si intravedevano sotto i pantaloni tirati su nel polpaccio – era adesso oggetto di pietà un po’ ripugnante, e basta. Neanche l’assenza di vita bastava a cancellare le stimmate della nascita: anzi, le esponeva in modo ancor più brutale. [42]
I corpi dei poveri, dei sottomessi, dei lavoratori possiedono invece una bellezza grezza, nonostante (e forse a causa) delle irregolarità ed impurità del volto, anti-classico e per lo più spiccatamente meridionale. Anche a questo proposito gli esempi riscontrabili nel testo sarebbero sconfinati; mi limiterò a qualche citazione rappresentativa:
(Salvatore Dulcimascolo) aveva la fronte stretta, i lineamenti irregolari, un po’ animali, quasi sgradevoli e nello stesso tempo pieni della bellezza della salute e della sessualità ereditate come un bene; il naso un po’ adunco, la bocca troppo carnosa, le guance tirate sugli zigomi; il corpo abbastanza lungo per un meridionale; la sua forza era quella felina e quadrata del ragazzo bruno, che sarà divorato, da vecchio, dalla magrezza, o deturpato, più probabilmente, dalla pinguedine dei poveri. [43]
I suoi due occhi neri che parevano bistrati tanto il loro obliquo disegno era inciso nell’orbita e tanto folte erano le sopracciglia, splendevano di un’allegria senza ragione, come quella degli animali. [44]
Nella madre uguale che nelle figlie, tutte pronte ad accettare i sacrifici imposti dalla natura e dal potere., confusi tra loro non per errore ideologico, bensì per realismo. Un realismo non pensato, bensì vissuto nei corpi, nei dolci occhi, nei sorrisi di gente povera, nei capelli meravigliosi ma umili come vegetazione o pelame di bestia, nei lineamenti appena dirozzati, un po’ camusi, ma uguali a tutti quelli coloro che assomigliano ai padri e alle madri belli e senza difetti. [45]
Il corpo diventa un contenitore simbolico di istanze proprie della casta di appartenenza, in cui Pasolini comprime e riassume le sue ideologie e mitologie personali (d’altronde l’autore ci aveva avvertito all’inizio del romanzo che la psicologia «sarebbe stata sostituita di peso dall’ideologia»). I suoi personaggi vivono un’esistenza leggendaria, in una programmatica trasfigurazione della periferia degradata in uno scenario epico; la creazione dell’intellettualissimo Pasolini deve essere contemplata come un presepe arcaico, in quanto ogni aiuto e sprone alla civilizzazione sarebbe un atto di contaminazione e di violazione di un luogo sacro.
Lo sguardo mistificatore di Pasolini nega il realismo non soltanto ai lettori ma anche a se stesso; la realtà subisce un processo di sublimazione e di forzatura delle dinamiche esistenti di segno contrario rispetto a Petronio, ma il cui risultato di copertura e scomposizione faziosa del reale è il medesimo: una trappola in cui i lettori (e i critici) sprovveduti non hanno ancora smesso di cadere.
Una somiglianza solo apparente: il tema erotico
Ad una prima lettura dei due romanzi, la somiglianza più vistosamente esplicita tra il Satyricon e Petrolio sembrerebbe risiedere nel copioso serbatoio di pagine erotiche. Approssimazione del tutto erronea e gratuita, retaggio di una lettura sommaria e (a voler essere generosi) frettolosa; la trattazione dell’eros costituisce, a mio parere, l’antitesi più spiccata tra i due romanzi. In Petronio l’oscenità è una delle varianti strumentali del medesimo sentimento di decadenza epocale su cui è intessuto l’intero romanzo; una delle tante sfrenate corse al profitto (in questo caso corporeo) che caratterizzano la torbida età Neroniana. Inoltre, come ricorda Luca Canali, nella sua Introduzione a Petronio:
Di quanti autori latini trattano le cose del sesso, anche nelle sue manifestazioni più scabrose e trasgressive, Petronio è linguisticamente il più casto: egli non ama il turpiloquio, anzi ne rifugge programmaticamente. Non ho fatto una statistica, ma sono certo di non sbagliarmi affermando che mai posizione dell’eros o semplice dettaglio fisiologico sono mai nominati con il nome corrente, sempre volgare. Tutto ciò Petronio indica con ingegnose metafore: non certo per ipocrisia né tanto meno per reticenza (…) bensì per una vera e propria ripugnanza per il raggelante luogo comune triviale. Sia Catullo, sia Persio, sia Giovenale e sia Marziale non solo fanno largo uso, ma forse esibiscono con qualche compiacimento un turpiloquio erotico alquanto stereotipato. L’erotismo nel Satyricon è spesso puro gioco: non è mai compiacimento o desiderio di denuncia o di scandalo. Senza scandalo, ma senza partecipazione, Petronio registra in perfetta castità di stile la disfatta di ogni legge morale. [46]
Petronio dunque, a differenza di quanto i riassunti antologici potrebbero far supporre, è un autore morigerato, perennemente controllato e casto nell’espressione di contenuti amatori. L’eros è da lui vissuto e descritto come una forza propulsiva e vivificatrice, avulsa dalle sovrastrutture civili del matrimonio, della fedeltà incondizionata e dal maschilistico galateo romano (propugnatore di un’ideale femminile di aggraziata passività). E’ un’entità ctonia, imbevuta di una violenta carica dionisiaca che precede la collettività e le norme di connivenza sociale. Un genuino culto per il corpo, ancora privo di una sublimazione intellettuale o artistica, estraneo alle categorie di moralità e di utilità; l’amore, in Petronio, non è bello o positivo, non ha ancora subito il processo di zuccherificazione romantica o di fobica negazione religiosa. E’ semplicemente, e incondizionatamente, natura.
Parallelamente, nei passi di più marcata licenziosità contenutistica (mi riferisco in modo particolare al penultimo capitolo del Satyricon, quando viene introdotta al lettore l’heredipeta Filomela [47], che addirittura arriva a prostituire i due figli), Petronio utilizza il corpo (e il suo stato deteriore) come sintomo di una più universale decadenza storica ed epocale. Il pervertimento delle pulsioni individuali è lo specchio di un periodo storico torbido quale fu l’età neroniana; la degradazione della provincia è spia della corruzione ammorbante della capitale, in un “mal di decadenza” che appartiene alla corte imperiale, al nuovo amalgama di forze sociali emergenti e, in un pessimismo più radicale (e moderno) all’intera umanità.
In Pasolini invece il linguaggio erotico si carica di un’aggressività e di una trivialità che in alcune pagine sfidano i limiti di sopportazione e auto-censura borghesi (contrassegno che lo accomuna all’ultima produzione cinematografica pasoliniana, da I racconti di Canterbury a Il fiore delle Mille e una notte, dal Decameron a (soprattutto) Salò o le 120 giornate di Sodoma). Al di là dell’intento (di ascendenza avanguardistica) di épater les bourgeois, per Pasolini il corpo diventa veicolo di denuncia sociale. Riporto parte dell’intervista che seguì la contestata uscita di Salò:
Nel mio film c’è molto sesso, ma (…) ha una funzione molto precisa, quella di rappresentare cosa fa il potere del corpo umano: l’annullamento della personalità degli altri, dell’altro. […] il sesso ha una grande funzione metaforica […] metafora del rapporto tra potere e coloro che ad esso sono sottoposti […] C’è una frase in particolare che faccio dire ad uno dei personaggi del mio film: “là dove tutto è proibito si ha la possibilità reale di fare tutto, dove è permesso solo qualcosa si può fare solo quel qualcosa…”
L’erotico diventa quindi scandaglio e specchio del potere, che vanifica le istanze del corpo veicolandole a sovrastrutture alienanti che stimolano e provocano, come conseguenza estrema, uno stato di perversione latente. Allo snaturamento delle pulsioni fisiologiche da parte della griglia civile, Pasolini oppone un vitalismo esasperato, che non si riduce a mera smania individuale, ma che afferma il bisogno di esperienze totalizzanti a livello collettivo, in una revisione radicale dell’etica e del vivere associato. L’illusoria patina di libertà democratica garantita dal sistema borghese, in realtà, annichilisce e vanifica le istanze del corpo, costringendo l’individuo a far defluire le emozioni in pre-ordinati canali di sfogo.
Parallelamente a questo utilizzo ideologico del corpo, il rapporto di Pasolini è anche veicolato alla sua omosessualità, vissuta spesso nei termini di colpa e estraneità; per l’autore il soggetto omosessuale inevitabilmente vive all’esterno della società, senza possibilità di integrazione all’interno del tessuto civile. Forse anche da questo (ma siamo nei limiti dell’azzardo critico) nasce la sua ossessiva ricerca dell’Alterità, di una diversità che possa essere compatibile con il proprio ruolo di ostracizzato. Tutti i personaggi che animano l’immaginario di Pasolini sono infatti la somma delle identità che il soggetto vorrebbe essere ma che consapevolmente rifiuta, come se volesse gelosamente custodire il proprio io mancante, accettando lo statuto inesorabile della propria incompiutezza, che non può e non vuole esistere ufficializzata nell’ambito della società borghese. L’eros pasoliniano in questa accezione diventa l’unico e disperato tentativo di contatto e compenetrazione con il mondo (spesso infatti Pasolini ripeteva che amare equivale a conoscere), in un’estrema prospettiva di evasione da un senso di colpa di cui l’autore sembrò volersi punire con una asocialità forzata.
Bibliografia
E. AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino 1956, primo volume
L. CANALI, Introduzione a Petronio, Bompiani, Milano 1990
L. CANALI, L’erotico e il grottesco nel Satyricon, Laterza, Bari 1986
L. CANALI, Neutralità e vittoria di Petronio, in Petronio, Satyricon, a cura di Ugo Dettore, Rizzoli, Milano 1981
L. CICU, Donne petroniane. Personaggi femminili e tecniche di racconto del Satyricon di Petronio, Roma 1992
G. B. CONTE, L’autore nascosto. Un’interpretazione del Satyricon, Il Mulino, Bologna 1997
F. FELLINI, Fellini Satyricon, a cura di D. Zanelli, Cappelli, Bologna 1969
F. FELLINI, Un regista a Cinecittà, Mondadori, Milano, 1988
R. GUERRINI, Petronio e Céline (ovvero la denigrazione del reale), “Reale Istituto Lombardo” 1973
K.J. HUYSMANS, A’ rebours, Parigi 1884
P. P. PASOLINI, Petrolio, Edizione Mondadori, “Oscar scrittori moderni”, Torino 2005
PETRONIO, Satyricon, traduzione e note a cura di Andrea Aragosti, Grandi classici greci e latini BUR, Bergamo 2009
J.P. SARTRE, Le parole, Edizione Il Saggiatore (tascabili), collana dei maestri dell’ ‘900.
E. SANGUINETI, La ballata del quotidiano, interviste di Giuliano Galletta (1994-2009), Genova 2012
G. VERGA, da Vita dei campi, Novelle, Rizzoli, Milano 1981.
P. ZANKER, Augusto e il potere delle immagini, Torino 1989.
[1] P.P.Pasolini, Petrolio, Milano 2005, Edizione Mondadori “Oscar scrittori moderni”, pag. 9
[2] P.P.Pasolini, lettera ad Alberto Moravia in calce a Petrolio, Edizione Mondadori, pag. 579-580
[3] Jean-Paul Sartre, Le parole, Edizione Il Saggiatore (tascabili), collana dei maestri dell’ 900, pag. 43
[4] P.P.Pasolini, Petrolio, Idem, pag. 448
[5] P.P.Pasolini, Petrolio, Idem, pag. 446
[6] P.P.Pasolini, Petrolio, Idem, pag. 13
[7] P.P.Pasolini, Petrolio, Idem, pag. 193
[8] Pozzuoli? Napoli? Una città di mera fantasia? La profusione dilagante di saggi ed articoli di geologi, critici letterari e storici dell’arte dimostra quanto sia concettosa e pedantesca l’insopprimibile querelle. Il dinamismo e la vivacità coloristica della descrizione non risentono in alcun modo, a mio parere, della determinazione effettiva di un paio di (indimostrabili) coordinate spaziali.
[9] Gian Biagio Conte, L’autore nascosto. Un’interpretazione del Satyricon, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 40-42.
[10] Gian Biagio Conte, L’autore nascosto. Un’interpretazione del Satyricon, Il Mulino, Bologna 1997
[11] Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino 1956, primo volume.
[12] A. Barbieri, nella sua Poetica Petroniana (Roma 1983) è del parere che Petronio “ha inteso colpire il moralismo e con ciò indicare una morale diversa fino a divenire opposta: una morale dell’immoralità”. Non condivido questa prospettiva (per creare una tale morale il Satyricon avrebbe dovuto presentare una dose assai più cospicua di immoralità) ma è senza dubbio una tesi affascinante.
[13] Petronio, Satyricon, traduzione e note a cura di Andrea Aragosti, Grandi classici greci e latini BUR, Bergamo 2009, p. 229
[14] Petronio, Satyricon, Idem, p. 233.
[15] Petronio, Satyricon, Idem, p. 259.
[16] Luca Canali, Introduzione a Petronio, Bompiani, Milano 1990, pp. 10-11.
[17] Giovanni Verga, da Vita dei campi, Novelle, Rizzoli, Milano 1981.
[18] Vitruvio raccomandava addirittura di costruire le scalinate dei templi con un numero dispari di gradini, in modo da garantire l’inizio e la fine del percorso con il piede destro, evitando così il rischio di catalizzare sul malcapitato fedele distratto una sorte nefasta.
[19] Il gallo era contemporaneamente simbolo di luce e di malattia; era infatti sacro al dio della medicina Asclepio, a cui veniva sacrificato in caso di avvenuta guarigione, e a Persefone, dea dell’Ade.
[20] Luca Canali, L’erotico e il grottesco nel Satyricon, Laterza, Bari 1986.
[21] Al termine della narrazione, Trimalchione anzi chiosa lo sbigottimento generale affermando che “Scio Niceronem nihil nugarum narrare: immo certus est et minime linguosus”.
[22] Petronio, Satyricon, Idem, p. 269.
[23] Non sono d’accordo con la supposizione postulata da Bȕcheler circa una lacuna immediatamente successiva alla novella sopra citata, motivata dal fatto che il raccordo con il segmento successivo sembri allo studioso brusco ed improvviso. A mio parere, proprio quest’effetto di dissonanza anti-armonica era ricercato da Petronio, per squalificare e screditare goliardicamente la scarsa attenzione e la gretta fruizione della “letteratura” (sebbene di tipo conviviale e popolaresco) da parte dei convitati, subito disposti a gettarsi nel loro ambiente culturale prediletto: la comicità de-sublimata.
[24] Petronio, Satyricon, Idem, p. 271.
[25] G.B. Conte, L’autore nascosto. Un’interpretazione del Satyricon, Il Mulino, Bologna 1997, p. 42
[26] Petronio, Satyricon, Idem, p. 331.
[27] Per l’approfondimento della tematica si veda il saggio di Paul Zanker, Augusto e il potere delle immagini (nella sezione dedicata al Programma di rinnovamento culturale, in Toga e Stola).
[28] Petronio, Satyricon, Idem, p. 413.
[29] P.P.Pasolini, Petrolio,Oscar Mondadori, Torino 2005, pp. 137- 146.
[30] P.P.Pasolini, Petrolio, Idem, p. 133.
[31] Il mito delle Argonautiche viene riletto in chiave fortemente anticapitalista e anticolonialista, in cui il vello d’oro, motore e causa primigenia del conflitto, viene assimilato al petrolio, l’oro nero della nostra società.
[32] Riporto la schematizzazione dello stesso Pasolini, alle pp. 170-171 di Petrolio: «(…) in una riunione intellettuale si raccontano e si commentano le seguenti storie: – L’acquisto di uno schiavo (a Khartoum) andata e ritorno (andata schiavista, ritorno osmosi tra le due culture attraverso il sesso) – La storia di una famiglia indiana i cui membri muoiono a uno a uno di fame – La distruzione della popolazione di Bihar (i Bianchi cercano di distruggere i 30 o 40 milioni di affamati e colerosi, dapprima buttando dall’alto pacchi di viveri avvelenati, poi addirittura bombardando a tappeto città e villaggi. Ma la popolazione non muore: appena uccisi, massacrati, risuscitano. – Lo scambio di esperienze tra un giovane israeliano e un giovane arabo (tutti e due muoiono in una battaglia sul Golan e ognuno dei due rinasce nel corpo dell’altro, vivendone le esperienze culturali: l’arabo vive l’industrializzazione e il cosmopolitismo industriale di Israele, l’israeliano vive l’esistenza preindustriale, contadina, magica di un villaggio del Libano povero. La storia finisce con i due funerali veri. – Tre storie di Botole: in Marocco in fondo alla botola mondo; uguale per merito di un Re (morente, appestato), in Nigeria un mondo degradato, con la vecchia in gabbia, in Algeria il mondo di Parigi, in cui il ragazzo diventa uno scopino. veramente degradato e servo – La rifondazione della religione dei Kota – Una storia che si svolge nel momento in cui la Sicilia è riromanizzata (Arabi e Siciliani) – Storia di un emigrante greco o andaluso in Germania, visto nei primi Anni Sessanta alle soglie del ’68 (ancora assolutamente imprevisto).»
[33] Tristram Shandy di Lawrence Sterne?
[34] Ricordano quasi le buone cose di pessimo gusto, descritte con squisita ironia da Guido Gozzano.
[35] K.J. Huysmans, A’ rebours, Parigi 1884.
[36] R. Guerrini, Petronio e Céline (ovvero la denigrazione del reale), “Reale Istituto Lombardo” 1973.
[37] E. Auerbach, Mimesis, I volume, Torino 1956, pp. 37-38.
[38] E. Auerbach, Mimesis, I volume, Torino 1956, pp. 38-40.
[39] P.P. Pasolini, Petrolio, Idem, pag. 260.
[40] Ivi, pag. 269.
[41] Ivi, pag. 460.
[42] Ivi, pag. 12.
[43] Ivi, pag. 275.
[44] Ivi, pag. 188.
[45] Ivi, pag. 266.
[46] Luca Canali, da Introduzione a Petronio, Satyricon, a cura di L.C. , Bompiani, Milano 1990, pp. 14-15.
[47] La scelta di questo nome non è casuale: Petronio ha attinto dal repertorio mitico la vicenda di Filomela, Procne e Tereo, anche se, a prima vista, parrebbe un collegamento iperbolico e non giustificato. In realtà, come ha brillantemente osservato Luciano Cicu nel suo saggio Donne petroniane. Personaggi e tecniche di racconto nel Satyricon di Petronio, la matrona di Crotone eredita i caratteri costitutivi dei tre personaggi: da Filomela l’ingegnosità, da Tereo la doppiezza, da Procne la determinazione contro natura ad utilizzare i figli per assecondare le vendette o le passioni personali.